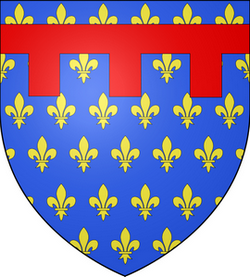Documenti e dati
1. Nel periodo angioìno, sopra il territorio già
precedentemente detto Tresàno, nasce, intorno ad
una o più ville signorili, il “loco qui dicitur
Barra de’ Coczi”.
Il grande “Dizionario geografico ragionato del
Regno di Napoli”, compilato con operosa passione
da Lorenzo Giustiniani ed uscito a stampa nel
1797, riporta, alla voce “Barra”, la
documentazione fondamentale esistente in
materia:
2. “Di questo casale (Barra) se ne fa
menzione nelle carte Angioine, e dalle medesime
si rileva, che appellavasi Barra de Cozi, de li
Cocze, de Coczi, e de Coczis, e che era nel
territorio detto Trasano, o Tresani.
3. In un diploma dunque di Carlo II d’Angiò del
1294, col quale concedè a Giovanni de Blasio
parecchi poderi, tra quelli vi fu petia terre
una arbustata sita in loco qui dicitur Barra de
Coczis de territorio Tresani (Regest.
sig.1294 M.fol.67 at.).
4. In un altro della Regina Giovanna I, col
quale concedè a Catarina Galasso domicelle et
fideli nostre alcuni altri poderi, si
legge: petias terre cum domibus et fundo
sitas in pertinentiis Neapolis in loco
ubi dicitur la Barra deli Cocze (Regest.1345
B.fol.133).
5. A questi due diplomi, accennati pure dal
nostro Chiarito (nel “Comento sulla Costituzione
di Federico II” part.3, cap.2, pag.146), io
aggiungo il terzo del suddivisato Carlo II, il
quale tra le molte donazioni fatte a’ PP.
Predicatori per la costruzione della chiesa di
S. Domenico maggiore di Napoli, vi si legge
questa: Item pecia una terre arbustata sita
in loco qui dicitur Barra de Coczi de territorio
tresano coniuncto ab una parte terre
S.Gregorio ecc. (Regest.Caroli II sig.1302
E.fol.6). Questo diploma porta la data del dì 24
dicembre 1301, XV ind. e XVII di esso Carlo.”
6. Il Cozzolino menziona inoltre “un altro
precedente diploma di Carlo II, quando era
ancora principe ereditario (Registro segnato
1324 A. fol. 108)” nel quale si parla di
quondam petiam terre in Civitate Neapolis
foris fluveum in loco ubi Gignonum et Villa de
Coczis dicitur positam.
7. Va però notato che, in nessuno dei documenti
citati, Barra de Coczi è definita “Casale”: essa
è semplicemente un “loco qui dicitur...”;
occorrerà attendere il successivo periodo
aragonese per trovarla documentata come
“Casale”.
8. “Invece, in un cedolare di anno incerto, ma
indubbiamente di epoca angioìna, troviamo
l’elenco di tutti i Casali esistenti in quel
tempo: accanto ai nomi dei Casali è notata la
rispettiva tassa ad essi imposta, ed i nomi dei
collettori deputati alla riscossione”
.
L’elenco, riportato dal Chiarito
, comprende 43 Casali e,
tra essi, troviamo:
·
Casavaleria (tassato per 2 once; il “collector”
incaricato di esigere le tasse era un certo
Stefanus Azapotus)
·
Sirinum (tassato solo per tari X e grana XVIII;
il collettore si chiamava Benedictus de Aprano
)
·
Tertium (tassato per 2 once, tari V e grana VIII;
collettore: Giovanni Sicardo il vecchio)
Non troviamo invece Barra, che non era
considerata ancora, evidentemente, un Casale.
9. Dal suddetto elenco, è possibile anche
ricavare approssimativamente la popolazione dei
Casali riportati.
Occorre considerare che la moneta adoperata era
l’ “oncia” e che ogni oncia si divideva in
quattro “augustali”. Le tasse, secondo il
Capasso
, si imponevano in ragione
di mezzo augustale per ogni “fuoco”, dove per
“fuoco” si intendeva il “nucleo familiare”,
corrispondente a cinque o sei persone circa.
10. Quindi, Casavaleria, che era tassato per due
once, doveva avere una popolazione formata da
sedici fuochi (sedici famiglie), cioè circa 96
abitanti!
Bisogna però considerare che i nobili, gli
ecclesiastici e gli eventuali studenti erano per
legge esenti dalle tasse, e quindi il numero
dovrebbe essere leggermente più alto; d’altra
parte, ovviamente, non tutti i nuclei familiari
erano composti da sei persone (forse le famiglie
erano più numerose, ma potevano esserlo anche di
meno), per cui si può solo concludere che la
popolazione di Casavaleria era
approssimativamente, in epoca angioina, intorno
ai 100 abitanti.
11. Per avere un termine di paragone, si
consideri che i Casali più popolosi, riportati
nell’elenco suddetto, sono Turris Octava,
Sanctus Anellus de Cambrano e Posilipum, che
pagavano sei once ed avevano quindi, più o meno,
300 abitanti.
12. Casavaleria era dunque abbastanza
importante, mentre il povero Sirinum non
raggiungeva nemmeno un’ oncia di tassazione e
quindi doveva avere sicuramente meno di 48
abitanti (in pratica, erano circa sei o
sette famiglie)!
13. Per quanto piccolo, Sirinum non era tuttavia
il Casale minore, che era invece (all’occhiuto
sistema fiscale angioino non sfuggiva davvero
nulla...) il microscopico Casale di Pollanella,
che pagava un solo tareno (praticamente, doveva
essere una sola famiglia) seguito a ruota da S.
Ciprianus, che ne pagava due!
14. Complessivamente, la città di Napoli ed i
suoi Casali pagavano annualmente 692 once d’oro,
di cui 506 a carico della città e 186 a carico
dei Casali; se ne può dedurre che la popolazione
di Napoli era, in epoca angioina, di circa 25-30
mila persone, mentre quella complessiva dei
Casali era di circa 9-10 mila.
15. Ci chiediamo ora: dal punto di vista della
popolazione dei Casali, quali furono i
cambiamenti più significativi nel passaggio
dalla dinastia sveva a quella angioina? e come
mai proprio in questo periodo inizia a formarsi
la Barra de’ Coczis? e perchè questo nome? e che
ne era, nel frattempo, dei già esistenti Casali
di Sirinum e di Casavaleria?
|
Clemente IV incorona Carlo I d'Angiò,
Ginevra, Galleria Pubblica e Universitaria |
La politica fiscale: suoi effetti
16. Per la povera popolazione dei Casali “foris
flubeum”, il cambiamento più avvertito,
soprattutto all’inizio, fu senza dubbio proprio
il vessatorio aumento della tassazione.
17. Abbiamo già visto come la “collecta” per
Napoli ed i suoi Casali passò, quasi
all’improvviso, da 170 a 692 once d’oro ed
inoltre, da occasionale che era, divenne
annuale.
Vi erano poi, naturalmente, la gabella sul pane,
quelle sulla farina, sul vino, sul pesce, sul
bestiame, sui cavalli, sul sale, sulla
vendemmia, etc. etc.
18. Venne altresì introdotto il cosiddetto “quartatico”,
cioè una specie di pedaggio che si doveva pagare
ogni qual volta si entrava o usciva dalla città
trasportando delle merci; per il pagamento di
questo pedaggio, furono poste delle sbarre nei
principali punti di accesso alla città e, fra
queste, vi fu la sbarra sul vecchio “ponte delle
paludi” (in epoca angioina detto “ponte
Guizzardo”) che era la via per la quale i nostri
contadini di “Foris flubeum” portavano in
Napoli, per la vendita, i frutti della terra.
Nessuna meraviglia, naturalmente, per il fatto
che il “quartatico” (che il popolo, però, disse
subito “la gabella delle sbarre”) risultasse
particolarmente odioso ai contadini dei Casali!
19. Si cominciò anche a manomettere gli antichi
“usi civici”, instaurando con la forza nuove
abitudini che, essendo contrarie alla
tradizione, furono giustamente dette dal popolo
“ab-usi”: le terre del demanio non erano più
sostanzialmente libere, come sotto gli Svevi, ma
vigilate da appositi “mastri massari” e “mastri
forestari”, che pretendevano imposte sul diritto
di raccogliere la legna, raccogliere erba
o frasche, in alcuni casi persino sulle sorgenti
o i corsi d’acqua...
20. Particolarmente infausta fu poi
l’introduzione della tassa aggiuntiva di tre
tareni a testa che, da allora, dovettero versare
annualmente al re tutti coloro che risiedevano
su terre demaniali: questo diede certamente il
colpo di grazia alla condizione di relativo
privilegio di cui avevano goduto, in epoca
sveva, gli “uomini di demanio” rispetto a quelli
che stavano su terre infeudate.
21. Questa pesante politica fiscale determinò,
da una parte, un drastico peggioramento delle
condizioni di vita dei contadini e delle
popolazioni più povere ma, dall’altra, anche
l’emergere di un nuovo ceto di funzionari che si
arricchiva proprio grazie ad essa.
22. Infatti, il sistema fiscale angioino era
tanto implacabile quanto macchinoso: la “Magna
Curia” stabiliva la cifra da riscuotere per
ognuna delle dodici province (Abruzzo citra ed
ultra, Molise, Capitanata, Terra di lavoro,
Principato citra ed ultra, Basilicata, Terra di
Bari, Terra di Otranto, Calabria citra ed ultra)
e, all’interno delle province, per ognuna delle
località; dopo di che, i cosiddetti “tassatori”
dovevano ripartire l’imposta fra i vari
contribuenti locali; entravano poi in azione i
cosiddetti “collettori” che dovevano
materialmente riscuotere l’imposta stessa,
dietro compenso del 2%; i collettori versavano
quindi l’importo all’ ”esecutore” e quest’ultimo
al “giustiziere”, che era in pratica il massimo
responsabile della Provincia.
23. Vi erano poi altri funzionari per
l’amministrazione delle rendite demaniali, dei
“monopòli” della corte, per la riscossione dei
diritti di registrazione e di sigillo reale,
delle pene pecuniarie eventualmente inflitte,
per la riscossione della “gabella delle sbarre”
e delle gabelle sulle singole merci, etc. ed
ognuno di questi funzionari poteva a sua volta
assumere temporaneamente delle persone da lui
dipendenti.
24. Questo ceto burocratico, distribuito sul
territorio, si accrebbe quantitativamente
rispetto al periodo svevo ed ebbe anche ovvie
opportunità di accrescere le proprie fortune
finanziarie...
|
 |
Carlo I d'Angiò, statua di Palazzo Reale Napoli |
I “re-vocàti” e Casavaleria
25. Il sistema fiscale sopra descritto provocò,
tra l’altro, il fenomeno dei cosiddetti “revocàti”.
26. “I revocàti eran coloro che, per esimersi
dalle fiscali imposizioni e collette,
abbandonavano i loro paesi, e ciò in danno degli
altri cittadini, i cui pesi venivano così ad
essere aumentati: quindi, erano richiamati ai
loro paesi, ed erano perciò detti re-vocàti”
.
27. In sostanza, dato che la tassa, una volta
deciso l’importo, doveva comunque essere pagata
dall’intera comunità del Casale, la fuga di
alcuni finiva con l’aggravare il peso sui
rimanenti.
Pertanto, la “Università degli uomini dei Casali
di Napoli” presentò ricorso contro i fuggiaschi
e la Magna Curia, investita del caso, ordinò che
questi dovessero essere ricondotti con la forza
al loro paese di origine o comunque che vi si
dovessero recare per pagare la dovuta imposta
.
28. La carta, contenente la decisione della
Magna Curia in merito al ricorso, viene detta
“Carta dei revocati” ed è del 1268: quindi,
proprio all’inizio del periodo angioino (e del
nuovo sistema di tassazione).
La “Carta dei revocati” è importante non solo
perchè ci permette di verificare la pesante
efficacia del sistema fiscale angioino, ma anche
perchè contiene un elenco dei Casali nei quali
si era verificato il fenomeno.
Poichè la carta è del 1268, i Casali citati (che
sono in numero di 33) esistevano senz’altro già
nel periodo svevo ed è questo l’unico elenco che
possediamo relativo a tale periodo.
29. La stima è certamente solo approssimativa,
dal momento che non in tutti i Casali si
trovavano revocati, nè d’altronde è sicuro che
tutti i Casali interessati abbiano poi
presentato il ricorso.
30. In ogni caso, per quanto più direttamente ci
riguarda, nella Carta è menzionato, fra gli
altri revocati, un certo Johannes Pinensis
(un discendente, forse, di quel Iohannis de
Pinum, il cui fondo si trovava in loco
qui nominatur Casabalera, nel 1135?) al
quale viene ingiunto di pagare la tassa dovuta
in casali Sancti Martini.
Poichè è ben documentata l’esistenza di una
chiesetta dedicata a S. Martino lungo la strada
che va da S. Maria del Pozzo a S. Giorgio a
Cremano, possiamo così essere certi, secondo il
P. Alagi, che l’antica Casavaleria era composta
da due agglomerati di case (uno intorno alla
chiesetta di S. Maria del Pozzo e l’altro
intorno alla chiesetta di S. Martino), per cui
il Casale veniva indicato sia come “Casavaleria”
che come “Casale di S. Martino”
.
|
Giovanna I
(immagine tratta da Bastian
Biancardi "Le vite dei re di Napoli" Venezia 1737) |
La disputa fra “antiqui
scomparati” e “de novo redempti”
31. Al pagamento del tributo personale rimaneva
inchiodata, nei Casali, anche un’altra categoria
di persone, i cosiddetti scomparàti (o
ex-comparàti).
Essi erano
, semplicemente, dei
servi riscattati, cioè discendenti di
uomini, anticamente servi, che in seguito
avevano ottenuto la libertà dai loro padroni, ed
“appartenevano” quindi solo al demanio del re:
in quanto tali, erano comunque obbligati al
pagamento del tributo personale alla corte.
32. Se non che, si venne a determinare una
odiosa discriminazione all’interno della
categoria degli “scomparati”, perchè gli
“antiqui scomparati” dovevano continuare a
pagare anche le tasse dovute al loro antico
signore, mentre i “de novo redempti” pagavano
solo la tassa demaniale.
33. Ne seguirono continue e penose dispute fra
le due categorie nonché fra queste ed i
rispettivi Casali di appartenenza: dispute che,
in definitiva, andarono comunque a svantaggio
delle popolazioni ed a vantaggio del fisco,
regale o baronale che fosse.
 |
|
Roberto
(immagine tratta da Storia
d'Italia - Fratelli Fabbri Editori, 1965) |
I “briganti”
34. Ulteriore effetto del vessatorio sistema
fiscale angioino fu l’inizio (o solo un
ulteriore incremento?), in quest’ epoca, del
fenomeno del “brigantaggio”.
Per la precisione, il termine “brigante”,
essendo stato importato dai francesi solo
all’inizio dell’Ottocento, non era quello
adoperato allora: si diceva, invece,
genericamente “bandito”, “fuorilegge”,
“malandrino”, “malvivente”, etc.
35. Al di là del nome, comunque, il fatto è ben
chiaro:
“I contadini, oppressi dai vecchi e dai nuovi
proprietari, avevano per isfogo quotidiano il
brigantaggio, non mai cessato nella sua forma
endemica: l’”andare alla montagna”, con
le sue avventure e pericoli, e con la certa fine
cruenta, ma anche con la gioia disperata,
espressa nel proverbio:- meglio toro due anni
che bove cento anni”
.
36. Di fronte alle difficili, talora penose,
condizioni di vita dei contadini poveri, alle
tasse ed ai balzelli che opprimevano ed
esasperavano le popolazioni, non è poi così
strano che qualcuno, specialmente se giovane ed
impaziente, pensasse che era “meglio un giorno
da leone che molti giorni da pecora” e si desse
quindi “alla macchia”, ovvero fuggisse dal
villaggio di origine per vivere liberamente
nelle foreste o sui monti.
37. I boschi erano allora folti ed ampi, e
potevano quindi agevolmente nascondere gruppi
(più o meno organizzati, più o meno numerosi),
di persone che vivevano alla giornata e quindi,
oltre a quanto potevano procacciarsi nel bosco
stesso, usavano di quando in quando
“alleggerire” i peraltro rari viaggiatori.
38. “A ben leggere le pagine della storia
napoletana, sotto tutti i regni e le dinastie si
sono verificate forme di banditismo.
Tutto lo ha favorito: la povertà dei coloni
agricoli, le angherie e le malversazioni dei
signori, la prepotenza del clero, l’ignoranza in
cui era tenuta la plebe.... ed ancora, forme di
superstizione, di fanatismo, unite a corruzione
dilagante...”
39. E’ ben vero, dunque, ciò che ha affermato
Dumas: “Non si cerchi una data più o meno
recente al brigantaggio napolitano; esso è
esistito sempre”
.
40. Di certo, nell’epoca di cui ci stiamo
occupando, troviamo documentato che, nel 1337,
Roberto d’Angiò diede a tre monasteri napoletani
il compito di disboscare, colonizzare e popolare
il territorio sulle pendici del Vesuvio
denominato “silva mala” perchè era infestato dai
briganti: il territorio, una volta colonizzato,
e fino ad oggi, venne detto Boscoreale.
 |
|
Tomba di Carlo di Calabria, Tino da Camaino 1333, Napoli - Santa Chiara
|
Le meretrìci e la regina Sancia
41. Quando giunse a Napoli, la devota e pudìca
Sancia di Maiorca, seconda moglie di re Roberto,
dovette rimanere particolarmente impressionata
dal gran numero di povere donne che esercitavano
la prostituzione in città.
42. Il triste fenomeno, oltre che ingente per
quantità, doveva essere anche particolarmente
“visibile”, nel senso che si svolgeva, senza
troppo ritegno, alla pubblica vista.
43. La buona regina non poteva sapere (o lo
intuiva, forse, vagamente) che quello “universal
meretricio” era, in definitiva, fortemente
alimentato proprio dal sistema fiscale praticato
dal re suo marito e dai suoi predecessori.
Tale sistema, gravando insopportabilmente sui
ceti più poveri, alimentava anche quella
disperata miseria che spingeva non poche ragazze
del popolo, per procacciare di che vivere a se
stesse e spesso anche ai propri familiari, ad
ingrossare le fila del “mestiere più antico del
mondo”.
44. Fra le ragazze che “esercitavano” per le vie
o negli squallidi “bordelli” della città, non
poche provenivano proprio dalle campagne
circostanti e qualcuna, certamente, anche dai
nostri Casali di Sirinum, Casavaleria, Tertium,
etc.
Una ragazza povera rimasta orfana (e quindi
senza dote) o che avesse patito “oltraggio” (e
gravidanza) da parte di briganti o mercenari di
passaggio, che possibilità aveva, secondo la
mentalità del tempo, di “accasarsi”?
Abbastanza facilmente, poteva essere allettata
da false promesse di una “vita migliore” in
città, da parte di lenòni con pochi scrupoli,
salvo poi rimanere schiava per tutta la vita di
uno “sfruttamento sessuale” intenso e feroce,
che la portava in pochi anni, tra le molte
malattie del mestiere e dell’epoca, per le quali
non vi era nè prevenzione nè cura, assai
rapidamente a sfiorire e morire.
Non a caso, come abbiamo visto, procurare la
dote alle fanciulle povere costituiva
principalissima preoccupazione delle estaurìte
contadine, le quali cercavano, in tal modo, di
arginare il doloroso fenomeno.
45. In ogni modo, la buona regina Sancia (che
non poteva certo influire sulla politica fiscale
del marito e fu, d’altronde, da lui assai poco
amata) pensò, secondo il costume dell’epoca, di
far costruire un grande convento con annessa
chiesa, allo scopo di accogliere le donne
“traviate” che volessero “fare penitenza”,
abbandonando la loro vita peccaminosa.
Il monastero e la chiesa, significativamente,
furono intitolati a S. Maria Maddalena, una
delle donne che seguirono Gesù come discepole e
che una lunga tradizione interpretativa (che
oggi sappiamo erronea) riteneva essere stata, in
precedenza, una prostituta
.
46. Nelle intenzioni della regina, donna
sinceramente religiosa e fortemente permeàta di
spiritualità francescana, l’edificazione del
monastero avrebbe dovuto costituire una specie
di equivalente morale dell’opera di bonifica
delle paludi che stava contemporaneamente
conducendo il re suo marito.
Come l’accorto sovrano andava purificando le
malsane paludi ad oriente della città, così lei,
la regina, avrebbe purificato le “paludi del
vizio” cittadino.
47. La buona Sancia doveva però ben presto
accorgersi che “prosciugare” il meretricio a
Napoli era impresa molto più difficile che
prosciugarne le paludi.
48. Quasi subito, infatti, dovette far
ingrandire il monastero della Maddalena: a tal
scopo, nel 1343, permutò la struttura già
costruita con quella, più ampia, della chiesa e
“santa casa” dell’Annunziata, che intanto stava
sorgendo proprio di fronte, elargendo cospicue
donazioni anche a quest’ultima.
Il convento si venne così a trovare laddove
rimase poi per secoli (e cioè, appunto, di
fronte all’attuale chiesa dell’Annunziata)
finché, dopo una lunga e gloriosa storia, nel
1955 esso venne fatto demolire, per edificare al
suo posto il repellente grattacielo che ancor
oggi “impreziosisce” Via della Maddalena.
49. Allora, comunque, nemmeno il convento
ingrandito bastò, e la povera Sancia fece
costruire poco più in là, per lo stesso scopo,
un altro monastero con relativa chiesa, che
furono stavolta intitolati a S. Maria Egiziaca,
una Santa ritenuta anch’essa peccatrice come la
Maddalena e che poi, pentitasi, aveva trascorso
ben 47 anni di durissima vita eremitica nel
deserto egiziano.
Per questo secondo monastero, la regina stanziò
3000 once d’oro, più una rendita permanente di
150 once d’oro all’anno, più ancora un terzo di
quei famosi territori alle pendici del Vesuvio,
detti “silva mala”, che il re suo marito stava
facendo liberare dalla presenza dei “briganti”.
50. Il trascorrere dei secoli è stato, per la
seconda opera di Sancia di Maiorca, più
benevolo: la chiesa di S. Maria Egiziaca (detta
“a Forcella” o “all’olmo”), infatti, esiste
ancora e l’annesso monastero è diventato
l’attuale ospedale “Ascalesi”.
51. La vicenda dei due monasteri per donne
“traviate”, frutto dei nobili quanto
necessariamente inadeguati sforzi della regina
Sancia, proietta comunque una significativa luce
su quali dovevano essere, in quel tempo, le
condizioni di vita dei ceti più poveri e,
all’interno di questi, delle donne: doppiamente
oppresse, in quanto povere ed in quanto donne.
 |
|
La morte di Roberto d'Angiò
(immagine tratta da Chroniques
de France, Vienna, Museo Nazionale Austriaco) |
La politica fiscale: sue cause
52. Non si deve, peraltro, ritenere che la
opprimente politica fiscale provenisse da una
particolare “malvagità” dei re angioini: essa
era purtroppo legata alle condizioni stesse
nelle quali era avvenuta la conquista del regno
da parte della dinastia francese.
53. E’ noto infatti che Carlo I d’Angiò
(“fratello poco santo” del re di Francia S.
Luigi IX), “avido d’acquistare terra e signorìa
d’onde si venisse”, era stato invitato a
scendere nel Mezzogiorno d’Italia, ed a cingerne
la corona, da due papi di origine francese,
Urbano IV (1261-1264) e Clemente IV (1265-1268),
nel contesto del conflitto che opponeva in
quegli anni il papato alla Casa imperiale di
Svevia.
54. Tale invito non era però senza condizioni.
In cambio dell’investitura papale, Carlo si
impegnava a riconoscere il “plenum et ligium
vassalagium romanae ecclesiae” (“pieno e ligio
vassallaggio alla chiesa di Roma”) del regno che
andava a conquistare, simboleggiato dal dono
annuale di un “palafridum album” (un cavallo
bianco)
e soprattutto assumeva,
in concreto, una serie di impegni molto precisi:
pagare ogni anno al papa un tributo pari a 35
volte quello pagato dagli Svevi e fornirgli, a
richiesta, trecento cavalieri ed un certo numero
di navi; cedere definitivamente allo Stato
pontificio la città di Benevento ed il suo
territorio; introdurre nel regno una
legislazione particolarmente favorevole alle
gerarchie ecclesiastiche (esenzione del clero e
dei monasteri dalle imposte, immunità degli
ecclesiastici davanti a qualsiasi tribunale
laico, sia civile che criminale, appoggio del
braccio secolare per garantire il pagamento
delle decime, introduzione dell’inquisizione
papale nel regno, etc.).
55. Oltre al papato, Carlo I ebbe anche altri
accesi sostenitori, tutti ovviamente non
disinteressati: in primis, il ceto
aristocratico napoletano che, fortemente ostile
agli Svevi (ad eccezione, come già detto, dei
Capéce), appoggiò invece massicciamente
l’impresa di conquista degli Angioini; inoltre,
sostanziosi finanziamenti per l’esercito di
Carlo vennero dai banchieri e dai ceti
mercantili amalfitani, fiorentini, pisani,
genovesi...
56. Una volta vinta la battaglia di Benevento
contro Manfredi nel 1266 ed entrato in possesso
del regno, Carlo I si trovò quindi nella scomoda
necessità di dover “ricambiare” i ricevuti
appoggi.
Naturalmente, sia l’oneroso tributo da
corrispondere al papa che la restituzione dei
prestiti ai banchieri, si tramutarono in tasse
le quali, essendone esentato il clero (come da
accordi) ed essendo quasi del tutto esenti i
nobili, ricaddero in pratica esclusivamente sui
contadini poveri e sulle popolazioni.
 |
|
Ladislao,
bassorilievo in marmo, Napoli Museo di S. Martino
|
La politica ecclesiastica
57. Per gli ecclesiastici, iniziò ad entrare in
vigore, con particolare ampiezza, il regime
privilegiato che era stato pattuito, con tutte
le sue conseguenze.
58. Con documento del 1272, Carlo I ordinava di
non citare in giudizio, per alcun
motivo, gli appartenenti al clero,
commettendosi altrimenti delitto di “lesa
maestà” e di “attentato alla libertà della
Chiesa”.
Ne scaturì, però, che “la licenza e l’insolenza
dei prelati, dei chierici e dei monaci contro i
laici, ed anche contro il basso clero, die’ in
estremi eccessi, con invasioni e rapine di beni,
angarìe e ingiurie alle persone, e i chierici
andavano in giro armati a mo’ di masnadieri”
.
59. Già Federico II aveva stabilito che si
dovessero ricercare attivamente gli eretici
presenti nel Regno e punirli con “giusta pena”,
che poteva arrivare fino al rogo; il
riconoscimento e la condanna degli eretici erano
però strettamente riservati ai tribunali
secolari e i beni ad essi confiscati ritornavano
al demànio règio.
Nel periodo angioino, invece, entrò in vigore
“l’Inquisizione delegata da Roma ai frati, e
specialmente ai domenicani”
, con l’ulteriore
precisazione che i beni confiscati agli eretici
venivano adesso assegnati in parte agli stessi
Inquisitori e in parte alla Règia Curia.
60. In realtà, molto spesso, anche la parte
spettante alla Règia Curia fu devoluta ai
conventi dei frati in Napoli, a titolo di aiuto
alle loro spese di necessità.
Le chiese ed i monasteri, in particolare i
conventi ”nuovi” dei due Ordini religiosi di
recente fondazione (domenicani e francescani)
che avevano appoggiato gli Angioini nella
conquista del regno, ricevettero continue e
cospicue donazioni da parte dei sovrani e delle
loro pie consorti.
61. D’altronde, sia l’alleanza politica con il
papato, sia la sentita religiosità dell’epoca,
spinsero gli Angioini ad appoggiare un gran
numero di nuove fondazioni religiose di ogni
tipo.
Attraverso di esse, si consolidava il consenso
del popolo verso la dinastia, esaltando la
religiosa “generosità” dei sovrani.
D’altra parte, si provvedeva così ad attenuare
il malcontento popolare con una rete diffusa di
“assistenza sociale”, che interveniva a lenìre
parzialmente le piaghe di quella crescente
miseria che era provocata dallo stesso blocco
politico-religioso (aristocrazia ed alto clero)
che esercitava il potere.
62. In conclusione, e paradossalmente, “forse le
troppo libere condizioni che la Chiesa si
era procacciata nelle terre napoletane e che
egli era costretto a tollerare, queste
malinconiche meditazioni, e non il semplice
dilettantismo dottrinale, inclinarono quel
“savio re” (che fu Roberto d’Angiò) a difendere,
in un suo trattato, la dottrina della povertà di
Cristo e degli apostoli”
ed a proteggere quell’ala
del francescanesimo che, proprio per il suo
attaccamento alla povertà ed il suo desiderio di
rinnovamento della Chiesa, era accusata di
eresia.
 |
|
Luigi (Ludovico) II
d'Angiò
|
L’infeudazione delle terre
demaniali e la bonifica
63. I nobili napoletani furono, invece,
ricompensati con generose elargizioni in feudo
delle terre demaniali e così pure, naturalmente,
la nobiltà francese che aveva seguito Carlo
nella conquista del regno.
I nobili francesi, peraltro, ignorarono la
tradizione napoletana degli “usi civici” e si
comportarono in pratica verso le popolazioni
come conquistatori stranieri, almeno finché non
pervennero gradualmente a “naturalizzarsi” come
napoletani, alla seconda e terza generazione.
64. La necessità di procedere a nuove
infeudazioni delle terre demaniali fu però,
anche, uno degli elementi che spinse Carlo
d’Angiò a promuovere la prima vasta opera di
bonifica dell’area paludosa e malsana ad oriente
di Napoli, il che ritornò indirettamente a
beneficio delle nostre popolazioni.
65. Tale opera di bonifica, utilizzando il
naturale assetto idrogeologico del suolo e
continuando quel poco (o tanto) che era stato
già fatto dai coloni nel periodo del ducato
bizantino, comportò la sistemazione di tutta la
campagna mediante canali di irrigazione che,
irreggimentando le acque dilavanti che
scendevano dal Somma e dal Vesuvio, confluivano
tutti nel fiume Sebéto come unico collettore
verso il mare
.
In questa vasta opera, rientrò anche il
provvedimento a favore dell’acquedotto
napoletano, le cui acque, divenute malsane,
furono purificate nel 1268
.
Il risanamento delle paludi proseguì poi
ulteriormente con Carlo II e con re Roberto.
66. Questi provvedimenti resero ovviamente più e
meglio coltivabili le terre, aumentandone la
capacità produttiva e rendendole più
“appetibili” per i nobili feudatari e per i
monasteri della capitale.
67. Vediamo quindi che i vari sovrani angioini
modificarono gradualmente la scelta di Federico
II di Svevia di mantenere le terre “Foris
flubeum” nel demanio règio e cominciarono a
darne in feudo parti sempre più rilevanti a
nobili, ecclesiastici di riguardo, funzionari e
favoriti di corte.
68. A quest’ultima categoria doveva, molto
probabilmente, appartenere la Caterina
Galasso (detta infatti esplicitamente, dalla
regina Giovanna I, domicelle et fideli nostre)
cui furono donate, nel 1345, petias terre cum
domibus et fundo, site in loco ubi
dicitur la Barra deli Cocze.
69. Alla categoria dei funzionari potrebbe
invece appartenere, secondo una ipotesi che
espliciteremo di seguito, quel Giovanni de
Blasio al quale, nel 1294 (dunque, una
cinquantina di anni prima), fu concessa da Carlo
II petia terre una arbustata sita in loco qui
dicitur Barra de Coczis de territorio Tresani.
70. L’inizio dell’opera di bonifica delle paludi
(che, ricordiamolo, proseguì a fasi alterne fino
al XX secolo incluso) comportò, come è ovvio, un
generale miglioramento delle condizioni
ambientali, in cui si svolgeva la vita delle
nostre popolazioni.
71. Si attenuò, pur senza mai scomparire, il
fenomeno della malaria e diminuì, in genere, la
mortalità causata dalle varie malattie legate
alla insalubrità della zona; la migliore
irreggimentazione delle acque dilavanti fece sì
che anche lo strutturale fenomeno delle “lave
dell’acqua” potesse essere contenuto o, quanto
meno, meglio previsto nei suoi percorsi e nei
suoi effetti; si ebbe una maggiore disponibilità
di acqua potabile.
72. Il “fiume” per eccellenza, il Rubeolum
o Ribium, che era rimasto quasi
completamente sepolto dalla ristagnante palude,
poté iniziare a risorgere a nuova vita e perfino
ereditare il greco, classico, nome di Sebéto.
Per Giovanni Boccaccio (1313-1375), infatti, che
visse nella nostra città i suoi anni giovanili,
dal 1328 al 1340, il Sebéto “è il fiume presso
Napoli, in Campania, che io non ricordo di aver
visto, tranne che si tratti invece di quel
piccolo rivo che scorre nelle paludi alle falde
del monte Vesuvio e senza nome s’immerge nel
mare presso Napoli”
.
Divenuto, però, in seguito alla bonifica, il
collettore principale di acque meglio
irreggimentate, il fiume vide accrescersi la
propria portata ed anche la propria importanza
economica, che del resto, per le povere
popolazioni della zona, non era mai stata
trascurabile.
|
 |
 |
|
Saluto in oro,
regnante
Carlo I d'Angiò (1266-1285). Clicca sull'immagine per ingrandire |
La peste nera (1347-1350)
73. Né la bonifica, né le più limpide acque del
Sebéto, poterono comunque granché rispetto a
quella che fu la più grande sciagura del secolo,
ed una delle più grandi dell’umanità.
74. “Già la terribile carestia che prostrò
l’Europa intera dal 1315 al 1317 causò, a quanto
sembra, disastri superiori a tutte quelle che
l’avevano preceduta, ma trenta anni dopo un
disastro nuovo ed ancora più spaventoso, la
peste nera, si abbatteva sul mondo appena
rimessosi da quella prima calamità.
Di tutte le epidemie menzionate nella storia
dell’umanità, essa fu indiscutibilmente la più
atroce: si stima che, dal 1347 al 1350, abbia
provocato la scomparsa di circa un terzo della
popolazione europea”
.
75. E’ proprio il Boccaccio ad averci lasciato
una vìvida descrizione di quella immane
sciagura, nella “Giornata prima” del suo celebre
“Decameron”:
“Già erano gli anni della fruttifera
Incarnazione del Figliuolo di Dio al numero
pervenuti di 1348, quando...pervenne la
mortifera pestilenza, la quale o per operazione
de’ corpi superiori o per le nostre inique opere
da giusta ira di Dio a nostra correzione mandata
sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle
parti orientali incominciata, quelle
d’innumerabile quantità di viventi avendo
private, senza ristare, d’un luogo in un altro
continuandosi, verso l’Occidente miserabilmente
s’era ampliata”.
76. La malattia si disse peste “nera” perchè si
manifestava, come prosegue il Boccaccio, “con
macchie nere e livide, le quali nelle braccia e
per le cosce, e in ciascuna altra parte del
corpo, apparivano a molti, a cui grandi e rade
ed a cui minute e spesse” e queste macchie erano
“certissimo indizio di futura morte: quasi
tutti, infra ‘l terzo giorno dalla apparizione
de’ sopraddetti segni, chi più tosto e chi meno,
e i più senza alcuna febbre o altro accidente,
morivano”.
77. Lo scrittore sottolinea la dissoluzione dei
legami sociali e persino dei più stabili affetti
umani che la terribile malattia provocò:
“Era con sì fatto spavento questa tribulazione
entrata ne’ petti degli uomini e delle donne,
che l’un fratello l’altro abbandonava, e il zio
il nipote, e la sorella il fratello, e spesse
volte la donna il suo marito; e, che maggior
cosa è e quasi non credibile, li padri e le
madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di
visitare e di servire schifavano.
Per la qual cosa a coloro, de’ quali era la
moltitudine inestimabile, e maschi e femmine,
che infermavano, niuno altro sussidio rimase che
o la carità degli amici (e di questi fur pochi)
o l’avarizia de’ serventi...”
78. Il Boccaccio parla in particolare della
città di Firenze, ma descrive anche la
situazione delle campagne circostanti, che
dovette essere molto simile a quella dei Casali
intorno a Napoli:
“Nè la peste risparmiò il circustante contado;
nel quale... per le sparte ville e per gli
campi, i lavoratori miseri e poveri e le loro
famiglie, senza alcuna fatica di medico o aiuto
di servidore, per le vie e per le loro corti e
per le case, di dì e di notte indifferentemente,
non come uomini ma quasi come bestie morìeno...
Per che addivenne i buoi, gli asini, le pecore,
le capre, i porci, i polli, e i cani medesimi
fedelissimi agli uomini, fuori delle proprie
case cacciati, per gli campi, dove ancora le
biade abbandonate erano, senza essere non che
raccolte ma pur segate, come meglio piaceva loro
se n’andavano...”
79. Di tanto universale sciagura, abbiamo visto
che il Boccaccio, come tutti i suoi
contemporanei, attribuiva la responsabilità o
“all’operazione de’ corpi superiori” (cioè, ad
una malvagia influenza degli astri) oppure ad
una “correzione” delle “nostre inique opere” da
parte della “giusta ira di Dio”.
80. Noi oggi, per nostra fortuna, possiamo dire
qualche cosa in più.
Sappiamo oggi che la peste è dovuta ad un
bacillo (“Pasteurella pestis”), che usualmente
attacca i topi. La malattia viene
accidentalmente trasmessa all’uomo mediante la
puntura di alcuni tipi di pulci, che infestano i
topi ammalati e che, alla morte di questi,
passano a nutrirsi sull’uomo. Una volta colpito
l’uomo, essa si diffonde poi rapidamente per
contagio diretto ed anche, quando il bacillo si
localizzi nei polmoni, per semplice contagio
attraverso l’aria.
I medici contemporanei ci dicono altresì che la
peste si può dunque combattere (o meglio,
prevenire) attraverso la derattizzazione e la
distruzione delle pulci tramite insetticidi.
81. Alla luce di queste considerazioni, possiamo
ritenere che la malattia venne, con ogni
probabilità, importata in Europa occidentale dai
topi che trovavano larga e non richiesta
“ospitalità” sulle navi che tornavano dalle
crociate e su quelle al servizio degli
intensificati traffici tra le due sponde del
Mediterraneo.
82. D’altra parte, le condizioni di vita delle
popolazioni, a quel tempo, comportavano una
convivenza abbastanza abituale con topi e con
pulci e, naturalmente, non esistevano gli
insetticidi.
83. In tali condizioni, la peste era in pratica
tanto inevitabile quanto inestirpabile; ed
infatti, la grande peste nera della metà del
Trecento fu disastrosa non solo in se stessa ma
anche perché causò l’impianto endemico della
malattia in Occidente, per circa 400 anni, e
quindi tutte le successive epidemie che si
susseguirono in Europa fino all’ultimo decennio
dell’Ottocento.
84. Limitatamente a Napoli, e nel solo periodo
angioino, dopo la grande strage del 1347-50, la
peste infuriò nel 1362, nel 1382, nel 1399, nel
1411 ed ancora nel 1442, quando la città venne
conquistata dagli Aragonesi.
|
 |
 |
|
Saluto in argento,
regnante
Carlo I d'Angiò (1266-1285). Clicca sull'immagine per ingrandire |
Considerazioni sul periodo
85. Il Trecento fu dunque, per le nostre
popolazioni povere, un secolo complessivamente
micidiale e il periodo angioino, considerato nel
suo insieme e confrontato con quello precedente
(svevo) e con quello successivo (aragonese), non
appare certamente il più felice, dal punto di
vista dei contadini dei Casali.
86. “L’età peggiore (peggiore, del resto, per
disordini e ferocie, in tutta Europa) fu quella
dei cento anni tra il mezzo del Trecento ed il
mezzo del Quattrocento...
Guerre di pretendenti, saccheggi, stragi e
devastazioni per parte di genti da condotta,
imperversare di bande, brigantaggio, e insieme
tradimenti dei baroni, incostanza delle
popolazioni, passaggi continui dall’uno
all’altro partito e grandiose, improvvise e
rapide catastrofi di alti personaggi e d’intere
casate, e miseria e ozio e mancanza di arti, ed
abbassamento morale nei grandi e nei piccoli...
Il paese e la gente destavano commiserazione, e
più ancora riprovazione ed orrore”
.
87. Nonostante ciò, la popolazione era comunque
in crescita. L’età media non superava, con ogni
probabilità, i 40 anni, ma alla fine del
Quattrocento Napoli contava circa 40 mila
abitanti ed i suoi Casali circa 12 mila (cioè
2016 “fuochi”).
Gli inizi
della Barra de’ Coczis
88. E’ all’interno del quadro finora delineato
che si può forse comprendere meglio l’origine
della Barra de’ Coczis ed anche quella del suo
nome.
89. Il territorio detto Tresàno, essendo posto
in leggera salita rispetto alla zona delle
paludi, era tendenzialmente boscoso e salubre,
ed era ovviamente demaniale al tempo di Federico
II.
90. Per gli abitanti dei vicini Casali di
Sirinum e di Casavaleria esso costituiva quindi
una risorsa di notevole importanza, ai fini
soprattutto degli “usi civici”: si poteva andare
nel bosco a raccogliere legna, erba da fieno per
gli animali e frutta selvatica, a cacciare e
pescare, a cavare pietre vesuviane per le
costruzioni e, in modo del tutto ovvio, si
poteva liberamente transitare.
91. Con gli Angioini, tutto questo cambiò, in
modo abbastanza brusco: a sorvegliare il bosco
vi era, adesso, il “mastro forestaro” che, per i
vari usi, pretendeva la gabella dovuta al re.
92. Fra le tante “diaboliche” novità, che
suscitavano l’ira dei giovani ed il rassegnato
scandalo degli anziani, vi fu, molto
probabilmente, una “sbarra” per la riscossione
di un pedaggio.
Niente di strano, in regime angioino: abbiamo
già visto che era stata istituita la “gabella
delle sbarre” per entrare e uscire dalla città
trasportando i prodotti della terra, e che
appunto una di queste sbarre era già stata
collocata sul ponte delle paludi; perchè non
anche per transitare attraverso il bosco
demaniale?
Ecco dunque la famosa “Barra” (o “Varra”, come
anche si disse fino a tutto il Seicento).
93. Ma una sbarra per le gabelle non funziona
certamente da sola: il “mastro forestaro”,
titolare della riscossione, ha bisogno di un
discreto numero di collaboratori per sorvegliare
il bosco ed imporre i nuovi scomodi usi (o
piuttosto “ab-usi”) ad una popolazione
giustamente riottosa.
Questi collaboratori, oltre eventualmente al
mastro stesso, debbono necessariamente risiedere
sul posto, perchè non possono allontanarsi,
lasciando la zona incustodita, e quindi anche le
rispettive famiglie si debbono insediare nei
pressi della “Barra”.
Ed ecco dunque, a poco a poco, formarsi anche un
piccolo gruppo di abitazioni.
94. D’altra parte, abbiamo visto come il ceto
dei funzionari (fra cui i “mastri forestari”)
potesse raggiungere rapidamente una discreta
agiatezza, proprio grazie alle percentuali che
riscuoteva sulle gabelle: quindi, una casa più
grande, un certo numero di servi, contadini che
coltivano le terre e gli orti annessi, che
accudiscono il bestiame, etc.
95. A loro volta, i contadini dei Casali vicini,
in quest’ epoca impoveriti dalle tasse
crescenti, in fuga sia dalle terre demaniali che
da terre feudali con signori sempre più
esigenti, possono trovare conveniente mettersi
sotto la protezione di un funzionario
“emergente”, che gode di una situazione di
relativo privilegio e può quindi permettersi di
trattarli meglio, sia come guardiani, che come
servi, come coloni, etc.
96. A poco a poco, il funzionario può persino
riuscire ad ottenere una o più terre in
concessione, poi addirittura un vero e proprio
piccolo feudo...
I suoi vecchi dipendenti, d’altronde,
profittando anche del miglioramento delle terre
indotto dalla bonifica, possono a loro volta
diventare coloni (per l’epoca) abbastanza
agiati, disboscare nuove terre, e così via...
97. In definitiva, tutto il territorio Tresàno,
che del resto abbiamo visto essere già in parte
coltivato in epoca ducale e normanna, sortì alla
lunga, paradossalmente, un benefico effetto di
risveglio economico dalla installazione della
famosa “barra”.
Questo accadde, in sostanza, perchè la
famigerata “barra delle gabelle” consentì ad un
certo numero di persone, inizialmente ristretto,
di accumulare un “capitale primitivo”, che fu
poi re-investito sul territorio nelle attività
agricole tradizionali e ritornò quindi a
beneficio di un più vasto numero di abitanti del
circondario.
98. D’altra parte, questo produsse
inevitabilmente anche un certo aumento delle
dis-uguaglianze ed una sensibile riduzione delle
precedenti usanze comunitarie.
99. Ciò spiega anche perchè, nel periodo
angioino, è il “loco qui dicitur Barra” che
cresce, fino a diventare poi Casale nel periodo
aragonese, mentre Sirinum e Casavaleria appaiono
statiche o addirittura in declino economico.
Erano, infatti, venute meno le condizioni
“sveve” (sicurezza, possibilità di fruire
largamente degli “usi civici”, carico fiscale
non pesantissimo), che avevano consentito ai
casali di Tertium, Casavaleria, Sirinum, di
poter crescere per quantità di popolazione e
“qualità” di vita, mentre le nuove condizioni
(le gabelle, lo sviluppo del ceto dei
funzionari, la bonifica) operavano in modo da
far nascere un Casale (la Barra de Coczis)
“nuovo”, non solo nel senso che prima non c’era
ma anche per le modalità della sua origine e la
composizione sociale dei suoi abitanti.
Origine del nome “Barra”
100. Il nome al Casale, dunque, secondo quanto
sostenuto anche dal P. Alagi, sembra sia
derivato da una sbarra o “barra” che chiudeva la
strada ai fini della riscossione delle gabelle.
101. Ma come mai quel “de’ Coczis” che
accompagna il termine “Barra”?
L’ipotesi più lineare rimane quella secondo la
quale “Coczis” è semplicemente il cognome della
famiglia che ebbe in appalto la riscossione
delle gabelle al passaggio della famosa “barra”,
onde il luogo venne ben presto detto “la Barra
de’ Coczis”.
102. Tale ipotesi è coerente con quanto dice il
Cozzolino:
“Ed uno dei territorii venduto, ma non
infeudato, sotto il re Carlo I d’Angiò, alla
borghese famiglia napoletana de Coczi, de Coctii,
de Coctiis o de Coczis, in gran parte, fu
appunto quello di Tresano o Trasano, per gran
danari imprestati alla Regia Corte; il che
importa che questo territorio era in allora
demanio di re”
.
103. I de’ Coczis sarebbero dunque una delle
molte famiglie napoletane che appoggiarono
finanziariamente l’impresa di conquista, da
parte di Carlo I d’Angiò, del regno di Napoli,
ottenendone poi in cambio l’appalto per la
riscossione delle gabelle nella zona demaniale
del Tresano nonché, nel 1275, una ampia parte
del territorio stesso.
104. Analogamente si comportò, come abbiamo già
detto
, la famiglia nobile degli
Aprano, che ricevette poi in cambio, a titolo
ereditario, l’ufficio (e la rendita) di
“collettore” delle imposte di vari Casali e, fra
questi, quello di Sirinum.
105. Essendo i de’ Coczis benestanti ma non
nobili, il territorio ad essi assegnato non fu
dato a titolo di feudo, anche se costituiva
comunque una cospicua rendita, che i de’ Coczis
non mancarono di sfruttare e di valorizzare nel
modo precedentemente descritto.
A tal proposito, si può osservare che, ancor
oggi, i cognomi “Cocozza” e “Cozzolino”
(chiaramente derivati da “Coczis”) sono ben
presenti e diffusi nella zona
.
106. A sua volta, il Giovanni de Blasio
che nel 1294 ricevette, da Carlo II d’Angiò,
petia terre una arbustata sita in loco
qui dicitur Barra de Coczis de territorio
Tresani, potrebbe essere stato o un nuovo
funzionario che in quell’anno prese il posto dei
de’ Coczis o semplicemente qualcuno che
ricevette il dono di un terreno, nello stesso
territorio Tresano, vicino a quello dei de’
Coczis.
Su questo terreno, il de Blasio potrebbe poi
aver costruito una propria abitazione oppure
essersi limitato a riscuotere dai contadini i
frutti della terra, dimorando egli altrove: non
esistono elementi che consentano di poter
decidere fra queste due alternative.
107. Infine, si elencano di seguito le diverse
ipotesi, avanzate da vari autori, circa
l’origine del nome “Barra”, nonché le ragioni
per le quali non sembrano condivisibili.
108. Ipotesi Prima:
Il termine “Barra” potrebbe derivare dal greco
“barry, barrydos” che significa “torre” e
riferirsi quindi alle molteplici torri che
furono una caratteristica del casale.
Le torri, però, furono edificate solo nel
periodo aragonese, come diremo in seguito;
quando, cioè, il nucleo abitato già da più di un
secolo si chiamava “Barra”.
109. Ipotesi Seconda:
Il termine “Barra” potrebbe derivare dal fatto
che la famiglia de’ Coczis aveva, nel suo
podere, anche un “porticus”, che in greco
corrotto si diceva “barra”.
A parte, però, la discutibilità di questa
etimologia, va osservato che la struttura del
portico era molto comune, sia nelle “corti”
contadine che nelle successive ville, e non si
capisce quindi perchè solo quel determinato
“porticus” sarebbe stato chiamato “barra” e non
anche gli altri.
110. Ipotesi Terza:
Il termine “Barra” potrebbe derivare dal fatto
che i terremoti e l’azione vulcanica del Vesuvio
formarono, su una parte del territorio Tresano,
alcuni “ammassi di lapilli, cocci di lava
indurita e gusci di molluschi” e da allora
quella zona sarebbe stata chiamata “Barra”, che
significherebbe appunto “ammasso di sabbia o di
altra materia”.
Non si trova, però, in quale vocabolario il
termine “barra” significhi “ammasso di sabbia o
di altra materia”. Non in quello italiano, nè
latino, nè greco, nè napoletano. In quale,
dunque? A parte ciò, vale inoltre quanto già
detto a proposito del termine “porticus” e cioè
che “ammassi di lapilli e cocci di lava
indurita”, alle falde del Vesuvio, se ne sono
sempre formati evidentemente parecchi: perchè
solo quello, e nessun altro, avrebbe assunto il
nome “barra” ?
111. Ipotesi Quarta:
L’abitato sorse, in ragione delle acque
dilavanti, disponendosi ortogonalmente alle
linee di compluvio, al di sopra di una linea
mediana di raccolta, determinando così una
conformazione urbanistica a forma di “barra”,
che avrebbe dato origine al suo nome.
A ciò si può osservare che, se è ben vero che il
centro storico di Barra ha una conformazione
urbanistica “lineare”, ortogonale alle linee di
compluvio, disponendosi le abitazioni ai due
lati del Corso Sirena, non è però possibile che
sia stato questo fatto a dare origine al nome
“Barra”, perchè quando questo termine compàre
per la prima volta (alla fine del Duecento), il
numero delle abitazioni è ancora troppo esiguo
per poter costituire un allineamento allungato.
Il tracciato tipicamente lineare cominciò a
formarsi solo dopo l’unificazione con Serino
(alla fine del Quattrocento), anche per favorire
il collegamento tra i due nuclei abitati.
|
 |
 |
|
Fiorino in oro (1343-1382). Clicca sull'immagine per ingrandire |
I Domenicani
112. Abbiamo visto che il Giustiniani riporta un
diploma, datato 24 dicembre 1301, del re Carlo
II d’Angiò, “il quale tra le molte donazioni
fatte a’ PP. Predicatori per la costruzione
della chiesa di S. Domenico maggiore di Napoli,
vi si legge questa: Item pecia una terre
arbustata sita in loco qui dicitur
Barra de Coczi de territorio tresano coniuncto
ab una parte terre S. Gregorio ecc.”
113. Ciò non vuol dire che l’attuale chiesa e
convento dei Domenicani in Barra risalgano a
quell’epoca; è anzi ben documentato
che la prima pietra della
costruzione del convento di Barra fu posta solo
il 16 novembre 1584, alla presenza dell’allora
arcivescovo di Napoli, Annibale Di Capua
(1578-1595), come vedremo meglio più avanti.
114. Dal Trecento al Cinquecento, dunque, la
pecia una terre arbustata di Barra fu, per i
Domenicani, una semplice rendita feudale che
servì, insieme a molte altre, prima per la
costruzione e poi per il mantenimento della casa
principale dell’Ordine nel regno meridionale: il
convento di S. Domenico Maggiore in Napoli.
115. In effetti, i Domenicani iniziarono a
diffondersi nel regno già nel periodo Svevo
(1194-1266), non molti anni dopo la loro
fondazione.
Data l’importanza della loro presenza, anche
nella storia di Barra, si ritiene qui non
inutile una piccola parentesi ad essi dedicata.
116. Ricordo, dunque, che S. Domenico de Guzman,
nato a Caleruega in Castiglia, visse dal 1171 al
1221; il suo Ordine (“Ordo fratrum
praedicatorum”, in sigla OP) prese forma già nel
1206, ebbe approvazione ufficiale dal papa
Onorio III (1216-1227) nel dicembre del 1216 e
si diffuse assai rapidamente in tutto il mondo
allora conosciuto, dalla Scozia alla Siria.
117. Alla morte di S. Domenico, fu suo
successore il tedesco Giordano di Sassonia
(1222-1237), uomo di grandi capacità
organizzative, che scrisse anche la costituzione
dell’Ordine.
118. Fu lui, in particolare, ad insediare i suoi
frati a Napoli, nel convento di S. Domenico
Maggiore, sotto la guida del primo priore fra’
Tommaso Agni da Lentini: nel 1231 il papa
Gregorio IX (1227-1241) scrisse, a tal
proposito, prima (20 ottobre) all’allora
arcivescovo della città, Pietro II di Sorrento
(1217-1247) e subito dopo (25 ottobre) a tutto
il popolo napoletano; infine (il 1 novembre)
l’arcivescovo donò ufficialmente ai Domenicani i
pre-esistenti monastero e chiesa benedettini di
S. Arcangelo a Morfisa.
119. Il papa era allora impegnato nella
controversia con Federico II di Svevia e, alle
controversie, i Domenicani erano ben avvezzi:
non per nulla, il loro Ordine era stato fondato
nel contesto della grande lotta contro l’eresia
albigese, nella Francia meridionale.
120. Nel loro stemma recavano la scritta
“veritas” ed il simbolo del cane, perchè essi si
definivano, con un gioco di parole,
“domini-canes” (“i cani del Signore”), ossia
coloro che si erano assunti il compito di fare
la guardia affinché il gregge del Signore non
venisse disperso dagli eretici; ovvero affinché
questi non si introducessero nel “campo del
Signore”, inquinando le sorgenti della “veritas”.
121. La finalità specifica dell’Ordine era
perciò l’approfondimento, la difesa e lo studio
sistematico della “veritas” cristiana e
cattolica, attraverso una rigorosa disciplina di
studio teologico, allo scopo di esercitare la
“sancta praedicatio”, la predicazione al popolo,
onde elevarne la conoscenza e la pratica della
dottrina cristiana e preservarlo dal pericolo di
cadere nell’eresia.
122. Si tratta, come si vede, di un “carisma”
preciso e ben chiaramente definito.
Tale precisione e chiarezza nella definizione
della propria identità, da una parte, evitò ai
Domenicani le laceranti divisioni interne che
afflissero invece il coèvo Ordine francescano
(costantemente alle prese con le dispute sulla
“povertà”) e, d’altra parte, anche per la
perfetta rispondenza alle esigenze del momento
storico, li pose all’avanguardia, nel bene e nel
male, della Chiesa dell’epoca.
S. Tommaso d’Aquino
123. Fu, com’è noto, un Domenicano il massimo
teologo europeo di quel tempo ed uno dei più
grandi della storia della Chiesa, il nobile
Tommaso d’Aquino, vissuto dal 1225 al 1274 e
proclamato Santo nel 1323.
 |
|
Paolo de Majo (Marcianise 1703-1784),
San Tommaso d'Aquino, olio su tela (Caserta, collezione
privata) |
124. Tommaso, ultimo dei figli del conte
Landolfo d’Aquino, nobile di origine longobarda,
e di Teodora, discendente dall’aristocrazia
normanna, nacque nel borgo di Roccasecca, a metà
strada fra Roma e Napoli, nel 1225.
La sua nonna paterna, Francesca di Svevia, era
sorella di Federico Barbarossa, imperatore del
Sacro Romano Impero: Tommaso era dunque cugino
del suo grande coetaneo Federico II di Svevia,
anche se molto diverse furono le loro strade.
A cinque anni, venne affidato dalla famiglia, in
qualità di “oblato”, al monastero benedettino di
Montecassino, ove rimase fino al 1239.
A quattordici anni, venne inviato a studiare in
quella Università che proprio suo cugino
Federico II aveva fondato in Napoli, pochi anni
prima, allo scopo di promuovere una cultura
“laica”, in opposizione alle altre Università
allora esistenti, come quella di Bologna, che
erano invece di impostazione “guelfa” e papale.
Qui, Tommaso fu iniziato alle opere di
Aristotele, ritenuto allora un autore
“pericoloso” da parte dell’autorità
ecclesiastica, del quale Tommaso diventerà e
resterà sempre convinto seguace in campo
filosofico.
A diciannove anni, decise di unirsi all’Ordine
domenicano di recente fondazione, nonostante
l’accesa opposizione di suo padre e dei suoi
fratelli.
Subito dopo, fu inviato dai superiori a studiare
prima a Parigi e poi a Colonia, avendo come
maestro il confratello S. Alberto Magno.
Ritornò a Parigi come docente, dal 1252 a1 1259.
Nel decennio successivo, fu in Italia, in
territorio papale: ad Anagni, Orvieto, Roma,
Viterbo, lavorò nell’organizzazione degli
“Studi” domenicani.
Dal 1269 al 1272 di nuovo a Parigi, impegnato
nelle controversie contro gli averroisti, che
interpretavano Aristotele in modo non
compatibile con la dottrina della Chiesa.
Solo nel 1272 ritornò infine a Napoli, per
fondarvi lo “Studio” domenicano, nel convento di
S. Domenico Maggiore, ove visse ed insegnò.
Dopo appena due anni ivi trascorsi, morì il 7
marzo del 1274, all’età di 49 anni, nel
monastero cistercense di Fossanova, mentre era
in viaggio per recarsi al II Concilio di Lione,
in Francia, come consulente teologico; 50 anni
dopo, nel 1323, venne proclamato santo dal papa
Giovanni XXII (1316-1334).
125. La sua vita fu interamente dedicata, in
piena coerenza al “carisma” domenicano, allo
studio, all’insegnamento e alla predicazione. I
testimoni dell’epoca riferiscono che dettava
abitualmente a tre o quattro segretari alla
volta, su argomenti diversi. Fu autore di
numerose e densissime opere, che rivelano una
delle menti più vaste e profonde che l’umanità
abbia mai avuto; il suo capolavoro rimane la
famosa “Summa theologiae”, composta fra il 1265
ed il 1273 e lasciata peraltro incompiuta a metà
della terza ed ultima parte.
126. Il suo pensiero consiste essenzialmente in
un “aristotelismo cristiano”, ossia nella
sintesi tra la filosofia di Aristotele ed i
presupposti del messaggio evangelico: si tratta
quindi di un poderoso tentativo di unificare, al
punto più alto, la grande civiltà classica
antica e la novità introdotta dal cristianesimo,
in modo da fornire una compiuta base teorica
alla “societas christiana” medioevale.
127. Il pensiero di Tommaso, per la sua novità,
andò incontro all’inizio ad una notevole
opposizione all’interno della Chiesa che, nelle
sue autorità più tradizionaliste, era legata,
piuttosto che ad Aristotele, al “platonismo
cristiano” elaborato qualche secolo prima da S.
Agostino. Per lo stesso motivo, anche i teologi
francescani ne furono costanti oppositori. Nel
1277, tre anni dopo la sua morte, i vescovi
Tempier di Parigi e Kilwardby di Oxford
condannarono alcune proposizioni tratte dalle
opere di Tommaso.
A partire dal Concilio di Trento, nel
Cinquecento, il pensiero di Tommaso divenne, per
così dire, la “filosofia ufficiale” della Chiesa
e nel 1567 il papa S. Pio V (1566-1572) lo
proclamò “Dottore della Chiesa”.
La predicazione
128. Ma non c’era solo l’alta cultura. Furono i
Domenicani coloro che praticarono, in modo
sistematico, anche la predicazione al popolo.
Si consideri che, a quel tempo, la predicazione
era riservata ai soli vescovi e S. Domenico,
all’inizio della sua opera, venne osteggiato da
molti esponenti del clero secolare e dei vecchi
Ordini religiosi (benedettini, cistercensi,
certosini, etc.), con la motivazione che egli,
presuntuosamente, pretendeva di fondare “un
Ordine di vescovi”.
In realtà, il Santo, per contrastare
l’estendersi dell’eresia, rivendicava la
funzione di predicare anche al semplice frate,
purché naturalmente ben preparato e soprattutto
di vita esemplare.
Il popolo, e gli stessi studiosi, ebbero così la
possibilità di un nuovo e largo accostamento
alle fonti della Sacra Scrittura e dei Padri
della Chiesa, che erano rimaste oscurate
dall’ignoranza, dalle superstizioni e dal
fanatismo dell’Alto Medioevo.
Aspetti ambigui: l’Inquisizione
129. Furono Domenicani, però, anche i più
convinti e micidiali assertori
dell’Inquisizione, della sua logica e delle sue
procedure. Di essa, anzi, furono specificamente
responsabili, come adesso si dirà.
130. Già il papa Lucio III (1181-1185), nel
Sinodo di Verona del 1184, aveva individuato e
colpito con scomunica i principali gruppi
eretici popolari che andavano emergendo in
quell’epoca, come i Càtari (soprattutto quelli
della Francia meridionale, che erano detti
“albigesi”, dal nome della città di Alby), i
Valdesi, ed altri gruppi minori.
131. Il grande Concilio ecumenico Lateranense IV,
indetto dal papa Innocenzo III (1198-1216) nel
1215, sancì ufficialmente, per tutto il mondo
cristiano, la scomunica (e, dopo un anno, la
deposizione e la perdita del potere) per quei
feudatari che non avessero “purificato” dagli
eretici le loro terre, mentre i vescovi avevano
il dovere di ricercare gli eretici in tutte le
diocesi e procedere alla loro punizione per mano
delle autorità civili.
132. Nel frattempo, lo stesso papa Innocenzo III
aveva indetto la grande crociata contro gli
albigesi, che diede inizio ad uno scontro
armato, durato 20 anni (1209-1229), con atroci
massacri e devastazioni in tutta la Francia
meridionale.
133. Poco dopo la conclusione della guerra
albigese, il papa Gregorio IX (1227-1241),
ritenendo insufficiente e troppo blanda l’azione
fino ad allora svolta dai singoli vescovi in
esecuzione dei decreti del Concilio Lateranense
IV, istituì ufficialmente, con apposito
documento del 1231, l’Inquisizione papale, con
il compito di ricercare (“inquirere”) e punire
(attraverso il braccio secolare) gli eretici in
tutto il mondo cristiano, e la affidò agli
Ordini religiosi di recente fondazione, in
particolare proprio ai Domenicani dei quali essa
divenne da quel momento un còmpito specifico.
134. Circa i metodi da adoperare, il papa
Innocenzo IV (1243-1254) ripristinò, nel 1252,
la tortura quale valido mezzo di prova
nei processi inquisitoriali, contraddicendo
peraltro la precedente dottrina ufficiale della
Chiesa, che con il papa Niccolò I (858-867)
aveva invece condannato la tortura come “offesa
contro ogni legge, umana e divina”.
135. Di per sé, l’ideale originario di S.
Domenico era la libera conversione degli
eretici, attraverso la predicazione e l’esempio
di povertà dei suoi frati.
Adesso, però, si registrava una innegabile
involuzione:
“I frati non si confrontavano in spirito di
libertà con quelli che apparivano come nemici
della fede, ma agivano ben consapevoli che alla
fine erano comunque loro a determinare
l’intervento del braccio secolare.
Il rischio dunque era quello di perdere di vista
l’idea primordiale del dialogo, quella idea che
aveva spinto S. Domenico a trascorrere una notte
a dialogare con l’oste per ottenerne da Dio la
conversione.
Prendeva cioè sempre più piede la tendenza a
scoprire e punire gli eretici, piuttosto che la
preoccupazione di convertirli sinceramente e
liberamente all’ortodossia della fede cristiana”
.
136. In tale contesto, si spiega l’emergere
delle tristemente controverse figure di “Grandi
Inquisitori” domenicani, come il francese
Bernardus Guidonis (Gui), autore del
trattato “Practica (officii) inquisitionis
haereticae pravitatis” e l’aragonese Nicolaus
Eymericus, autore del “Directorium
inquisitorum haereticae pravitatis”. Essi, morti
entrambi nel Trecento, ebbero poi validi
continuatori quali Johannes Nider
(1380-1438) e soprattutto i famigerati Jacob
Sprenger (1437-1495) e Heinrich Institor
(1432-1505), inquisitori in Germania ed autori
del tremendo “Malleus maleficarum” (“Martello
delle streghe”), che costituì per alcuni secoli
il “testo-base” per l’individuazione di eretici
e streghe.
Aspetti ambigui: il contesto politico
137. Nel contesto napoletano, comunque, i
Domenicani si impegnarono a fondo nella lotta
contro il pluri-scomunicato Federico II e
nell’appoggio alla conquista del regno da parte
degli Angioini.
Non meraviglia, quindi, che, dopo la vittoria di
Carlo I d’Angiò nel 1266, essi assurgessero a
grandi onori: esaltati nei documenti dei sovrani
come “fedelissimi custodi della fede ed energici
mìliti della Santa Sede”, svolsero
ufficialmente, per conto del papa, il ruolo di
Inquisitori nel regno e ricevettero, soprattutto
dai primi re angioini, cospicue donazioni per i
loro conventi (vedi nn. 57-62).
138. Nel 1294, su richiesta di Carlo II d’Angiò,
con Bolla del papa Celestino V (luglio-dicembre
1294), confermata l’anno seguente dal nuovo papa
Bonifacio VIII (1295-1303), venne istituita la
“Provincia Regni” ovvero la circoscrizione
domenicana che comprendeva tutta, e solo,
l’Italia meridionale continentale e la Sicilia.
Primo priore provinciale: fra’ Pietro di Andria.
139. Gli storici domenicani attuali appaiono ben
consapevoli delle ambiguità derivanti dal
contesto politico in cui avvenne tale
istituzione:
140. “La Provincia Regni nacque dalla
convergenza fra gli interessi politici degli
Angioini e i sentimenti di autonomia dei frati
del Sud (dai loro confratelli) ”
.
141. “Non solo re Carlo non ne ostacolò i
movimenti, come era avvenuto ai tempi
dell’imperatore svevo nei confronti dei frati
che sostenevano la politica papale, ma li inviò
lui stesso in tutto il regno, a controllare la
fedeltà dei regnicoli al pontefice e
quindi al potere angioino che ne era il braccio
secolare.
Si può dire perciò che i Domenicani, beneficati
in diversi modi dallo stato, non di rado
divennero involontariamente uno strumento nelle
mani del potere costituito e riconosciuto dalla
Chiesa.
Cosa che ovviamente aveva i suoi vantaggi (buona
libertà di movimento e sicurezza economica) ma
anche i suoi svantaggi, in quanto l’inquisizione
non colpiva soltanto gli eretici veri e propri,
come richiedeva lo spirito dell’Ordine, ma anche
(ed erano numerosi) gli eretici politici, vale a
dire i ghibellini”
.
142. “Col 1294, il rapporto fra l’Ordine e gli
Angioini acquisiva un più chiaro e duraturo
assestamento, nel senso di un impegno continuo
dei Sovrani nel dare un concreto appoggio alla
missione dell’Ordine nonché un altrettanto
continuo impegno dell’Ordine nel ricercare e
segnalare i nemici del re”
.
143. In particolare, la sede principale dei
Domenicani nel regno, ovvero la chiesa con
annesso convento di S. Domenico Maggiore in
Napoli, fu magnificamente ristrutturata ed
ampliata nel periodo 1284-1324, grazie
soprattutto alle elargizioni di Carlo II.
144. Appunto fra queste elargizioni, si registra
nel 1301 la concessione di alcune terre,
appartenute alle famiglie De Rebursa e Parrilli,
site in vari Casali di Napoli, ed in particolare
quella, riportata dal Giustiniani, relativa alla
pecia una terre arbustata sita in loco qui
dicitur Barra de Coczi de territorio tresano
(vedi n.112).
L’estaurìta di Sirinum viene data
in feudo
145. Mentre sul territorio Tresano avvenivano
tali trasformazioni, anche il vicino villaggio
di Sirinum era investito da mutamenti non meno
profondi: all’interno dei rapporti comunitari
fra “li homine de lo Casale” organizzati in
estaurìta su terre demaniali, venivano innestati
dall’alto, in modo abbastanza pesante, nuovi
rapporti di subordinazione feudale.
146. Infatti, nell’àmbito della generale
politica angioina, di infeudazione delle terre
demaniali e di favori alle istituzioni
ecclesiastiche, che abbiamo già descritto, il re
Roberto d’Angiò fece dono di una parte delle
terre di Sirinum, inclusa la chiesa estaurìta di
S. Atanasio, all’ospedale dell’Annunziata di
Napoli.
147. Questo ci fa sapere il Chiarito
, citando l’Inventario dei
beni posseduti dal suddetto ospedale, che
“sèrbasi nell’Archivio della Chiesa della SS.
Annunziata di questa Metropoli”:
“L’accennato Inventario, formato nell’anno 1336,
ci fa sapere che in questo Villaggio (Sirinum,
ndr) vi fosse una Chiesa dedicata a detto
nostro Vescovo S. Atanasio; ed altre curiose
notizie.
Leggesi in detto Inventario così: Item habet
dictum Hospitale in Casali Sireni Stargiam
terrae unam... per mensuram... computata in
dicta mensura Ecclesia S. Athenasii; cum curti
ante se usque ad viam publicam, Cimiterio...
concessa per Abbatem dicti Hospitalis; de
speciali gratia stauritae dictae
Ecclesiae”.
148. Vediamo quindi che, nel 1336, l’ospedale
dell’Annunziata possedeva Stargiam terrae
unam del territorio del casale di Sirinum e
che in dicta mensura erano inclusi anche:
a) la chiesa di S. Atanasio, che era la
chiesetta del villaggio e, ovviamente, la sede
della relativa estaurìta;
b) la corte davanti alla chiesa, fino alla via
pubblica (corte che si vede tuttora davanti alla
“Arciconfraternita della SS. Annunziata”, fino
al Corso Sirena);
c) il cimitero annesso alla chiesa, che doveva
essere in parte sottostante ed in parte
restrostante la chiesa stessa (ricordiamo che
l’usanza cristiana, prima del famoso editto di
Napoleone che impose le sepolture extra-urbane,
era di seppellire i defunti sotto le chiese o
quanto meno in prossimità di esse).
149. Ma quando era avvenuta la donazione?
E’ qui opportuno ricordare che la chiesa della
SS. Annunziata (“Ave gratia plena”, in sigla
AGP) in Napoli, fu una delle più notevoli
istituzioni religiose promosse dagli Angioini in
città.
Alla chiesa erano annessi un importante ospedale
(tuttora funzionante) e la cosiddetta “Santa
Casa” per l’infanzia abbandonata (nella quale i
bambini venivano accolti attraverso la
caratteristica “ruota”, abolita solo nel 1875),
che funzionò in pratica fino al 1980.
150. Dalla storia, dunque, dell’Annunziata
, apprendiamo che la più
antica documentazione esistente su di essa è un
diploma angioino, datàto 15 dicembre 1318, nel
quale i “Maestri della SS. Annonciàta sopra
muro” chiedono al re Roberto l’espropriazione di
“un fodicciuolo di tal Tommaso Coppula” per la
costruzione della “Chiesa et Hospidale”, da
erigersi con elemosine dei fedeli.
151. E’ certo, quindi, che nel 1318 esisteva già
una confraternita intitolata all’Annunziata
(tale confraternita era nata presumibilmente un
paio di anni prima, attorno ad una piccola
cappella omonima) e che la chiesa e l’ospedale
erano in costruzione.
152. Il re Roberto, come usava, sostenne l’opera
con varie donazioni e, fra queste, vi fu
evidentemente anche quella della Stargiam
terrae unam del nostro villaggetto di
Sirinum, che troviamo poi registrata
nell’inventario compilato nel 1336.
153. Fu dunque nel periodo fra il 1318 e il 1336
(più vicino alla prima che alla seconda data)
che il re Roberto d’Angiò concesse terra e
chiesa, con corte e cimitero (come sopra detto),
del Casale di Sirinum a titolo di rendita
feudale all’Annunziata, così come suo padre
Carlo II aveva concesso ai Domenicani, nel 1301,
pecia una terre arbustata ... de territorio
tresano.
154. Per gli Angioini, fu semplicemente una
ulteriore donazione ad enti ecclesiastici di
beni del demànio règio, ma per la minuscola
popolazione del Casale di Sirinum (ricordiamo
che potevano essere una cinquantina di persone)
costituì una svolta, poco meno che epocale,
della sua storia.
La contésa
155. Questa volta, infatti, oltre la terra, era
stata infeudata anche la chiesetta e quindi i
“maestri dell’estaurita”, eletti dalla
popolazione, si trovarono all’improvviso a
dipendere dall’abate dell’ospedale.
156. Considerato che essi erano abituati ad
amministrare direttamente i beni della comunità,
sotto il controllo ed a vantaggio della comunità
stessa, nonché a nominare senza interferenze il
cappellano che amministrava i sacramenti, si può
ben comprendere come da quel momento siano
insorte continue controversie fra l’estaurita e
l’abate, le cui tracce permangono nei documenti
addirittura fino al Concilio di Trento ed oltre.
157. I quattro estauritari, alla testa delle
sette-otto famiglie di Sirinum e con il
presumibile appoggio del loro povero prete di
campagna, dovettero iniziare una fiera “guerra
di trincea”, per far rispettare i diritti della
loro piccola comunità, rispetto al nuovo,
potente feudatario, resistendo ad ogni sorta di
pressioni materiali e morali (si consideri che,
in quel tempo, si poteva utilizzare addirittura
lo strumento della “scomunica”, per ottenere il
versamento delle rendite...).
158. Si trattava, da una parte, della disputa
(rinnovantesi in pratica ogni anno) circa la
ripartizione dei prodotti della terra fra la
comunità locale e l’abate, che poi diventava
ovviamente una disputa più generale circa il
potere di gestione della comunità e dei suoi
beni; d’altra parte, la controversia riguardava
anche il diritto di nomina del cappellano, che
fino a quel momento era di pertinenza della
comunità (che peraltro lo stipendiava), mentre
adesso veniva rivendicato dall’abate, che anzi
pretendeva addirittura di nominare direttamente
gli stessi maestri dell’estaurita, sottraendoli
quindi alla elezione ed al controllo degli
uomini del Casale.
159. Non esistono, purtroppo, documenti che
consentano di ricostruire nei dettagli tutta la
disputa, che dovette essere piuttosto
aggrovigliata, anche perché la Chiesa universale
attraversava in quel secolo una grave crisi.
160. Dal 1309 al 1377 i papi ebbero sede non a
Roma bensì ad Avignone, in Francia, e furono
fortemente subalterni alla monarchia francese (è
il periodo cosiddetto della “cattività
avignonese” della Chiesa).
Tornati i papi a Roma, nel 1378 ebbe però inizio
il cosiddetto “grande scisma”, cioè un lungo
periodo che durò fino al 1417, nel quale si
ebbero contemporaneamente due papi (in certe
fasi addirittura tre), che si contendevano il
governo della Chiesa, oltre che con reciproche
scomuniche, anche con gli eserciti schierati dai
rispettivi sostenitori.
161. In questa fase, naturalmente, anche la
Chiesa di Napoli si trovò ad avere
contemporaneamente due (o tre) arcivescovi,
ognuno nominato da un papa diverso ed ognuno
fermamente convinto di essere il legittimo capo
della diocesi e reclamante l’obbedienza dei
sudditi.
162. In tale situazione, non è difficile
immaginare che anche la piccola (ma, per la
povera popolazione, vitale) disputa fra Sirinum
e l’Annunziata potesse trascinarsi per decenni,
con parziali successi ora dell’uno, ora
dell’altro, in una situazione di sostanziale
equilibrio, potendo sempre ognuno dei due
competitori appellarsi ad una autorità ritenuta
“più legittima” di quella alla quale si
appellava l’antagonista.
163. D’altra parte, occorre considerare che la
contesa non era combattuta, dalle due parti, con
pari fervore e determinazione: per il piccolo
Casale di Sirinum si trattava di una questione
vitale e determinante, dalla quale dipendeva in
definitiva la sua stessa sopravvivenza; per
l’Annunziata, si trattava invece di una rendita
piccolissima ed in sostanza trascurabile,
rispetto alle molte e cospicue donazioni che
vennero fatte all’istituzione nel corso di tutto
quel secolo e nel successivo.
Si può quindi presumere che, da parte dell’AGP,
la vicenda fosse seguita in modo piuttosto
blando e che l’accanimento (se vi fu) fosse più
“di principio” che di sostanza.
164. E’ ben certo, comunque, e documentato
, che nel 1411 il piccolo
Casale arrivò ad intentare causa contro
l’ospedale: evento che dovette restare
memorabile nella tradizione orale delle famiglie
del Casale, visto che ancora veniva ricordato
durante la Santa Visita del card. Decio Carafa,
nel 1620!
165. I contadini di Sirinum ed i loro “mastri”
erano sicuramente poveri e presumibilmente
ignoranti, ma non erano certo stupidi.
La data per far causa all’ospedale, infatti,
appare decisamente ben scelta, ove si consideri
che non solo era ancora in corso il “grande
scisma” ma appena due anni prima (quindi, nel
1409) la Santa Casa dell’Annunziata aveva
ricevuto in dono dalla regina Margherita, madre
del re Ladislao d’Angiò-Durazzo, il grande feudo
di Lesina, in Capitanata, che fu la più grande
investitura feudale concessa all’istituto.
L’AGP si trovava quindi in un momento nel quale
non doveva avere grosse difficoltà economiche e
poteva, dunque, permettersi una certa
benevolenza verso il povero Casale!
166. Ad ogni modo, non si sa come andasse a
finire la causa.
D’altra parte, nel 1432, la regina Giovanna II
d’Angiò-Durazzo finanziò interamente i lavori
per la costruzione di un nuovo ospedale per
l’Annunziata e quindi la rendita di Sirinum
diventò ancor meno significativa per l’istituto.
167. Sembra, ma non è certo, che il papa Eugenio
IV (1431-1447), qualche anno dopo, terminato
ormai lo scisma, abbia finalmente concesso
all’abate dell’ospedale il “privilegio” di
nominare il cappellano dell’estaurita di
Sirinum.
168. Ma il nostro piccolo Casale (vuoi per
fierezza di spirito, vuoi per la disperazione
della miseria, vuoi per entrambe le cose),
continuò evidentemente a dimostrarsi un osso
molto duro da piegare, tanto che il 25 febbraio
1543 (ed il manoscritto, dopo quanto abbiamo
detto, suona quasi come un bollettino di
vittoria), durante la Santa Visita del card.
Francesco Carafa
,
“relatum fuit eidem domino
visitatori quod dicta ecclesia regitur per
quator magistros laycos pro tempore eligendos de
dicta Villa qui eligunt Cappellanum in dicta
ecclesia amovibilem pro celebratione missarum et
administratione ecclesiasticorum sacramentorum”
(traduzione: fu riferito al signor visitatore
che la detta chiesa (quella di Sirinum) è retta
da quattro maestri laici, che vengono eletti
periodicamente da detta Villa, i quali (a loro
volta) eleggono il cappellano in detta chiesa,
amovibile, per la celebrazione delle messe e
l’amministrazione dei sacramenti ecclesiastici).
169. Dunque, nel 1543, quando Sirinum si era
ormai unificato con la Barra de Coczis in un
unico Casale con un’unica chiesa estaurìta, la
popolazione di questo Casale continuava ad
eleggere i suoi “quattro maestri laici” per
governare la chiesa (ed i beni connessi), ed i
maestri sceglievano chi dovesse essere il prete
cappellano, che era comunque “amovibile”, poteva
cioè essere rimosso e sostituito con un altro, a
giudizio delle famiglie e degli stessi
“magistros laycos”.
170. Sembrerebbe quindi, per i nostri contadini,
una vittoria quasi completa, ma... la vicenda
ebbe poi ulteriori sviluppi e i loro
antagonisti, con il Concilio di Trento, si
presero la loro rivincita.
Di questo parleremo, però, nel capitolo dedicato
ai due secoli del vice-regno spagnolo.
Cronologia dei Re Angioini di
Napoli
1266-1285 Regno di Carlo I d’Angiò
1266
- Battaglia di Benevento: Carlo I d’Angiò
sconfigge Manfredi di Svevia, che muore in
battaglia.
1268 - Battaglia di Tagliacozzo: Carlo I d’Angiò
sconfigge Corradino di Svevia (figlio di Corrado
IV) che viene poi decapitato in Piazza Mercato a
Napoli e sepolto alla foce del fiume Sebéto.
Napoli diventa la capitale del Regno.
1275 – La famiglia de’ Coczis riceve da Carlo I
d’Angiò un terreno in territorio Tresano.
1282 - Inizio della guerra “del Vespro”: la
Sicilia si ribella agli Angioini e offre la
corona a Pietro III d’Aragona, marito di
Costanza figlia primogenita di Manfredi.
1285-1309
Regno di Carlo II d’Angiò, figlio primogenito di
Carlo I
1294 – Giovanni de Blasio riceve da Carlo II
d’Angiò un terreno sito in Barra de Coczis de
territorio Tresani.
1301 – I Padri Domenicani ricevono da Carlo II
d’Angiò un terreno sito in Barra de Coczi de
territorio tresano.
1302
Finisce la guerra “del Vespro” fra
Angioini ed Aragonesi, con la pace di
Caltabellotta: Carlo II d’Angiò mantiene il
titolo di “Re di Sicilia” ed il possesso della
parte continentale del Regno, mentre Federico II
d’Aragona, col titolo di “Re di Trinacria”,
s’impossessa della Sicilia; alla sua morte,
però, l’isola dovrà tornare agli Angioini.
1305
Carlo II fa esporre per la prima volta in
pubblico il busto d’argento, da lui
commissionato ad òrafi della corte angioina, per
contenere le ossa del cranio di S.Gennaro.
1309-1343 Regno di Roberto d’Angiò, terzogenito
di Carlo II
1309-1377
“Cattività avignonese”: i papi non risiedono più
a Roma ma ad Avignone (Francia) e sono
fortemente subalterni alla monarchia francese.
1328-1340 Giovanni Boccaccio a Napoli. Roberto
d’Angiò fa costruire la teca per contenere le
ampolle del sangue di S. Gennaro.
1336 – Nell’inventario dei beni concessi da
Roberto d’Angiò all’abate della “Santa casa”
dell’Annunziata in Napoli figurano anche dei
terreni posti nel Casale di Sirinum e la chiesa
estaurita di S. Atanasio.
1337 - Dopo la morte di Federico II d’Aragona,
il suo successore si rifiuta di restituire
l’isola agli Angioini, come stabilito a
Caltabellotta, ed assume anzi anch’egli il
titolo di “Re di Sicilia” in concorrenza con gli
Angioini.
Da questo momento vi sono quindi 2 “Regni di
Sicilia”: uno, denominato “Regno di Sicilia di
qua dal faro (il faro di Messina)” che è in
effetti il Regno di Napoli governato dagli
Angioini; l’altro, denominato “Regno di Sicilia
di là dal faro”, che è in effetti la Sicilia
governata dagli Aragonesi.
In pratica, quindi, a partire dal 1282, la
Sicilia costituisce un Regno autonomo, governato
dai seguenti re aragonesi:
1282-1285 Pietro I (III d’Aragona)
1285-1295
Giacomo I (II d’Aragona)
1295-1336 Federico II
1336-1342
Pietro II
1342-1355
Luigi
1355-1377
Federico III
1377-1402 Maria
1402-1409 Martino “il giovine”
1409-1410
Martino “il vecchio”
1343-1382 Regno di Giovanna I d’Angiò, figlia di
Carlo (primogenito di Roberto morto
prematuramente)
1345 Caterina Galasso riceve da Giovanna I
d’Angiò una casa, con terreni, sita in la
Barra de li Cocze.
1347-1350
La grande “peste nera” spopola l’Europa.
1378-1417
“Grande scisma” nella Chiesa: si hanno
contemporaneamente 2 papi (in certe fasi, anche
3) che si contendono il governo della Chiesa
cattolica.
1382-1386 Regno di Carlo III d’Angiò-Durazzo.
1386-1399
Reggenza di Margherita di Durazzo, moglie di
Carlo III.
1389
(17 agosto) – E’ documentato il verificarsi per
la prima volta del “miracolo di S. Gennaro”: il
sangue del martire si scioglie nelle ampolle.
1399-1414 Regno di Ladislao d’Angiò-Durazzo,
figlio di Carlo III e di Margherita.
1414-1435
Regno di Giovanna II d’Angiò-Durazzo, sorella di
Ladislao.
Nicola Del Pezzo-”I casali di Napoli” in
“Napoli nobilissima”, settembre 1892,
pag.2
M. Camera “Annali delle due Sicilie”-
Napoli, 1841, vol.I, pag. 290.
Giambattista D’Addosio- “Origine,
Vicende storiche e progressi della Real
S.Casa dell’Annunziata di Napoli”-
Napoli, 1883. Vedi anche il recente: Ida
Maietta e Angelo Vanacore-
“L’Annunziata: Chiesa e Santa Casa”-
Napoli, 1997.