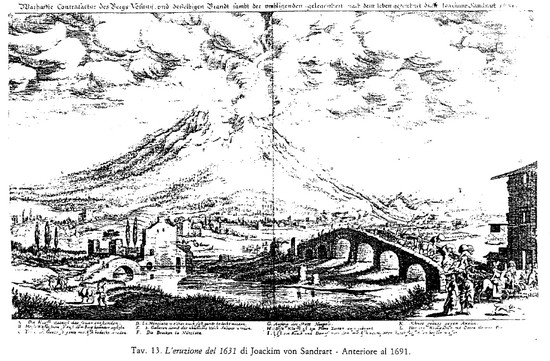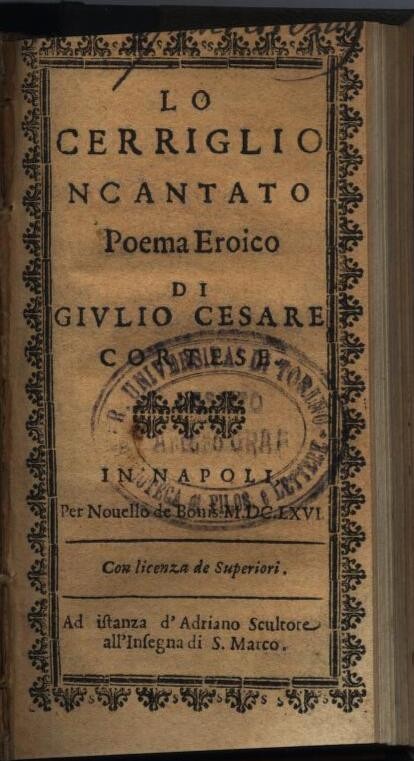La Barra nel Seicento
1. Il parroco Don Giuseppe
Carlino (1687-1709) fu particolarmente accurato
nella sua relazione per la Santa Visita del
Card. Giacomo Cantelmo (1691-1702) e fornì
questo quadro statistico della popolazione della
Barra nel 1699:
|
Popolazione dai
18 anni in su |
2190 |
|
Popolazione al di
sotto dei 18 anni |
385 |
|
Sacerdoti
cittadini (di Barra) |
4 |
|
Sacerdoti
forestieri (non di Barra) |
7 |
|
Chierici |
1 |
|
Religiosi
domenicani |
12 |
|
Religiosi
francescani |
7 |
|
Romiti (Eremiti) |
1 |
|
Totale della
popolazione |
2607 |
2. Si è visto
che, alla fine del Quattrocento, i due Casali
unificati di Sirinum e della Varra de’ Coczis
avevano poco più di 100 abitanti (“fochi
decisepte”). A metà del Cinquecento, si ebbe
l’unificazione anche con Casavaleria, che a sua
volta doveva avere dimensioni non molto più
grandi
e, nel 1599, gli abitanti erano più di 1.000.
3. La crescita della
popolazione, nei due secoli del dominio
spagnolo, fu dunque eccezionalmente rapida e
costante: addirittura maggiore di quella, pur
notevole, che si verificava contemporaneamente
nella città di Napoli
.
Le grandi catastrofi che pure
ebbero luogo nel periodo (la peste e la guerra
nel 1526-28; i terremoti della seconda metà del
Cinquecento; l’eruzione del Vesuvio nel 1631; la
grande peste del 1656; le carestie, le epidemie,
etc.) ben lungi dal frenare l’aumento della
popolazione, sortirono evidentemente l’effetto
contrario di rafforzare la capacità di
resistenza e lo spirito di adattamento di questo
popolo “solare” amante della vita.
Vi fu, soprattutto, un fenomeno
di immigrazione verso il Casale, dovuto alle
condizioni sociali complessivamente più
favorevoli, rispetto alle altre campagne del
regno, che in esso si potevano trovare.
4. In ogni caso, è nel periodo
del vice-regno spagnolo che Barra acquista la
sua fisionomia unitaria di fondo, che verrà poi
trasmessa ai secoli successivi.
5. Come si è detto, nella
seconda metà del Cinquecento si ebbe
l’insediamento nel Casale dei due conventi,
francescano e domenicano, la fine della
estaurìta di Casavaleria (intorno al 1577) e,
alcuni decenni dopo, anche di quella della Varra
di Serino (1620), contestualmente al sorgere
della parrocchia della “SS. Annunziata - AGP” (a
partire dal 1610).
6. Nel corso del Seicento, su
questo tessuto sociale prevalentemente
contadino, innervato solo da insediamenti
religiosi, cominciano ad innestarsi anche, in
modo stabile, nuclei dell’aristocrazia e della
grande borghesia arricchitasi con il commercio e
la speculazione.
La villa di Gaspare Roomer
7. Qui occorre far menzione,
prima di ogni altro, di Gaspare Roomer
(nato intorno al 1585-morto il 3 aprile 1674),
del “coraggioso e fortunato mercante, ma anche
inesauribile sovvenitore di istituzioni pie e
generose, e intelligente mecenate”, “fiammingo
per nascita ma napoletano per elezione”
,
il quale, nei primi decenni del Seicento
(intorno al 1620), fece costruire in Barra una
sua magnifica villa, nella quale “servito da una
corte numerosa, riceveva con splendidezza i
viceré e i più grandi signori del regno”
.
8. Data l’importanza di questa
figura per la storia di Barra, si raccomanda
allo studioso lettore la consultazione della sua
classica biografia, curata da Giuseppe Ceci
nel 1921, dalla quale si apprendono anche vari
particolari del suo rapporto con la villa
situata nel nostro Casale.
9. Ci si limita qui ad
osservare che il Roomer apparteneva alla
categoria, generalmente odiata, degli
“arrendatori”
e probabilmente scelse la Barra per insediarvi
la sua “villa di rappresentanza” anche perchè
sapeva che qui non vi era alcuno che potesse
avere risentimenti nei suoi confronti, essendo
il Casale esente da buona parte della
tassazione.
10. Inoltre, la scelta di Barra
per l’insediamento fu certo favorita dalla
vicinanza alla nuova “strada delle Calabrie”,
promossa nel 1562 dal vicerè Don Perafàn
.
“Tale strada litoranea...
costituì l’asse primario delle comunicazioni...
servendo di collegamento tra la città e i
numerosi Casali sviluppatisi lungo la costa e
raggiungendo a monte i Casali sparsi,
tramite diramazioni.
Dalla strada costiera, la più
antica via di accesso al primitivo nucleo del
Casale di Barra... doveva essere quella che oggi
reca il nome di via Bernardo Quaranta.
L’antica cupa costituiva
infatti il percorso più breve per chi, dalle
residenze costiere vice-reali (come la famosa
villa di Bernardino Martirano in
Pietrabianca) si dirigeva a quelle del
Casale di Barra...
Va rilevato che l’incrocio tra
questa via di collegamento (attuale Via
Bernardo Quaranta) e l’altra (attuale
Corso Sirena) che costituiva l’asse del
Casale, rappresentava non solo un punto nodale
della struttura urbana e territoriale, ma
rivestiva anche una notevole importanza sotto il
profilo della difesa della zona, avvalendosi del
lieve pendìo fra il monte ed il mare; e fu certo
questa una delle cause preminenti della scelta
di tale sito per l’insediamento della villa del
Roomer, come per la localizzazione conventuale
dei domenicani”
.
11. Teresa Colletta si spinge
fino a ritenere abbastanza fondata l’ipotesi
,
avvallata pure dallo storico barrese Pasquale
Cozzolino nel 1889, che anche la prima villa di
Barra, quella Duecentesca dei de’ Coczis (in
seguito distrutta dalle eruzioni del Vesuvio),
fosse situata proprio in questo luogo, scelto
poi dal ricco mercante fiammingo per edificarvi
il suo palazzo.
Il “quadrivium” nobile
12. In ogni caso, è certo che
l’incrocio tra il Corso Sirena e le attuali Via
Bernardo Quaranta e Via Villa Bisignano può
essere considerato il “quadrivium nobile” di
Barra, proprio per l’importanza strategica di
cui si è detto, che ha favorito l’insediamento,
in almeno tre dei suoi quattro angoli, di
edifici di notevole valore storico: la villa del
Roomer; la villa Filomena; il convento dei
domenicani con l’adiacente villa Finizio (nella
quale poi, nell’Ottocento, visse Bernardo
Quaranta).
Le ville-masserìa del
Seicento
13. Quasi contemporaneamente
alla villa del Roomer, ed accanto ad essa, sorse
infatti la villa Filomena.
La villa Filomena, la villa
Amalia (sita in Casavaleria e recante
esplicitamente la data 1617) e la villa
Mastellone (attestata nel 1678) costituiscono
gli esempi, tuttora presenti in Barra, di
ville nobili a carattere rustico-residenziale
anteriori al periodo settecentesco.
Non si trattava, cioè, di ville
“di rappresentanza”, come quella del Roomer, nè
di ville “di delizia” come quelle successive del
“Miglio d’oro”, ma di “ville-masseria” nelle
quali famiglie di piccola nobiltà di provincia
risiedevano stabilmente, a diretto contatto con
le loro terre e con i contadini che le
coltivavano.
14. Ciò spiega quanto osservato
da Anna Giannetti e Benedetto Gravagnuolo
riguardo a villa Filomena: “il tono
dell’edificio è tutt’altro che aulico e l’ampia
corte retrostante sembra più destinata a
svolgere funzioni agricole che a condurre verso
giardini di delizie. Anche formalmente,
l’edificio manifesta più solidità e utilità che
grazia: le mura hanno una pesante conformazione
a scarpa, certamente per opporsi al
deflusso delle acque torrentizie... mentre la
planimetria a doppia L con il basso ingresso e
l’ampia corte rettangolare ha molti più punti di
contatto con la tipologia a corte dell’edilizia
minore di Barra che con quelle della villa
suburbana”
.
15. Si tratta quindi di un tipo
di insediamento, intermedio fra le piccole corti
agricole pre-esistenti e le grandi ville
aristocratiche che verranno dopo, espressione di
una piccola nobiltà ancora sana, che manteneva,
in qualche modo, rapporti con l’attività
produttiva e con il lavoro contadino nei feudi,
di non grande estensione, da cui provenivano le
sue rendite.
Presenze illustri nella villa del Roomer: Donna
Marianna (1630)
16. La villa del “borghese”
Gaspare Roomer ebbe il suo momento di gloria
nelle corti di tutta Europa nel 1630, quando
venne “prescelta quale residenza della regina
d’Ungheria (Maria Anna d’Austria) nel suo
soggiorno napoletano, dall’8 agosto al 19
dicembre dello stesso anno.
In suo onore probabilmente
furono scolpite le insegne della casa d’Asburgo
(l’aquila bicipite) nei pilastrini ancor oggi
visibili nella balaustra della terrazza
affacciante sul giardino. Si proseguiva in tal
modo una usanza già introdotta da Carlo V nel
1535, quando l’imperatore prese alloggio nella
villa di Bernardino Martirano”
.
17. In effetti, Donna Maria
Anna d’Austria era niente di meno che la
sorella del re di Spagna Filippo IV, ed andava,
proprio allora, sposa al re d’Ungheria.
Per recarsi alle nozze, avrebbe
dovuto attraversare la Lombardia, nella quale
però in quell’anno infieriva la peste; si
decise, pertanto, di farla transitare per
Napoli, dove era in quel tempo viceré Fernando
Afàn de Ribera, secondo Duca d’Alcalà
(1629-1631), discendente di quel Don Perafàn che
aveva governato dal 1559 al 1571.
18. Il soggiorno napoletano
della promessa sposa, tra feste, cerimonie,
incidenti di etichetta, liti per questioni di
precedenza, etc. etc. durò piuttosto a lungo
(più di quattro mesi, come si è detto) e si
concluse con una “Nobilissima Cavalcata che si
fece a’ 19 di dicembre del 1630, nell’uscita
della Serenissima Infante D. Maria d’Austria,
Regina d’Ungheria”
.
19. E’ inutile dire che la
maggior parte delle spese furono a carico del
vice-regno napoletano (cioè delle popolazioni
povere, che pagavano donativi e gabelle).
Presenze illustri nella villa del Roomer: il
conte di Penaranda (1658-59)
20. Un altro momento nel quale
la villa del Roomer si trovò al centro
dell’attenzione fu quello del trapasso dei
poteri fra due vicerè, nel 1658-59.
Gaspar de Bracamonte y Guzmàn,
conte di Penaranda, era stato chiamato a
prendere il posto di Garcia de Avellaneda y Haro,
conte di Castrillo, illustre giurista
dell’Università di Salamanca, che aveva
governato nel periodo 1653-1658 (ed aveva dunque
dovuto, fra l’altro, fronteggiare la peste del
1656).
I rapporti fra i due notabili
spagnoli non erano evidentemente molto buoni,
giacché essi rifiutarono ostinatamente di
incontrarsi fra di loro per la cerimonia del
passaggio dei poteri.
Il Penaranda giunse a Napoli il
29 dicembre del 1658, ma dovette aspettare fino
all’11 gennaio dell’anno seguente, in attesa che
il suo predecessore sgombrasse il palazzo reale.
In questo periodo di epica
tenzone diplomatica in punta di fioretto (in
pratica, per le feste di Capodanno ed Epifania)
il nuovo viceré alloggiò appunto nella villa del
Roomer a Barra.
Il “nefasto” conte di Monterey
(1631-1637)
21. Nefasta quant’altre mai per
la nostra popolazione fu l’epoca del viceré
Manuel de Zuniga y Fonseca, conte di Monterey
(1631-1637).
Il periodo di governo di questo
vicerè iniziò con una catastrofe naturale
(l’eruzione del Vesuvio, nel 1631) e si concluse
con una catastrofe sociale (la risoluzione di
vendere a privati tutti i Casali demaniali,
compresa la Barra, nel 1637).
22. Pressato dalle continue e
crescenti richieste di denaro da parte della
corte di Madrid (la Spagna era allora impegnata
nella guerra “dei trent’anni”) e convinto, da
parte sua, che la città ed il regno di Napoli
pagassero ancora poco rispetto agli altri
possedimenti spagnoli, il Monterey aumentò il
peso fiscale sulla popolazione fino al punto
massimo mai raggiunto nei due secoli del dominio
spagnolo.
Sotto di lui (che peraltro continuava a condurre
vita sfarzosa e mondana, fra ricevimenti e
rappresentazioni teatrali) si diffuse nel popolo
il detto che era meglio vivere fra i Turchi
“infedeli” piuttosto che nel viceregno di
Napoli!
L’eruzione del Vesuvio nel
dicembre 1631 (e le seguenti)
23. Il Monterey arrivò a Napoli
il 14 maggio del 1631. Il 16 dicembre di quello
stesso anno, iniziò un’eruzione del Vesuvio
tanto terrificante per i contemporanei quanto
memorabile presso i posteri.
L’eruzione del 1631 fu la più forte di tutto il
secondo millennio:
il Vesuvio subì un abbassamento di circa 450
metri e si formò un cratere di circa 2 Km di
diametro. Il “gran cono”, con un fortissimo
terremoto, collassò sulle falde, come
liquefatto, in terribili colate di lava che
cancellarono ogni cosa fino al mare; il mare
stesso si ritirò dal lido, quasi spinto indietro
dall’enorme frana.
24. L’eruzione immediatamente
precedente si era verificata nell’anno 1500,
sicché se ne era ormai perduta ogni memoria
presso le popolazioni ed abbandonate tutte le
possibili, pur fragili, precauzioni. L’area
vesuviana era stata di nuovo (a Casali sparsi,
ma interamente) riedificata ed inevitabile fu
quindi la tragedia. Furono distrutti interi
paesi e villaggi; si contarono morte circa
10.000 persone, più 6.000 animali di
allevamento; i danni stimati ascèsero ad oltre
25 milioni di ducati.
25. Si deve poi aggiungere che
la lava continuò ancora a riversarsi, con vari
episodi eruttivi negli anni seguenti
(1649-60-80-85-89), all’interno del cratere che
si era aperto, formando un nuovo “gran cono”
che, alla fine del secolo, cominciò ad essere
ben visibile anche da Napoli. Infine, nel 1694,
nel 1696 e nel 1698, la lava fuoriuscì
nuovamente dal cratere, traboccando in direzione
di S. Giorgio a Cremano, Boscotrecase e Torre
del Greco.
|
 |
L'eruzione del Vesuvio del 1631 |
Le descrizioni dei cronisti – Il
P. Saverio Santagata
26. Le descrizioni della grande
eruzione del 1631, da parte dei cronisti
dell’epoca, sono pittoresche quanto drammatiche,
e si possono leggere tenendo davanti agli occhi,
a mo’ di illustrazione, i due disegni del
Vesuvio, prima e dopo l’eruzione, pubblicati da
G. B. Masculo nel suo “De Incendio Vesuvio”,
libri X, Napoli, 1663.
27. Così il P. Saverio
Santagata, della Compagnia di Gesù:
“Il compimento di tutti questi
terrori fu ciò che avvenne circa le ore
dieciotto dell’istesso giorno di mercoledì
diciassettesimo di dicembre.
Allora, non cessando la pioggia
orribile e niun’altra delle molte cagioni del
mortalissimo affanno, sopravvenne un ultimo, ma
più di tutti gli altri esizial terremoto, che
fece vacillar come canna ogni edifizio, e non
pochi ne scompaginò, gittandone a terra non
piccol numero.
Nel tempo stesso, si commosse
il monte dalle radici e, per via di naturale
rovinosissima mina sbalzato in aria
l’impedimento della sommità, che sbassato restar
lo fece di molto, aprì in tutto la orribil
bocca, con ampiezza di un miglio e mezzo nel suo
diametro e di tre in circa nella irregolare
circonferenza.
Apèrtosi così il varco ad
infellonire e nuocere, fece il monte incredibili
scempi; perocché lo stesso fu lo spalancarsi
della gran voragine, e il rovesciarsi nelle
sottoposte contrade le furie tutte d’inferno.
Basti dire che, in meno di una quarta parte di
ora, quattordici volte rigurgitando, mandò
tartarei e sopra ogni umano pensamento orribili
fiumi di zolfo, bitume, alume, acque boglienti,
cenere, sabbia, e fuoco mescolato a minerali di
ogni specie; le quali roventi materie rovinando
giù a precipizio dalle valli, rapiron seco per
lo cammino sassi e macigni di smisurata mole, e
con esterminio non mai veduto rasero da’
fondamenti, senza lasciarne neppur vestigio,
case, palagi, chiese, ville, e popolazioni
intere, a cui fu lo stesso accorgersi dei ferali
allagamenti del monte, ed il trovarsi oppresse
dall’ultimo ed inevitabil fato”
.
|
 |
L'eruzione del Vesuvio del 1631 |
Le descrizioni dei cronisti – Il
P. Salvatore Varone
28. Il De Dominicis, dopo di
averci detto che la lava, la quale si riversò
dalla voragine apertasi il mercoledì, si
divise in sette correnti di varia natura, e
che una di esse fu quella che, scendendo per S.
Giorgio, prese la volta di Napoli, così continua
il racconto
,
volgendo in italiano le parole del P. Salvatore
Varone, della Compagnia di Gesù, nelle sue
“Vesuviani incendii Historiae”:
“Il primo torrente
precipita verso occidente minacciando la città
di Napoli, e poco mancò che non assorbisse con
sinistro soffio la scarsa perennità del Sebéto;
imperocché precipitando pei sottoposti confini
di Barra e di S. Giorgio, dapprima dòmina su la
via règia presso Pietrabianca, indi prorompe nel
Tirreno a due miglia lungi da Napoli, dove
s’innalza una chiesa della gran Regina che,
soccorrendo con somma benignità ai voti de’
mortali, dal popolo è invocata sotto il nobile
titolo di S. Maria del Soccorso (si tratta
appunto della chiesa della Madonna del Soccorso,
fondata nel 1517 in S. Giovanni a Teduccio,
dove ancor oggi vi è una lapide commemorativa
dell’evento) ”.
|
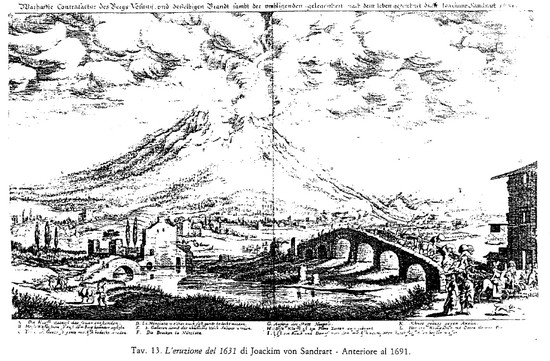 |
L'eruzione del Vesuvio del 1631 |
Le descrizioni dei cronisti – Il
Capitano de Contreras
29. Il capitano spagnolo Alonso
de Contreras, che si trovava a Nola, così
descrive
:
“Una mattina, martedì 16
dicembre, si vide un gran pennacchio di fumo
sulla montagna... ed a mano a mano che avanzava
il giorno, il sole si oscurò e cominciò a
tuonare ed a piovere cenere. La gente, vedendo
che tutto il giorno e anche la notte continuava
a piover cenere, cominciò a spaventarsi e ad
abbandonare la città.
Fu quella una notte così
orrenda che credo non ci sia l’uguale neanche il
giorno del giudizio; non solo cenere, ma
cadevano dal cielo anche pietre infuocate, come
le scorie che cavano i fabbri dalle fucine,
grandi quanto una mano ed anche di più. Oltre a
ciò, si ebbero quella notte violente scosse di
terremoto che fecero crollare molte case; i
cipressi e gli aranci si squarciavano come se
fossero partiti da un’ascia di acciaio.
Tutti gridavano “Misericordia
!” che faceva proprio pena udirli. Ed era una
pena che non so dirvi, vedere la poca gente
ch’era rimasta, scarmigliate le donne, ed i
bambini che correvano di qua e di là, mentre da
una parte bruciava una casa e dall’altra ne
cadevano due; anche quelli che volevano scappare
non sapevano dove andare, perché affondavano
nella cenere e nella terra infocata...
Al fuoco e alle ceneri che non
cessavano di piovere si aggiunse anche l’acqua,
perché cominciò a precipitare dalla montagna un
torrente così impetuoso che solo il rumore
infondeva terrore...
Il venerdì volle il Signore che
piovesse acqua dal cielo, mista con terra e
cenere; e si formò al suolo una melma così
compatta e dura ch’era impossibile romperla
anche con zappe e picconi... E così passammo il
Santo Natale, mentre il Vesuvio continuava a
vomitar fuoco”.
La Barra nella tragedia del 1631
30. Anche gli abitanti di Barra
cercarono scampo verso la vicina città.
“Essi presero la volta di
Napoli: ma non vi arrivarono soli. Il Viceré,
saputo di molti che, scampati dalle ruine e dal
fuoco, si erano raccolti sui lidi della Torre,
di Resina e di Portici, mandò due galee perché
li traghettassero alla Città: e così, tra quelli
che andarono colà per terra, e quelli che vi
andarono per mare, si contarono presso a 15.000
persone.
Dicono gli scrittori di quei
tempi, e si intende da sé, che era uno
spettacolo degno di compassione vedere quel sì
gran numero di miseri, quali mezzo nudi con le
vesti bruciate, quali con qualche mano mozza o
con qualche braccio monco, quali cercando
inutilmente il padre, la madre, la moglie, il
figlio perduto. Tutti languivano della fame, ed
essendosi sparsi per la città in cerca di alcun
ristoro, vi produssero una confusione
indescrivibile.
I preposti alla pubblica
beneficenza, accorsero tostamente in loro aiuto,
e mille dei più miserabili presero a loro
carico, ricoverandoli nel recinto delle scuole.
A questa loro carità si unì
quella dei privati. Il Monte della Misericordia
ne ricettò tremila, parte in un’ampia casa posta
nel luogo detto S. Gennaro fuori le mura, e
parte nei contorni della Madonna dell’Arco. Il
Monte dei Poveri Vergognosi raccolse quanti
poté, dei più riguardevoli per nascita o per
impieghi, nell’Albergo dei Pellegrini, fàttosi
cedere per questo dalla celebre Congregazione
dello stesso nome fondata da S. Filippo Neri.
Alcune nobili e ricche matrone aprirono a buon
numero di onorate donzelle le porte di un
edifizio che in un tratto apprestarono per esse
presso la chiesa e monistero di S. Severino. E
così altri, che a volerli noverare tutti a uno
per uno sarebbe un non finire giammai”
.
31. I nostri di Barra, essendo
abbastanza vicini a Napoli, furono certamente
fra quelli che si rifugiarono in città “per
terra”, andando a piedi, con asinelli o con
poveri carrettini, attraverso il ponte della
Maddalena sul fiume Sebéto, come si vede nella
illustrazione fàttane da Joackim von Sandrart
alcuni anni dopo.
32. Comunque, dopo i primi
provvedimenti di assistenza elencati sopra dal
Palomba, non furono prese dalle autorità
altre misure di aiuto o di coordinamento.
Trascorsi una quarantina di giorni, i profughi
cominciarono a rientrare nei rispettivi Casali,
e dovettero fare (ovvero ri-fare) tutto da soli.
33. I Barresi trovarono, a
conti fatti, che il loro Casale era stato,
nonostante tutto, meno colpito di altri. S.
Giorgio a Cremano, ad esempio, era stato quasi
completamente distrutto, e la sua chiesa
parrocchiale invasa da una lava di “acque
boglienti miste a sassi ed arene infocate”, che
aveva incenerito sessanta persone che ivi si
erano rifugiate
.
34. A Barra, invece, la lava
non arrivò, anche se il Giuliani
narra che: “Barra, che era stata toccata appena
dai torrenti di fuoco e cenere, veniva dalle
grosse correnti d’acqua allagàta, e negli
alberi e negli edifici stranamente e crudelmente
abbattuti, mediante le grossissime pietre
che seco ne portavano; anzi, dovunque
somiglianti piene strabocchevolmente passavano,
diversi valloni, dove più dove meno profondi,
horridamente si aprivano”.
35. Comunque, non subirono
danni sostanziali gli edifici che cominciavano a
costituire gli “elementi di identità” del
Casale: rimasero indenni le chiese (la
parrocchiale, S. Atanasio, S. Maria delle Grazie
dei Francescani, S. Maria della Sanità dei
Domenicani) e le case principali (la villa del
Roomer, villa Amalia, villa Filomena...).
Il colpo subìto, soprattutto
dai più poveri, era stato però molto duro: le
misere abitazioni dovettero essere ricostruite
in pratica da capo, ed i campi devastati
dovettero essere faticosamente recuperati, ove
possibile, alla coltivazione.
Il Villaggio di San Martino si
stacca da Barra: “le Pagliàre”
36. Si è detto
che la chiesa di S. Martino (appartenente al
casale di Casavaleria), già alla fine del
Cinquecento, era ormai diroccata.
Continuava ad esistere, però,
il piccolo gruppo di case che da essa prendeva
il nome e che, come tutto il casale di
Casavaleria, era stato unito a Barra intorno
alla metà del Cinquecento.
In occasione della eruzione del
1631, alcuni sopravvissuti abitanti di S.
Giorgio, non potendo subito ricostruire le loro
case là dove in precedenza erano, si insediarono
nelle campagne a monte di S. Martino, nel luogo
ancor oggi detto “le Pagliàre” dal nome delle
prime abitazioni provvisorie che essi si
costruirono.
Si stabilirono, quindi,
rapporti molto stretti fra costoro e gli
abitanti di S. Martino; in tal modo,
gradualmente, quest’ultimo si staccò da Barra e
fu aggregato a S. Giorgio a Cremano, come è
tuttora.
Da notare, però, che le rendite
dei terreni annessi alla chiesa diroccata
rimasero sempre a beneficio della parrocchia di
Barra
.
La protesta dei Casali nel 1637
37. Erano ancora tutte aperte
le ferite provocate dalla catastrofe naturale
(l’eruzione), quando arrivò nei Casali la
notizia di una vicina catastrofe sociale.
38. Nel 1637, il viceré conte
di Monterey giunse infatti alla determinazione
di procedere alla vendita di tutti i Casali
ancora demaniali (fra i quali era anche la
Barra).
Il viceré aveva bisogno di
soldi, per soddisfare le richieste che
continuavano a provenire dalla Spagna,
nonostante la condizione di prostrazione in cui
si trovava la città in seguito all’eruzione.
Pensò quindi di poter conseguire un rapido
“realizzo”, vendendo anche quei Casali vesuviani
che costituivano ormai, per lui, solo una
fastidiosa incombenza, visto che le rendite da
essi provenienti erano di molto scemate in
seguito alla catastrofe.
39. Il viceré non aveva però compreso che la
capacità di sopportazione delle popolazioni era
quasi del tutto esaurita e gli animi erano assai
vicini alla rivolta.
Contro la sua decisione, i
Casali di Torre del Greco, Resina, Portici, S.
Giorgio a Cremano, S. Giovanni a Teduccio,
Barra, La Villa, Ponticelli, S. Pietro a
Patierno, Casoria, Arzano, Afragola, Casalnuovo,
Cardito, Frattamaggiore, Pomigliano, Grumo,
Casandrino, Mugnano, Panecocoli, Marano, Polvica,
Piscinola, Chiaiano, Marianella, Mianella, Miano,
Secondigliano, Posillipo, Soccavo, Pianura e la
stessa Napoli, sollevarono una forte
opposizione legale, con una formale e
generale protesta, richiamandosi a tutte le
norme e “privilegi” ad essi storicamente
riconosciuti, ed arrivando in alcuni luoghi
anche alla sollevazione armata
.
40. Per sua buona sorte, il
Monterey venne richiamato in patria e, il 13
novembre 1637, lasciò l’incarico (e la bollente
“patata”) al suo successore Ramiro Nunez de
Guzman, duca di Medina de las Torres
(1637-1644).
41. Il duca di Medina riuscì ad
imporre la conferma della deliberazione del suo
predecessore, ma... una cosa era il decidere di
vendere, tutt’altra cosa era il vendere di
fatto.
Per far ciò, infatti, bisognava
anzitutto trovare il compratore, poi mettersi
d’accordo sul prezzo e sulle condizioni della
vendita, poi procedere alla esatta confinazione
del territorio che si vendeva, poi ottenere la
conferma da parte di Madrid, etc. etc.
Considerato, inoltre, che i
Casali erano in subbuglio e che le rendite dei
loro terreni, dopo l’eruzione, erano divenute
assai meno appetibili per i possibili
compratori, non stupisce affatto il constatare
che le cose andarono piuttosto per le lunghe.
42. Basti qui menzionare il
caso di S. Giorgio a Cremano, documentato dal
Palomba
:
solo il 25 settembre 1645 giunse da Madrid il
diploma con il quale questo Casale veniva
concesso in feudo ad Antonio Caracciolo, a
condizione peraltro che si procedesse alla
confinazione.
Ma sia la “Universitas” del
Casale, sia la vicina Pietrabianca, sia la
stessa città di Napoli, elevarono opposizione
legale contro la decisione, con varie e diverse
motivazioni, giungendo fino a sostenere la
nullità della concessione fatta al Caracciolo, e
solo il 4 febbraio 1647 si addivenne ad una
transazione tra la “Universitas” di S. Giorgio
ed il suo aspirante feudatario, per mano del
notaio Brancale.
Ormai, però, era alle porte la
generale sollevazione delle plebi, nota col nome
di Masaniello, e dopo... nulla poté più essere
come prima.
43. Dopo la sollevazione di
Masaniello, per placare gli animi ed evitare
ulteriori turbolenze, il Serenissimo Don
Giovanni d’Austria, figlio naturale del re,
inviato apposta da Madrid, “mise fuori” (11
aprile del 1648) una serie di “grazie” per la
“fedelissima città di Napoli, le Università ed
uomini tutti del Regno”.
Fra queste, ve n’era una che
così diceva: “Facciamo anco grazia a tutti li
Casali di questa fedelissima città di Napoli,
che si possano ricomprare (cioè, ritornare al
demanio), pagando il prezzo o migliorazioni
fatte... dispensando per questa volta... da ogni
altra legge in contrario”
.
44. Se dunque venne concessa ai Casali già
infeudati, come S. Giorgio, la facoltà di
riscattarsi tornando in demanio, a maggior
ragione si può ritenere che non si procedesse ad
ulteriori vendite di quei Casali che erano
rimasti demaniali.
Tale era il caso di Barra,
che infatti non fu mai venduta, rimanendo
costantemente in demànio anche in quei
perigliosi frangenti.
45. Dalle carte della lite
riguardante S. Giorgio, si evince infatti
incidentalmente che, ancora nel 1646, la
Barra, S. Giovanni a Teduccio e Pietrabianca
erano “burgo e piazza di detta fedelissima
città” di Napoli, cioè erano ancora demaniali;
ed abbiamo già escluso che possano essere stati
venduti dopo (vedi, peraltro, quanto avvenne nel
1678: n°122). Così, ormai nel 1794, il Galanti
registrerà 20 Casali demaniali e solo 10
baronali
.
46. Ma veniamo ora a dire, più
per esteso, di quella sollevazione di Masaniello
che, come si è visto, anche per i Casali
produsse qualche frutto positivo.
La “sollevazione” di Masaniello
nel 1647
47. Il cardinale Ascanio
Filomarino, arcivescovo di Napoli dal 1641 al
1666, così scriveva al papa Innocenzo X
(1644-1655), per informarlo degli eventi:
“Questa sollevazione ebbe
principio da venticinque in trenta fanciulli,
ciascheduno dei quali non passava li quindici
anni, e che si erano uniti nella piazza del
mercato, con le canne in mano, per fare una
festa, solita farsi ogni anno, con alcuni
giuochi puerili, in onore della Beatissima
Vergine.
Detti fanciulli, trovatisi a
caso presenti al luogo dove si pagava la gabella
dei frutti, mentre per certa differenza occorsa
col gabelloto ne furono gettati via alcuni
sportoni, prèsane buona parte, ne facevano
allegrezza grande fra loro.
Un tal Masaniello pescatore,
giovane di venti anni (precisamente, 27),
ch’era anche lui presente, fàttosi capo di detti
fanciulli e di altri che accorsero e s’unirono,
e montato sopra di un cavallo che stava nella
piazza, disse che si levi la gabella dei
frutti.
Ad un batter d’occhio, si
unirono con lui migliaia e migliaia di persone
di popolo, e tutte sotto la sua guida
s’incamminarono verso il palazzo del viceré; per
strada givano sempre crescendo, onde in poche
ore arrivarono al numero di cinquanta in
sessantamila, e si sollevò tutta la città, e fu
domenica 7 del passato (luglio 1647),
conforme scrissi a Vostra Santità”
.
Le premesse
48. In effetti, è evidente che le popolazioni
del regno avevano ormai esaurito le loro, pur
secolari, riserve di sopportazione e di pazienza
nei confronti dell’oppressione di aristocratici
e borghesi, tanto stranieri che indigeni.
Sia l’immensa plebe della città
che i contadini delle campagne (“padulani” o
“cafoni” che fossero) avevano ormai accumulato,
in diversi modi e tempi, troppi motivi di
malcontento, dai quali non si intravedeva
alcun’altra via di uscita se non quella della
rivolta.
49. La goccia che fece
traboccare il vaso fu la famosa “gabella dei
frutti” che il viceré in carica, Rodrigo Ponce
de Leon, duca d’Arcos (1646-1648), quale
uno dei primi atti del suo governo, aveva
re-introdotto, dopo che era stata abolita nel
1619 dal viceré Pedro Tèllez Giròn secondo duca
di Ossuna.
50. Subito dopo, vi furono attentati contro
alcune baracche dove si riscuoteva la gabella e,
il giorno 26 dicembre 1646, una folla inferocita
bloccò la carrozza del viceré, davanti alla
basilica della Madonna del Carmine, mentre
questi si recava alla Messa per le festività
natalizie; in quel pericoloso frangente, il duca
d’Arcos promise di abolire l’odiosa gabella ma
“ovviamente”, una volta messosi in salvo, non
mantenne la promessa fatta.
La domenica 7 luglio 1647
51. Si giunse così alla
domenica 7 luglio 1647. A quanto pare,
l’episodio che diede il via alla sollevazione
non fu così “a caso” come allora poté sembrare.
L’incidente con il “gabelloto”
fu provocato ad arte da un certo Maso Carrese,
di Pozzuoli, che era cognato di Masaniello,
ed anche la festa dei ragazzi in onore della
Madonna del Carmine, pur usuale, era stata
quell’anno organizzata dallo stesso Masaniello,
come risulta dalla “Cronistoria del Real
Convento del Carmine Maggiore di Napoli”, la
quale attesta che un certo fra’ Savino,
un converso carmelitano amico del pescivendolo,
gli aveva prestato 20 carlini (poi restituiti)
per comprare le canne necessarie per la festa.
Giulio Genoino
52. Ma soprattutto, “ne’ primi
mesi del 1647, fu veduto spesse volte, verso
l’imbrunire, stringersi a secreto colloquio con
Masaniello nella chiesa del Carminello al
Mercato... un vecchio, in abito da prete e con
lunga barba...”
.
Era questi l’ormai ottantenne
Giulio Genoino, giurista oltre che prete.
In gioventù, era stato “Eletto
del popolo” e, alleandosi con l’ambizioso e già
menzionato vicerè Pedro Tèllez Giròn, secondo
duca di Ossuna (1616-1620), non solo aveva
allora conseguito l’abolizione della gabella
sulla frutta, ma aveva cercato di perseguire un
ben preciso progetto politico di riforma,
consistente nella richiesta di parità di voti
fra nobili e popolo nell’amministrazione
della città.
La richiesta era, per l’epoca,
decisamente molto avanzata ed anzi sconvolgente
per gli equilibri del potere, come si vide dalle
fortissime resistenze che incontrò e che ne
determinarono la sconfitta.
53. Il duca di Ossuna venne
dimesso dall’incarico ad opera della corte di
Madrid e, tornato in patria, venne addirittura
processato e finì i suoi giorni in prigione, nel
1624; anche il Genoino subì varie traversie,
persecuzioni ed una lunga carcerazione, che non
valsero tuttavia a fiaccare il suo spirito di
convinto oppositore dell’aristocrazia.
54. Ora, vecchio ma non domo,
egli “aveva scorto l’influenza che il giovane
pescivendolo esercitava sulla plebe del Mercato
e del Lavinaro, l’avversione che nutriva contro
i nobili ed i prepotenti, l’animo pronto ed
ardito, ed il buon senso che nascondeva sotto le
apparenze della spensieratezza e della
buffoneria; lo indettava, quindi, e lo preparava
a’ futuri casi ed a’ moti facilmente
prevedibili”
.
La settimana del popolo: 7-13
luglio 1647
55. Da queste premesse, nacque
la sollevazione del 7 luglio, al grido di “Viva
il re e muoia il mal governo!”
Per una settimana, fino al
sabato 13 luglio, Tommaso Aniello d’Amalfi,
detto Masaniello, nato il 29 giugno 1620 in Vico
Rotto al Mercato, da Cicco d’Amalfi e Antonia
Gargano, di professione pescivendolo, fu il vero
capo della città, alla testa della plebe.
56. Il cardinale Ascanio Filomarino ne dà questa
positiva testimonianza:
“Questo Masaniello... ha
dimostrato prudenza, giudizio e moderazione; in
somma era divenuto un re in questa città, e il
più glorioso e trionfante che abbia avuto il
mondo. Chi non l’ha veduto, non può figurarselo
nell’idea, e chi l’ha veduto non può essere
sufficiente a rappresentarlo perfettamente ad
altri.
La confidenza ed osservanza e
il rispetto ch’egli ha avuto in me, e
l’ubbidienza che ha mostrato in ordinare e far
eseguire tutte le cose che gli venivano dette e
suggerite da me, è stato il vero miracolo di Dio
in questo così arduo negozio, il quale era
altrimenti impossibile di condurre a fine in sì
poche ore, come si è fatto, con tanta lode e
gloria di Sua Divina Maestà e della Beatissima
Vergine che l’hanno guidato e protetto”
.
57. “Un drappello di circa 50
garzoni e fanciulli, capitanati da Giovanni
d’Amalfi a cavallo, eseguiva fedelmente gli
ordini di Masaniello.
Scalzi, in sola camicia e
mutande di tela, e col berretto rosso in testa,
essi, facendosi ministri di una nuova giustizia,
andavano processionalmente per le vie, preceduti
da uno stendardo (pennone), nel quale si
vedevano dipinte le armi reali di Spagna, e
portavano chi torce di pece, chi graffii o
forcine, chi solfanelli, fascine impeciate ed
altre cose bisognevoli ad accendere, e chi
finalmente picconi e sciamarri.
Erano cenciaiuoli o
bazzareoti (venditori ambulanti di
commestibili), gente della più vile e povera
condizione, che viveva stretta ed ammucchiata in
alcuni di quei luridi covìli del Mercato e del
Lavinaro, che si dicevano e si dicono tuttora
fòndachi, e che la progredita civiltà ha ora
diminuiti, o in buona parte migliorati, ma non
ancora interamente distrutti.
Laceri e seminudi, furono i
primi che allora si chiamassero làzzari
,
e questo nome, che i superbi dominatori
spagnuoli diedero loro come un’ingiuria, i
plebei sollevati della città e del regno,
imitando i bruzii dell’antica Italia ed i
gueux delle Fiandre, lo adottarono
volentieri, come un titolo onorifico, e come un
distintivo di animo libero ed indipendente”
.
58. Oltre a quella, sopra
descritta, guidata da Giovanni d’Amalfi,
fratello di Masaniello, il Capasso menziona “sei
compagnie, comandate da Scipione Giannattasio
del Lavinaro e da altri capitani più fedeli.
Componevansi di giovinetti da 16 a 22 anni,
antichi compagni del pescivendolo, per lo più
cenciaiuoli o saponari, che portavano
ordinariamente come special distintivo il
graffio e la sporta”.
59. Durante quella settimana, i
drappelli di lazzari procedettero a
devastare e bruciare tutti gli uffici del dazio
(i luoghi dove si pagavano le gabelle) nonché le
ricche abitazioni dei più noti “arrendatori” e
di coloro che “si erano arricchiti sulla fame
del popolo”, incluso quella dell’ “Eletto del
popolo” allora in carica, Andrea Naclerio,
accusato (ed era vero) di essere corrotto dagli
arrendatori.
60. Fra gli altri, anche l’arrendatore
Gaspare Roomer giudicò opportuno, in quei
giorni, lasciare il suo palazzo di città, sito
in via Monteoliveto, e rifugiarsi nella sua
villa alla Barra
.
61. Infine, il sabato 13
luglio, il viceré giurò sui Vangeli, in Duomo,
di rispettare e far rispettare i nuovi
“Capitoli”, dettati dal Genoino, che
comprendevano sia la liberazione dalle
“gravezze” (l’abolizione di tutti i dazi imposti
dopo Carlo V), sia la parità fra nobili e popolo
nell’amministrazione della città.
La reazione: uccisione di
Masaniello (martedì 16 luglio 1647)
62. Passata però quella
inaudita settimana di egemonia popolare, viceré,
nobili e ricchi borghesi cominciarono a
riprendersi dallo sconcerto e ad organizzare
adeguatamente la loro reazione.
63. A dar loro una mano,
sopravvenne in Masaniello un vero e proprio
stato di squilibrio mentale: “la gran mole dei
pensieri, la lunga inèdia, l’abuso del vino e le
veglie protratte, e forse, più che tutto ciò, il
veleno dell’adulazione, di cui era stato così
largamente abbeverato dal viceré, perturbarono
il suo cervello”
.
Egli cominciò a compiere azioni strane, quali
denudarsi in pubblico, orinare davanti a tutti
in un angolo prima di entrare in Duomo, tenere
discorsi sconnessi.
Soprattutto, però, ordinò atti
arbitrari: stragi, esecuzioni sommarie senza
motivo, devastazioni e confische ingiustificate
di beni, che suscitarono disgusto e paura nei
suoi stessi sostenitori ed alleati.
64. Di conseguenza, andò a buon
fine la trama ordita dal viceré, con il tacito
consenso dello stesso Genoino e la attiva
complicità dell’ex -”Eletto del popolo” Andrea
Naclerio e di alcuni stretti collaboratori di
Masaniello, invidiosi del suo potere o comprati
dal viceré.
65. Il martedì 16 luglio
(festa della Madonna del Carmine), mentre il
cardinale Ascanio Filomarino celebrava Messa al
Carmine Maggiore, davanti ad una strabocchevole
folla, Masaniello si mise ad arringare il
popolo.
“I frati lo invitarono a porre
termine a quel gesto poco edificante, ed egli
obbedì, mettendosi a passeggiare nel corridoio
principale del convento, al primo piano.
Là lo raggiunsero ben otto
persone armate, che prima gli tirarono quattro
colpi di archibugio, privandolo di vita, poi lo
decapitarono.
La testa, mostrata al viceré,
fu portata alle Fosse del Grano; il corpo, dopo
essere stato trascinato in ludibrio per le
strade, fu gettato in un fosso qualsiasi della
città.
66. Non erano passate
ventiquattr’ore e subito si videro i frutti
dell’uccisione di Masaniello: il peso del pane
diminuito e le gabelle rimesse in vigore.
Compreso il male commesso
contro il suo difensore, il popolo ne raccolse
il cadavere, lavandolo nelle acque del Sebéto;
vi riunì il distaccato capo, e lo trasportò al
Carmine...
Quindi si vide uscire dal
Carmine un corteo di ben 400 preti, e 100
ragazzi del celebre conservatorio di S. Maria di
Loreto; seguiva il cadavere (vestito con le
insegne di Capitano Generale) e, dietro, il
bel numero di 4000 soldati ed un popolo che non
finiva mai.
Dopo un lungo giro per la
città, il mesto corteo rientrò nel Carmine a
tre hore di notte, come allora si diceva, e
Masaniello fu sepolto nello spazio tra il lato
sinistro della balaustra dell’altare maggiore e
la cappella detta del presepio, oggi di S. Ciro”
.
Le fasi della rivolta dopo la
morte di Masaniello
67. La rivolta popolare non si
spense però con la morte di Masaniello,
deludendo così sia l’assassino e spergiuro
viceré d’Arcos, sia l’astuto Giulio Genoino che
pensava adesso di poter guidare il popolo, senza
Masaniello, secondo i suoi progetti. Non è però
questo il luogo per narrare dettagliatamente le
vicende, così intense, che si svolsero appresso;
bastino quindi i pochi cenni che seguono.
68. Il 21 agosto si ebbe una
seconda fase della sollevazione, al grido
non più di “Viva il re e muoia il malgoverno” ma
“Viva il popolo e morte agli spagnuoli” :
si arrivava quindi alla guerra aperta contro i
dominatori, fino a quando il viceré, il 7
settembre, giurò nuovi capitoli d’intesa.
69. Questa seconda fase della
rivolta travolse il vecchio Genoino, che il
popolo riteneva complice nell’uccisione di
Masaniello e che il viceré allontanò da Napoli,
facendolo imbarcare per la Spagna, dove però
giunse cadavere, per i tanti travagli subìti
alla sua veneranda età.
70. Ma presto fu evidente che
il viceré non intendeva mantenere nemmeno i
nuovi giuramenti fatti.
Il primo ottobre giunse nel porto la flotta
guidata da don Giovanni d’Austria, figlio
naturale del re Filippo IV di Spagna. Istigato
dal viceré, il giovane comandante intimò al
popolo di consegnare le armi e, avùtane risposta
negativa, iniziò a cannoneggiare la città.
71. La situazione si
radicalizzava, in tal modo, sempre di più; il 22
ottobre il popolo proclamava la “serenissima
real repubblica”, invocando alla sua guida il
francese Enrico di Lorena, duca di Guisa,
che approdò al ponte della Maddalena il 15
novembre, accolto dal grido “Viva Dio e il
popolo”.
72. La guerra fra le due parti
continuò, con tutti i mezzi delle armi, delle
astuzie, della diplomazia e dei tradimenti, fino
al 6 aprile del seguente anno 1648, quando gli
spagnoli ripresero interamente la città ed il
Guisa fu fatto prigioniero.
73. Nel frattempo, il 24
gennaio 1648, il duca d’Arcos era stato
richiamato in patria ed al suo posto nominato
viceré, a partire dal primo marzo, Inigo Velez
de Guevara, conte di Onate (1648-1653),
che ebbe l’ingrato compito di gestire la
“normalizzazione” spagnola.
La Barra nella rivolta di
Masaniello
74. Nicola Lapegna riporta i
nomi di due giovani barresi, Silvestro
Mastrogiacomo e Raffaele Fiscone,
“noti per audacia e coraggio dimostrato e per la
loro fedeltà e grande attaccamento a Masaniello
nei sei giorni della sua dominazione”
.
75. Al di là di questi nomi,
comunque, è del tutto plausibile che in quei
drappelli di giovani e ragazzi che componevano
“l’armata” di Masaniello, oltre che naturalmente
nel gran mare di vasto popolo che lo seguì, vi
fossero anche “padulani” della Barra, che si
recavano abitualmente a Napoli per smerciare i
prodotti della loro terra ed avevano quindi
stretti rapporti con i lazzari, cenciaiuoli,
bazzareoti o saponari che fossero.
76. D’altronde, la rivolta non tardò ad
estendersi anche ai Casali di Napoli, nei quali,
come si è detto, non mancavano motivi specifici
di malcontento
,
sia per l’aggravarsi anche in quei luoghi delle
gabelle, in dispregio degli antichi privilegi
goduti, sia soprattutto dopo la risoluzione di
vendita del conte di Monterey.
77. Dell’estensione dei tumulti anche a Barra è
testimonianza la vicenda del Roomer, riportata
dal Ceci nella sua biografia:
78. “Gaspare Roomer, ancora il 16 luglio
1647 (giorno della morte di Masaniello), si
trovava nella sua villa alla Barra come in luogo
di rifugio, raggiunto dopo aver lasciato il suo
palazzo napoletano, sito alla via Monteoliveto
(vedi n°60).
Qui ebbe, appunto il 16 luglio,
la visita di un converso carmelitano, fra’
Savino, confidente di Masaniello (vedi n°51)
che, con un ordine scritto dal segretario di
questi, Marco Vitale, gli impose di consegnare
5000 zecchini per servizio di Sua
Maestà.
Il denaro fu subito sborsato,
dietro regolare ricevuta; ma il converso, giunto
al ponte della Maddalena, seppe della morte di
Masaniello avvenuta proprio in quel giorno e,
paventando un eguale destino, se ne fuggì a Roma
col peculio.
Il denaro fu poi in buona parte
recuperato dal Roomer, che era stretto in
vincoli di amicizia coi superiori e con parecchi
padri dell’Ordine Carmelitano”.
79. Ma “presto, anche la dimora
alla Barra non sembrò sicura” per un ricco
arrendatore come lui, ed egli lasciò anche
questa, riparando in Castel Nuovo insieme ad
altri notabili cittadini e poi addirittura su
una nave di sua proprietà al largo del golfo.
80. E’ molto probabile che il
Roomer lasciasse la Barra dopo che, il 21
agosto, ripresero i tumulti e la rivolta
popolare entrò in una nuova ed ancora più
turbolenta fase, che sfociò in aperta guerra
civile.
81. E’ fuori dubbio, quindi, la
partecipazione di Barra e di Barresi alla
sollevazione del 1647 e tale partecipazione non
fu inutile, viste le concessioni, anche a
vantaggio dei Casali, che il plenipotenziario
spagnolo, don Giovanni d’Austria, fu costretto a
fare dopo quelle memorabili giornate (vedi nn°43-44).
|
 |
|
Micco Spadaro,
"La rivolta di Masaniello". Napoli, Museo di San Martino
|
La grande peste del 1656
82. Salvatore de Renzi
,
“che raccolse con molta diligenza in un sol
volume tutte le notizie che intorno alla peste
del 1656 poté rintracciare sia nei libri
stampati, sia in memorie e documenti inediti”
scrive che i morti in Napoli furono 450.000, su
una popolazione stimata, intorno alla metà del
Seicento, di circa 500-550 mila persone. Il
Capasso restringe le vittime a 350-400 mila. In
ogni caso, si tratta sempre di ben più della
metà della popolazione allora presente
(morirono, in pratica, circa 7 persone su ogni
10).
|
 |
|
Micco Spadaro,
"Piazza Mercatello durante la peste del 1656". Napoli, Museo di San
Martino
|
83. Questo semplice dato è
sufficiente a dare le dimensioni della
drammaticità dell’evento che, appena nove anni
dopo la sollevazione di Masaniello, sopraggiunse
ad unificare oppressi ed oppressori nella comune
fragilità della condizione umana, facendo molte
più vittime, anche nei nostri Casali, della pur
disastrosa eruzione del Vesuvio nel 1631.
84. Erano certamente le
precarie condizioni igieniche, la promiscua
convivenza di uomini e bestie, la disastrosa
condizione abitativa e, in città, il pauroso
addensamento della popolazione su aree
ristrette, le condizioni che favorivano la
recrudescenza della peste, del resto endemica
fin dal Trecento in tutta Europa
.
85. A quel tempo, come ovvio, le interpretazioni
furono diverse: parlarono, alcuni, di veleni
sparsi volutamente dal viceré e dalle classi
dirigenti, per trarre vendetta dei recenti
tumulti; dissero, altri, di una giusta punizione
del Cielo stesso per le violenze e le
disobbedienze allora compiute.
86. Certo è che il medico
Giuseppe Bozzuto, che aveva per tempo
compreso il pericolo ed avvisato le autorità
affinché si prendessero le possibili
precauzioni, fu addirittura fatto imprigionare
dal viceré Garcia de Avellaneda y Haro, conte
di Castrillo (1653-1659), come
perturbatore della pubblica quiete. Il Bozzuto
fu poi liberato quando la peste scoppiò,
essendosi verificato che aveva ragione, ma ne
morì lui stesso poco dopo.
87. Lo stesso viceré, nei primi
giorni della pestilenza, per stornare i sospetti
che il popolo nutriva sulle autorità, pubblicò
“che vi erano cinquanta persone che in abiti
mentìti andavano seminando le polveri velenose”,
appositamente inviati dalla Francia e dal
Portogallo, nazioni nemiche della corona
spagnola
.
88. “Allora sì che i poveri
forestieri la passarono male: poiché bastava
portare l’abito, le scarpe, il cappello, la
cappa, o qualche altra cosa differente dall’uso
comune de’ cittadini, per correr pericolo della
vita.
All’uscir della chiesa di S.
Maria di Costantinopoli in Napoli (quella
stessa nella quale si andava ad implorare la
Madonna contro la peste: vedi n°106)
v’inciampò un tal Vittorio Angelucci, molti
preti e diversi mendìchi, e tra questi un
infermo uscito poche ore prima dallo Spedale
della SS. Annunziata, che a colpi di bastone
perdé la vita.
Una povera donna, la quale in
mezzo al Mercato si spolverava la gonna, fu
fatta in pezzi insieme con un bambino ch’ haveva
in braccio”
.
89. “Intanto la peste
continuava la sua opera sterminatrice. Si moriva
con uno starnuto, col solo dare un sospiro, con
vertigini. L’infermo era assalito da tremore,
gli venivan meno immediatamente le forze, e
seguiva subito la morte.
I morti eran così numerosi, che
furon fatti uscire dalle carceri i ladri ed i
banditi, perché trasportassero o trascinassero i
cadaveri.
Abbiam detto trascinassero
perché spesso si era costretti proprio a tirar
per terra, con un uncino, i poveri colpiti e
spesso tra i cadaveri furon trovati esseri che
davano ancora segni di vita”
.
90. Furono allestiti almeno
dieci ospedali e parecchi lazzaretti, tra i
quali uno a Borgo Loreto. Presto, non bastarono
più le usuali sepolture sotto le chiese e furono
scavate grandi fosse comuni.
91. S. Maria degli Angeli,
all’Orto botanico, viene tuttora detta “alle
croci”, perché lungo la salita davanti alla
chiesa venne in quell’anno scavata una enorme
fossa comune per seppellirvi i morti, e sopra vi
furono collocate numerosissime croci.
92. Così pure, le quattro fosse
dell’annona nella grande piazza Mercato si
colmarono di ben 47.000 corpi e, da quel tempo,
il luogo ebbe la triste denominazione di “morticelli”.
“La pietà dei superstiti chiuse allora la piazza
con un muro di recinzione e tutte le sere vi si
vedevano accesi innumerevoli lumini”
.
 |
|
Micco
Spadaro Rendimento
di grazie dopo la peste (I monaci di San Martino rendono grazie per lo
scampato pericolo della peste, 1657). Napoli Certosa e Museo Nazionale di
San Martino |
La peste del 1656 a Barra
93. La peste, a Napoli e nel
circondario, durò all’incirca dagli inizi di
maggio fino ad ottobre. Il focolaio era Napoli,
che però solo con molto ritardo venne isolata,
per cui la malattia poté propagarsi anche nei
Casali, portata dai padulani che andavano
a vendere in città i loro prodotti.
94. La mortalità cominciò a
crescere in giugno e raggiunse le punte massime
nel periodo più caldo, il mese di luglio e la
prima metà di agosto; poi, dopo un benefico
acquazzone purificatore, iniziò gradualmente a
diminuire. L’epidemia fu dichiarata
ufficialmente scomparsa l’8 dicembre (festa
dell’Immacolata).
95. Nel Casale della Barra, i registri
parrocchiali riportano 183 morti (115 donne e 68
uomini), da confrontarsi con i dati dei tempi
“normali”: 23 morti nel 1655 (l’anno prima) e 20
nel 1657 (l’anno dopo).
118 persone morirono nel solo
mese di giugno, fra i quali anche il parroco
Vincenzo Imperato, entrato in carica poco
tempo prima, nel maggio 1654, e la cui firma
compare per l’ultima volta sui registri in data
26 giugno 1656.
96. Il dato di giugno è probabilmente assai
prossimo al reale, ma quello complessivo è
certamente superiore a 183, perché la mortalità
raggiunse le punte massime a luglio ed agosto e
“quanti ne morissero nei mesi di luglio e di
agosto non si può dire, perché i libri
parrocchiali di quel tempo vanno a salti e a
lacune; ciò che dimostra, che il numero degli
infermi che si dovevano assistere e de’ morti
che si dovevano seppellire tanto era grande, che
non lasciava né tempo né testa per registrarlo”
,
data anche la morte del parroco.
97. Nel vicino casale di S.
Giorgio a Cremano, nel mese di giugno morirono
circa 140 persone (su una popolazione di 600) ed
il Palomba
stima intorno a 300 il numero complessivo delle
vittime.
Considerato che il numero degli
abitanti di Barra era superiore (intorno alla
metà del Seicento, può essere stimato intorno ai
1800, quindi circa il triplo di quelli di S.
Giorgio) e che Barra si trovava più vicina a
Napoli e quindi più prossima al focolaio
dell’epidemia, sembra realistico congetturare
intorno a 7-800 il numero complessivo delle
vittime Barresi del flagello.
98. Non pare, quindi, che si
arrivi a superare la metà degli abitanti, come
invece (e di gran lunga) avvenne in Napoli, ma
naturalmente la tragedia fu del tutto analoga,
anzi forse peggiore, considerato che qui la
terra aveva bisogno di braccia, per dare quei
frutti che consentivano di sopravvivere.
Intere famiglie furono
cancellate ed in quelle restanti nessuna vi fu
che non piangesse morto un padre, una madre, un
fratello, un figlio, una moglie, un marito...
”tolto al proprio amore e al proprio bisogno, di
una maniera sì cruda, e senza verun riparo”
.
99. Il luogo della sepoltura,
sotto il pavimento della nuova parrocchia,
l’accesso al quale era costituito dalla lapide
con la scritta UNIVERSITAS 1642 che solo pochi
anni prima era stata posta, si riempì quasi
d’improvviso dei resti mortali di tante persone
care, appartenenti ad ogni famiglia del Casale.
100. Vi furono certamente, come
sempre in occasioni simili, episodi di violenza
e di sciacallaggio, di appropriazione indebita
dei beni delle famiglie estinte e addirittura di
omicidio, ma risplendette anche quello spirito
di fraternità che fa affrontare e superare
insieme le sofferenze più gravi.
101. “Questa scena di morte,
dispiegata con tanta solennità sugli occhi di
tutti, valse in mano a Dio per operare la salute
di molte anime qui nel Casale nostro, come tutto
altrove nel regno. Lascio stare che niuno fu, il
quale non s’affrettasse allora ad aggiustare le
partite della sua coscienza, e tenersi preparato
a quel che potrebbe essere di lui da un istante
all’altro. Ma si videro anche, in ogni luogo,
atti di pietà singolare sì privata che pubblica”
.
102. In particolare, come
abbiamo visto, il parroco Vincenzo Imperato
seppe accompagnare e confortare il suo popolo
nella tragedia, come vero pastore del gregge,
fino a morire lui stesso nell’epidemia.
103. La ripresa fu comunque
sorprendentemente rapida: il primo matrimonio
successivo alla peste è registrato già in data
31 agosto 1656 e nel successivo anno 1657 il
numero dei bambini nati fu di 108, superiore
cioè alla media degli anni precedenti, che era
di 80-90. Il nuovo parroco venne nominato nel
novembre del 1656 e fu don Carlo Riccardo,
che rimase poi in carica fino al 1684.
La chiesa di S. Maria di
Costantinopoli in Barra
104. La più importante memoria
storica, relativa alla grande peste del 1656,
esistente in Barra, è la chiesa di S. Maria di
Costantinopoli “allo Scassone”.
105. Si è già detto
della omonima e maggior chiesa presente in
Napoli, collegata alla peste del 1526-28 ed a
quella successiva del 1575, dalla quale la città
ed il regno rimasero indenni. A partire dal 1575
e fino ai primi decenni del Seicento, venne
edificata e progressivamente abbellita la grande
chiesa napoletana dedicata MATRI DEI OB URBEM AC
REGNUM A PESTE SERVATUM.
106. Si può facilmente
immaginare quanto fosse estesa la devozione
popolare verso quella particolare immagine della
Madonna
[49], considerato il fatto che la
peste era fenomeno endemico, con frequenti
recrudescenze.
In particolare, in occasione
della grande peste del 1656, “tutto il popolo
accorreva in quella chiesa dal sorgere al
tramonto del sole, e le donne vi andavano scalze
e scarmigliate, ed uno storico dice che
imitavano i cori delle undicimila vergini di S.
Orsola; alle quali seguivano innumerevoli coorti
di matrone e turbe di uomini coverti di sacchi,
con cilicii ed altri strumenti di penitenza;
vedresti in ogni giorno, dice il Florio, dal
nascere al tramonto del sole, sciami di persone
pie che corrono a visitare questa chiesa”
.
107. Nulla di strano, quindi,
che anche gli abitanti del piccolo borgo di
Barra detto “lo Scassone” ben conoscessero quel
tempio napoletano e la particolare immagine di
Maria in esso venerata e che, in occasione
dell’infuriare della peste, si siano recati colà
in pellegrinaggio per impetrare la fine del
flagello.
108. Occorre ora dire che, già
nel Cinquecento, nel borgo dello Scassone
vi era una piccola immagine della Madonna delle
Grazie, posta in una semplice nicchietta sul
muro di una casa abitata da un certo Tommaso
Mandaro.
Cessata la peste del 1656, le
famiglie del luogo pensarono di edificare una
chiesetta in ringraziamento a Maria, là dove
c’era solo quella piccola immagine sul muro, e
di intitolarla appunto alla Madonna “di
Costantinopoli”, che “preserva dalla peste”.
La chiesetta venne aperta
ufficialmente al culto nel marzo del 1658, come
si rileva dagli Atti intercorsi fra la Curia
diocesana e i “magistri” del posto, custoditi
nell’Archivio Storico Diocesano.
109. L’immagine della Madonna
delle Grazie intorno alla quale fu edificata la
chiesa è ancor oggi visibile sulla parete, a
sinistra di chi entra nella chiesa stessa.
Infatti, molto probabilmente,
in occasione della costruzione, furono anche
dipinti i due affreschi che attualmente si
vedono e che sono tornati alla luce solo nel
1982 (al tempo del parroco don Salvatore Russo),
nel corso dei lavori di restauro successivi al
terremoto del 1980.
110. Il primo affresco
completava la pre-esistente immagine mariana,
aggiungendovi la figura di un prete che celebra
Messa (ritratto al momento della elevazione
dell’Ostia consacrata), assistito da due
chierici in ginocchio; il secondo, sulla parete
di fronte, è ormai del tutto sbiadito e se ne
vede solo il margine esterno, ai due lati del
quale si notano una figura maschile ed una
femminile in abiti seicenteschi e, in alto, la
colomba simbolo dello Spirito Santo.
111. La chiesa, nel 1658, era
molto più piccola di quella che attualmente si
vede; fu nel quinquennio 1849-54 che essa venne
ingrandita di circa due terzi, come si dirà in
seguito
.
Dopo la peste
112. Lo spopolamento provocato
dalla peste del 1656, anche se venne colmato in
non molti anni da una vivace ripresa della
natalità, contribuì comunque a rendere poco
praticabili, e meno redditizi, ulteriori esosi
prelievi fiscali.
113. Soprattutto però, dopo che
la plebe ebbe preso coscienza della sua forza,
dimostrata con la sollevazione di Masaniello nel
1647, i viceré successivi dovettero porre
maggiore attenzione a non irritarla
eccessivamente ed a perseguire una politica di
maggiore equilibrio fra le diverse classi
sociali.
114. Cosa, questa, che fecero
soprattutto i due viceré che gli storici
ritengono i più “illuminati” della seconda metà
del Seicento e cioè Inigo Velez de Guevara,
conte di Onate (1648-1653), il viceré della
“normalizzazione”, e Gaspar de Haro, marchese
del Carpio (1683-1687).
Ed il meno “illuminato” Antonio
Pedro Alvarez de Toledo, marchese di Astorga
(1672-1675), fu costretto ad introdurre in
Napoli il gioco del lotto, quando ebbe bisogno
di “qualche espediente per scorticare e non
guastare la pelle” onde trovare i 350.000 ducati
che gli erano stati richiesti dalla corte di
Madrid
.
Le congiure nobiliari
115. La controprova più
convincente delle migliorate condizioni del
popolo è data, forse, proprio dal fatto che a
protestare e a ribellarsi, in questo periodo,
furono principalmente i nobili, soprattutto con
le due celebri congiure che, per così dire,
aprono (1649) e chiudono (1701) la seconda metà
del Seicento.
116. La prima, guidata
da Alfonso d’Avalos, principe di Montesarchio,
nel 1649, si poneva l’obiettivo di portare sul
trono di Napoli proprio quel don Giovanni
d’Austria, figlio naturale di Filippo IV di
Spagna, che l’aveva “pacificata” nel 1647-48,
sconfiggendo il duca di Guisa
.
117. La seconda, a
carattere marcatamente filo-austriaco, fu detta
“congiura di Macchia”
dal nome di Gaetano Gambacorta, principe di
Macchia, e si svolse il 23-24 settembre
1701.
118. Entrambe queste congiure
nobiliari, pur diverse tra loro, furono però
egualmente retrograde: tendenti, cioè, a
ripristinare una condizione di assoluto
privilegio della nobiltà, che gli eventi storici
avevano, sia pur parzialmente, messo in
discussione; sicché il popolo, nella prima, non
ebbe comunque parte attiva e, alla seconda, si
rifiutò completamente di partecipare.
119. E’ molto significativa la
celebre risposta, riferita dal Colletta
,
che un anziano plebeo dette a Saverio Panzuti,
“Eletto del popolo” e partecipe della congiura
di Macchia, quando questi si recò, insieme ad
altri, in piazza Mercato per chiedere l’adesione
del popolo.
120. Disse dunque il vecchio
làzzaro: “Voi, Eletto, e voi, popolo,
ascoltate. Sono molti anni che il malgoverno
spagnuolo fu da noi scosso, movendoci Masaniello
popolano. Stettero i nobili o contra noi o in
disparte, e spesso vennero ad arringarci, come
ora il nuovo Eletto, per ricondurci alla
servitù, chiamandola quiete.
Io, giovinetto, seguitai le
parti del popolo; vidi le fraudi dei signori, le
tradigioni del governo, le morti date a’ miei
parenti ed amici.
Io, vecchio ora che parlo, e
assennato dal tempo, credo che in questa
congiura di nobili debba il popolo abbandonarli,
come nella congiura di Masaniello fu da’ nobili
abbandonato.
Udite già gli assunti nomi di
principe di Piombino, principe di Salerno, conte
di Nola; e aspettatevi tanti altri ancora
ignoti, ma che tutti sarebbero sopra noi nuovi
tiranni.
Io mi parto da questo luogo; mi
seguirà chi presta fede ai miei detti!” E restò
vuota la piazza.
Un po’ di respiro… per non essere
venduti (1678)
121. In un clima, dunque, di
maggiore tranquillità sociale e di minor carico
fiscale, anche il nostro Casale della Barra poté
“respirare” un po’ di più.
122. Un bel po’ di “fiato” fu
necessario per respingere un altro tentativo di
“vendita a privati” di vari Casali, fra i quali
La Barra, effettuato questa volta dal vicerè
Fernando Fajardo, marchese de Los Velez
(1675-1683): il Casale della Barra chiese di
“rimanere in demànio” e lo ottenne, nel 1678,
sborsando in cambio al vicerè la bella cifra di
8000 ducati
.
123. Il “fiato” maggiore, però,
fu utilizzato per portare a termine la chiesa
parrocchiale.
La parrocchia “di S. Anna” nel
Seicento
124. Il titolo ufficiale della
parrocchia di Barra è “Ave Gratia Plena” ovvero
A G P ovvero “SS. Annunziata”: lo stesso, cioè,
dell’altra e maggior chiesa che si trova in
Napoli
.
Fin dalla sua fondazione, però, vi fiorì anche
quella particolare devozione alla madre di
Maria, onde la parrocchia stessa venne
popolarmente detta “di S. Anna”.
125. Ancor prima che venisse
posto il battistero nel 1697, risulta che vi
fosse in parrocchia “...un quadro di S. Anna, la
madre di Maria SS. ma, con lo suo Bambino e con
S. Giuseppe e S. Gioacchino” che “se celebra per
essere guarnito di ogni cosa necessaria...”,
come si evince dagli Atti di Santa Visita del
Card. Antonio Pignatelli nel 1689.
Gli Atti di Santa Visita del
Card. Giacomo Cantelmo nel 1692 specificano: “La
quarta cappella intitulata S. Anna, con
l’imagini del Bambino, S. Anna, la Madonna, S.
Giuseppe e S. Gioacchino … una fenestra con le
vetrate, et avante alla detta cappella vi è una
balagustrata di legname di noce”.
126. Il quadro raffigurava
quindi bensì S. Anna, ma inserita nel contesto
di una “foto di famiglia” che riprendeva tre
generazioni: figlio (il bambino Gesù), genitori
(la Madonna e S. Giuseppe) e nonni (S. Anna e S.
Gioacchino).
127. Esso, quale che ne fosse
il pregio artistico, si prestava perciò a quella
che oggi si direbbe la “pastorale familiare”,
perché proponeva, visivamente e sinteticamente,
tutta una serie di valori cristiani della
famiglia: l’unità e l’armonia fra le persone e
le generazioni, la santità della procreazione e
l’amore per i bambini, la fedeltà coniugale, il
rispetto e la non-emarginazione degli anziani,
la laboriosità e lo spirito di sacrificio, nel
contesto di una fede in Dio semplice ma solida,
alimentata dalla preghiera quotidiana.
128. Erano appunto i valori che
la Chiesa intendeva infondere nelle famiglie e
che furono sostanzialmente recepiti e vissuti
dal popolo di Barra, dando vita alla sana
famiglia contadina, ampia, compatta e
patriarcale, che sarà il sostegno di molte
generazioni per secoli, fino alla sua
disgregazione operata, nel Novecento, dalle
mutate condizioni sociali e culturali.
129. D’altra parte S. Anna,
patrona delle partorienti ed invocata dalla
donne sterili desiderose di avere un figlio,
rappresenta in modo emblematico la maternità
(forse più della stessa Madonna) nonché la
femminilità vissuta nel contesto domestico, in
dedizione al marito e ai figli.
Il P. Tommaso Auriemma e la
confraternita dell’Annunziata (1640)
130. Il principale promotore
della figura di S. Anna in Barra fu il padre
gesuita Tommaso Auriemma, che ivi operò
alacremente, in collaborazione con i vari
parroci, per buona parte del Seicento.
131. Davide Palomba, anch’egli
gesuita, scrivendo nel 1881, così delinea la
figura del suo confratello vissuto due secoli
prima:
“Quanto poi al P. Auriemma, era
questi un uomo meritatamente stimato da ogni
maniera di persone. Entrato nella Compagnia in
età di anni diciotto, vi era riuscito insigne
così nelle lettere come nella pietà.
E, per quello che si attiene
alle lettere, ben lo attestano le Opere da lui
stampate... delle quali Opere, alcune ebbero
l’onore di varie edizioni, altre furono tradotte
in diverse lingue.
Relativamente poi alla pietà,
dicono le memorie rimasteci di lui, che egli era
religioso per osservanza e per povertà esimio.
Ma quello che lo rendeva più ammirevole era lo
zelo per la salute delle anime. Perciò, dopo di
avere insegnato lettere umane e teologia morale,
ottenne dai suoi Superiori di poter dedicare il
resto degli anni, che gli avanzavano, al sacro
ministero; ed il campo dàtogli da coltivare
furono questi paesi posti a poca distanza da
Napoli.
Fosse pertanto la docilità
della nostra gente, fosse la scossa salutare
della eruzione (1631) e della peste
(1656), certo è che il frutto da lui
raccolto in queste parti fu copioso assai.
E ne è una prova convincente la riunione della
Santissima Annunziata, alla quale nella Barra
diede, quanto era da lui, forma ed essere di
Sodalizio”
.
132. “Venne in Barra il P.
Tommaso Auriemma, gesuita, nel 1639 e nel 1640
fondò la Congregazione della SS. Annunziata”,
come concordano i successivi Atti di Santa
Visita.
133. L’Auriemma, quindi, noto e
valente predicatore e formatore delle coscienze,
venne in Barra la prima volta al tempo del
parroco Francesco Antonio del Pozzo (1627-1654)
e del card. Francesco Buoncompagno (1626-1641),
nel periodo compreso fra l’eruzione del Vesuvio
(1631) e la sollevazione di Masaniello (1647), e
si adoperò allo scopo di costituire la
confraternita secondo lo spirito del Concilio di
Trento destinata a sostituire in tutto la
precedente estaurìta.
134. Dagli Atti di Santa Visita
già nel 1639 risulta infatti come promotore
della congregazione “della SS. Annunziata”, che
si riuniva naturalmente nei locali stessi della
nuova parrocchia, anche se in quell’anno non
aveva ancora un riconoscimento formale del
proprio statuto da parte della Curia. Tale
riconoscimento formale fu dato l’anno successivo
(1640) e la confraternita, nel 1692, contava 187
iscritti (100 uomini e 87 donne), su un totale
di circa 2500 “anime” Barresi registrate
quell’anno.
135. Gli statuti dell’Annunziata di Barra
prevedevano esplicitamente l’intervento
permanente dei Gesuiti nella direzione
spirituale della confraternita. Ora, occorre
notare che l’Ordine dei gesuiti fu quello che,
più di ogni altro, nel periodo successivo al
Concilio di Trento, promosse la devozione verso
S. Anna.
Tommaso Auriemma, in
particolare, risulta autore di un’opera
specifica, intitolata, secondo lo stile
dell’epoca, “Historia panegirica delle
attioni, glorie e gratie di S. Anna, Genetrice
della Gran Madre di Dio Maria”, uscita a
stampa nel 1665.
Si può quindi ritenere per
certo che egli, nel processo stesso di
formazione della confraternita laicale e di
guida spirituale degli ascritti, procurò di
instillare quell’amore verso la figura di S.
Anna, che doveva poi così fortemente
caratterizzare il Casale.
136. Collaboratore dell’Auriemma
e co-fondatore dell’Annunziata in Barra fu il
laico Gerolamo Pisa, che già faceva parte
della analoga confraternita gesuitica della
Purificazione in Napoli e risulta essere stato
assegnato nel 1612, in qualità di “prefetto”, ad
un’altra congregazione fondata nella chiesa del
Carminiello al Mercato, aggregata a quella della
Purificazione
.
Evidentemente, il Pisa era un
attivo collaboratore dei PP. Gesuiti e
partecipava con loro alla fondazione di nuove
confraternite, in particolare quando si trattava
di “impiantarle” dal punto di vista
organizzativo.
|
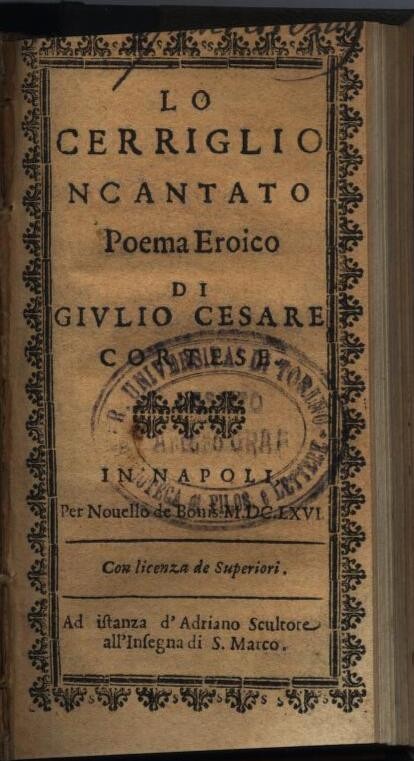 |
Giulio Cesare Cortese è il maggior poeta napoletano
del Seicento |
Vita di confraternita nella Barra del Seicento
137. La confraternita
dell’Annunziata di Barra era “affiliata” non
soltanto a quella detta “dei Catecumeni” di
Napoli, come la maggior parte delle
confraternite dei Casali, ma anche alla
prestigiosa arciconfraternita romana “della
Concezione” in S. Lorenzo in Damaso, che era la
“capo-fila” di tutte le confraternite “della
Dottrina Cristiana”, quelle cioè che si
proponevano come scopo principale
l’istruzione catechistica dei confratelli:
138. “… et particolarmente in
essere instrutti nella sacra Dottrina Cristiana
et in essere promossi a vita spirituale in
frequenza de’ Santi Sacramenti et in esercitio
di tutte le virtù cristiane”.
139. La catechesi prevedeva due
momenti: quello dell’apprendimento della
dottrina in occasione delle riunioni della
confraternita; e quello dell’insegnamento
agli altri della dottrina appresa. I padri
di famiglia dovevano cioè insegnare il
catechismo nella propria famiglia, così come
dovevano fare i maestri di scuola, i
capi-bottega e i maestri delle corporazioni di
arti e mestieri, ciascuno per le persone di cui
era responsabile, perché “tutti passano per le
mani di costoro e sotto del loro magistero”.
140. La dottrina cristiana si
apprendeva “conforme all’uso”: da due o
da quattro persone, “a modo di dialogo si
reciterà una parte della Dottrina del Padre
Ledesma”.
141. Il padre gesuita spagnolo
Giacomo Ledesma (1519-1575) aveva scritto, nel
1571, una “Dottrina christiana breve, per
insegnare in pochi giorni, per interrogazione, a
modo di dialogo fra ‘l maestro e discepolo”.
142. La “Dottrina breve” del
Ledesma, originariamente in spagnolo e poi
tradotta in moltissime lingue, aveva avuto
ovunque un grandissimo successo per la sua forma
semplice e pratica, particolarmente adatta al
tipo di apprendimento, verbale e
mnemonico, di coloro che non sapevano
leggere e scrivere; ovvero, in quel tempo, la
stragrande maggioranza della popolazione.
143. Inoltre, i confratelli
imparavano anche “le lodi e i canti dell’istessa
Dottrina, acciò che, lasciando i canti profani,
possano cantare quelli devoti e spirituali”.
144. Infine, il padre
spirituale, nel suo sermone conclusivo,
“dichiarerà qualcosa della dottrina … qualche
articolo e mistero della fede, qualche altro
precetto, o qualche sagramento”.
145. Si raccomandava anche di
leggere, o farsi leggere, privatamente, qualche
libro spirituale, quali le vite dei santi o
testi preparatori alle varie festività
religiose.
146. Riguardo a queste ultime,
era naturalmente prevista la partecipazione alla
Messa domenicale, in particolare la prima
domenica di ogni mese, e in tutte le ricorrenze
festive solenni. La Messa quotidiana era
raccomandata ma non obbligatoria, potendo essere
sostituita dalla “Visita al SS. Sacramento” e
dalla recita di 5 Pater e 5 Ave in
onore delle 5 piaghe del Signore crocifisso, e
una Salve Regina in onore della Vergine.
147. Ogni giorno, abitualmente:
il rosario di cinque poste, l’orazione mentale
al mattino e l’esame di coscienza alla sera, il
ringraziamento prima del pranzo e della cena, la
preghiera per la Chiesa, per il Papa e per le
Anime del Purgatorio.
148. Come pratiche ascetiche,
era suggerito di digiunare il Sabato o di fare
qualche astinenza o altra devozione in onore
della Vergine; nella confraternita di Barra, in
particolare, era prevista anche “mez’ora di
disciplina ogni venerdì sera”.
149. A Barra, inoltre,
contrariamente a quanto di solito accadeva per
le altre confraternite “della Dottrina
Cristiana”, il sodalizio doveva anche gestire
una festa e la relativa processione, quella del
25 marzo (giorno dell’Annunciazione): i
preparativi dovevano aver inizio con un mese di
anticipo, ed in quel giorno l’Oratorio rimaneva
sempre aperto ed accessibile anche ai
non-iscritti, evitando “ogni forma di
divertimento dentro e fuori l’Oratorio”.
150. Erano previste due tipi di
riunione: quella per gli “esercizi ordinari” e
quella per gli “esercizi straordinari”.
151. Gli “esercizi ordinari” si
tenevano la Domenica e nelle principali
festività religiose, e consistevano in:
-
Preghiera
iniziale di invocazione dello Spirito Santo
-
Litanie della
Vergine
-
Apprendimento
della “Dottrina” e dei canti, come detto
sopra
-
Sermone del
Padre spirituale
-
Atti di
penitenza
-
Recita finale
della Salve Regina
152. Gli “esercizi
straordinari” erano invece:
-
la lettura
delle regole della confraternita che veniva
fatta, ogni prima domenica del mese, dal
Padre spirituale,in sostituzione del
sermone;
-
la recita
della Coroncina delle piaghe di Cristo, la
seconda domenica di ogni mese;
-
la devozione
del “Santo del mese”, la terza domenica, che
consisteva nel “pigliarsi ogni mese un Santo
per protettore e avvocato davanti a Dio”.
153. Altresì irrinunciabili
erano:
-
l’assistenza
ai confratelli infermi, consistente
nel visitarli, pregare per loro e con loro,
fornire aiuti materiali se necessario;
-
l’accompagnamento alla sepoltura dei
confratelli defunti, dopo le esequie
che si celebravano nell’Oratorio; in
suffragio, era poi prevista la comunione, da
farsi il primo giorno festivo dopo la morte,
e la recita del rosario di 15 poste e di
altre preghiere.
154. Per quanto riguarda
l’organizzazione interna, essa era simile a
quella di altre confraternite, come abbiamo
descritto nei nn°117 e seguenti del capitolo
dedicato al Cinquecento.
155. In particolare, però,
nell’Annunziata di Barra era previsto che il
Padre spirituale fosse sempre un Gesuita, che
doveva “conservare la congregatione, presiedere
negli esercitii che si fanno, procurare che si
osservino le regole, e che tutti gli ufficiali
siano diligenti nelli loro ufficii”.
Era il Padre gesuita a proporre
3 confratelli per le cariche di superiore e di
assistenti; dopo di che, colui che aveva la
maggioranza dei voti, diventava priore e gli
altri due, assistenti; il Padre però disponeva
di 2 voti invece di uno.
Era poi sempre lui a nominare
direttamente gli altri ufficiali della
confraternita, tranne il tesoriere, e comunque
ad autorizzare, insieme al priore, le spese
necessarie.
“Il governo della confraternita
ovvero la congregazione dell’officiali non può
riunirsi senza la voluntà et presentia del Padre
e, facendosi senza il Padre, sarrà nulla né
potrà proporre nissuno officiale cosa alcuna; ma
ogn’uno comunicherà al Padre quello che vuole
proporre et il Padre, in suo nome, la proporrà
quando si farà la congregazione”.
156. L’elezione si svolgeva
annualmente, nel periodo natalizio o in altro
periodo opportuno; gli “officiali” potevano
anche essere confermati più volte ed anzi si
raccomandava di “non mutarli tutti
contemporaneamente”, evidentemente per
assicurare la continuità della gestione.
157. Per essere ammessi alla
confraternita, bisognava fare richiesta al Padre
e compiere un noviziato di 4 mesi sotto la guida
del “maestro dei novizi”, apprendere la dottrina
cristiana, praticare spesso i sacramenti e
frequentare l’oratorio; il novizio doveva poi
fare la confessione generale e la comunione
immediatamente prima della cerimonia di
ammissione.
Il completamento della chiesa
parrocchiale
158. Procedeva, intanto, il
completamento della chiesa parrocchiale.
“E tu leggi, ripetuto in ben tre lastre di marmo
bianco, poste l’una in seguito all’altra nel
pavimento di essa, una sola frase”
: UNIVERSITAS 1642.
Si trattava, evidentemente, dell’accesso al
luogo di sepoltura che era, conforme all’uso,
sottostante la chiesa. In pratica, s’inaugurò
allora il nuovo “cimitero”, mentre in precedenza
i morti venivano seppelliti sotto la chiesa di
S. Atanasio.
159. Successivamente, venne
posto il fonte battesimale, come si
evince dalla scritta che lo sovrasta:
D O M
AD
ABSTERGENDAM GENERIS HVMANI LABEM
INFVNDENDVMQVE GRATIAE CAELESTIS NITOREM
HVNC VERAE
SALVTIS FONTEM
ET ANIMARVM ELVENDARVM LAVACRVM
VBI RECENS
NATI CHRISTO REGENERANTVR PARENTI
ASSIDVVMQVE
FACIT ORIGINARIA CVLPA NAVFRAGIVM
TOMAE
AGNELLI SANCTORI BORRELLI ET ANGELI SANNINI
PAGI
ELECTORVM PIETAS
JOSEPHO
CARLINO PAROCHO OPTIME MERITO ADNITENTE
AERE PVBLICO
FORMANDVM EXCITANDVMQVE CVRAVIT
AN.
REPARATAE SALVTIS
M DC LXXXX VII
Traduzione:
- A DIO
OTTIMO MASSIMO -
PER TERGERE
LA MACCHIA (ORIGINALE) DEL GENERE UMANO
ED INFONDERE
LO SPLENDORE DELLA GRAZIA CELESTE
QUESTO FONTE DI VERA SALVEZZA
E LAVACRO
DELLE ANIME DA PURIFICARE
DOVE I
NEONATI VENGONO RIGENERATI IN CRISTO
E
CONTINUAMENTE FA NAUFRAGIO L’ORIGINARIA COLPA
LA PIETA’
DEGLI ELETTI DEL VILLAGGIO
TOMMASO D’ANIELLO
SANTOLO BORRELLI E ANGELO SANNINO
CON LA
COLLABORAZIONE DEL BENEMERITO PARROCO GIUSEPPE
CARLINO
EBBE CURA DI
FAR COSTRUIRE CON IL DENARO PUBBLICO
NELL’ANNO
DELLA RIACQUISTATA SALVEZZA
1697
160. Si tenga presente, come
già detto al n°159 del capitolo dedicato al
Cinquecento, che “per le costituzioni di
Federico II di Svevia (1220-1250), perciò sin da
tempi antichissimi…” l’amministrazione locale “…
si affidava ad un Sindaco e due Eletti,
scelti dal popolo in così largo Parlamento
che non altri erano esclusi dal votare fuorché
le donne, i fanciulli, i debitori della comunità
e gli infami per condanna o per mestiero. Ci si
adunava in certo giorno d’estate nella piazza e
si facevano le scelte per gride, avvenendo di
rado che bisognasse imborsar più nomi per
conoscere il preferito”
.
161. I nostri Tommaso
D’Aniello, Santolo Borrelli e Angelo Sannino
erano dunque gli Eletti di Barra (un
Sindaco e due Eletti) che fecero costruire, con
denaro pubblico, il fonte battesimale inaugurato
nell’anno 1697; il parroco era invece D.
Giuseppe Carlino, in carica dall’agosto 1687 al
gennaio 1709.
162. Sui due lati del fregio
che incornicia il luogo del battistero, venne
scolpita, come ancor oggi si vede, la Sirena
bi-cauda, stemma del Casale.
163. Nello stesso anno 1697
nel quale veniva posto il fonte battesimale,
il grande pittore Francesco Solimena, che
risiedeva in Barra, donò alla parrocchia la
bellissima tela raffigurante “S. Maria delle
Grazie con anime purganti”, che ancor oggi si
vede nella cappella laterale successiva a quella
che ospita il battistero.
164. Così, in un certo senso,
come notava già il Cozzolino, intorno al fonte
battesimale si trova riassunta tutta la passata
storia, religiosa e civile, di Barra!
La villa Mastellone (1678)
165. Lo storico di Barra Pasquale Cozzolino,
scrivendo nel 1889, riferisce:
“… sulle altezze del Serinum,
risanato, la marchese Amato nel 1621 volle,
accosto ad un territorio suo, veder costruita la
Casa, così detta Scioriniello, forse dai
fiori superbi del parco che la dovevano
idealizzare, allietata pur da teatrino; ed i
Mastellone, dei duchi di Limatola, la loro villa
nel 1678, confinante con questa casa Amato,
arricchita anche di bel parco, con stradone
centrale di mezzo chilometro circa! ”.
166. La villa-masseria (vedi
n°13) dei Mastellone sorse dunque nel 1678,
lungo quella “cupa” che proprio da loro prese il
nome di Cupa Mastellone.
In effetti, il tracciato della
strada esisteva già, scavato nel terreno dalle
“lave dell’acqua” che irrompevano dal Vesuvio
durante le piogge e determinavano appunto il
formarsi delle famose “cupe”, delle quali quella
di cui stiamo parlando è una delle più antiche
sul territorio di Barra.
Nel 1678, in occasione della
costruzione della villa, il vecchio tracciato
venne molto probabilmente ri-sistemato, per
congiungere più agevolmente la villa, isolata in
mezzo ai campi dei quali i Mastellone erano
“signori”, con il nucleo abitato di Barra “di
sotto”.
167. I Mastellone (o Mastelloni: le due dizioni
si trovano in atti diversi, ma riferiti sempre
alla stessa famiglia), a quanto sembra, erano
originari di Sorrento: il documento più antico
che se ne ha, riferisce di un Matteo Mastellone
che fu milite e sindaco di Sorrento nel 1274.
Divennero feudatari nel periodo Aragonese,
acquisendo nel tempo vari titoli nobiliari.
168. In particolare, il titolo di “duchi di
Limatola”, riferito dal Cozzolino ai Mastellone
di Barra, appartenne al ramo secondogenito
della famiglia.
169. Il ramo primogenito, infatti,
acquisì successivamente i titoli di nobili in
Monòpoli, “règi familiari” (1580) duchi di
Castelpagano (1724), marchesi di Capograssi
(1725), marchesi di Ripa Limosano per
successione di Casa Capecelatro con anzianità
dal 1617, nobili di Tarquinia, ed altri. A
questo ramo primogènito appartenne quell’Emmanuele
Mastellone (1750-1835) che troveremo, in
seguito, come Ministro della Giustizia nella
Repubblica napoletana del 1799.
170. Il titolo di duchi di Limatola
apparteneva invece alla illustre famiglia dei
Gambacorta (vedi n°117).
Morto però senza eredi, il 31 marzo 1725 in
Napoli, l’ultimo duca Francesco Gambacorta, il
titolo ed il feudo passarono al ramo
secondogenito dei Mastellone, nella persona
di un Giovanni Mastellone, nel 1733, e poi di
Maddalena Mastellone (1751-1760).
Dopo questo periodo relativamente breve, titolo
e feudo pervennero, per matrimonio, alla
famiglia Lottieri d’Aquino di Pietrastornina ed
in seguito, per vicende non ben documentate, ai
Carafa.
171. Dopo la legge di eversione della feudalità
(nel 1806), che comportò la vendita di terreni e
castello a privati, il solo titolo di
“duca di Limatola” venne riconosciuto, con Règio
Decreto di Ferdinando II di Borbone il 17 luglio
1856, nella persona di Nicola Mastellone.
172. Perciò, quando, nel 1678,
i Mastellone (del ramo secondogenito)
costruirono la loro villa-masseria in Barra, non
portavano ancora il titolo di “duchi di
Limatola”, che ricevettero invece solo nel 1856.
Di questo titolo si fregiava, al tempo del
Cozzolino, quel Giovanni Mastellone (1820-1898)
che fu Sindaco di Barra dal 1879 al 1882 e poi
dal 1886 al 1892, e che svolse un ruolo
fondamentale nel definire la conformazione
urbanistica che ancor oggi caratterizza Barra,
come vedremo a suo luogo.
Il terremoto del 1688
173. A far costruire la
villa-masseria in Barra nel 1678 fu, come
risulta dalla lapide che sovrasta l’ingresso
della cappella, Domenico Mastellone.
174. Solo dieci anni dopo, però, sopravvenne il
celebre terremoto del 1688: anche la masseria
dei Mastellone subì consistenti danni ed un lato
di essa addirittura crollò.
175. Quel terremoto del 5 giugno 1688 fece
particolare impressione sui napoletani,
soprattutto a causa dell’elevato valore
simbolico di alcuni degli edifici che da esso
furono danneggiati.
Si ebbe infatti il crollo della facciata della
grande e centralissima chiesa di S. Paolo
Maggiore, con i resti, ivi incorporati,
dell’antico tempio pagano di Castore e Polluce,
e vi furono gravi danni anche alla cupola della
chiesa del Gesù Nuovo.
176. Per dare un’ idea della
ripercussione psicologica che ebbe l’evento, si
riporta qui di seguito un ben composto sonetto,
che il gesuita Giacomo Lubrano, quasi
anticipando in stile barocco il Leopardi de “La
ginestra”, scrisse per l’occasione, onde
sottolineare la irrimediabile precarietà di ogni
opera umana, anche di quelle esaltate come
“eterne”:
177. Terremoto orribile accaduto in Napoli nel 1688:
Mortalità, che sogni? ove ti
ascondi,
se puoi perire a un alito di
fato?
dei miracoli tuoi il fasto
andato
or nemmen scopre inceneriti i
fondi.
Sozzo vapor da bàratri profondi
basta ad urtar con precipizio
alato
alpi di bronzo; e in polveroso
fiato
distrugge tutto il Tutto a
regni, a mondi.
Di ciechi spirti un’invisibil
guerra
ne assedia sempre, e cova un
vacuo ignoto
a subitànee mine in ogni terra.
Ai troni ancora, ai templi è
base il loto:
su le tombe si vive; e spesso
atterra
le nostre eternità breve
tremòto.
La cappella di S. Rosa
178. Anche i Casali, con le
loro povere abitazioni e le loro ville, non
restarono indenni.
Ma nel Casale della Barra,
proprio fra i ruderi originati dal crollo di un
lato della villa Mastellone, spuntò, non molto
tempo dopo… una rosa (“erumpente inter rudera...
rosa”) che, con la sua indifesa tenacia, ispirò
a Domenico Mastellone la costruzione, su
quell’ala diroccata del suo palazzo, della bella
cappelluccia che tuttora si vede, dedicata
appunto a S. Rosa, come si può ancora leggere
nell’epigrafe che ne sovrasta la porta.
Chi è Santa Rosa?
179. S. Rosa, vergine, è la
prima Santa del continente americano, e può
essere chiamata “la Santa degli indios ”
in particolare degli indios del Perù.
Nacque infatti a Lima, capitale
del Perù (che era stato, ricordiamolo,
colonizzato dagli spagnoli) il 20 aprile del
1586, decima dei 13 figli di una nobile famiglia
di origine spagnola.
Il suo nome di battesimo era
Isabella Flores de Oliva, ma una serva di casa
di origine india le diede, secondo il
costume indigeno, il soprannome di un fiore e la
chiamò “Rosa”. Questo soprannome popolare le fu
poi autorevolmente confermato, al momento della
Cresima, dall’arcivescovo di Lima, S. Turibio de
Mongrovejo; ad esso, lei stessa aggiunse “di
Santa Maria” per sottolineare il suo amore per
la Madre di Dio, e così da allora si chiamò
“Rosa di Santa Maria”.
Essendo andata in miseria la
sua famiglia, ne divenne lei stessa il sostegno
principale, con il suo lavoro di ricamatrice e
coltivando il suo piccolo orto.
Rimase affascinata dalla
lettura di alcuni brani delle opere di S.
Caterina da Siena e vestì l’abito del
Terz’Ordine domenicano; la sua breve vita
fu tutta dedicata alla penitenza, alla
contemplazione mistica e all’aiuto materiale e
spirituale ai poveri indios.
Morì il 24 agosto del 1617,
all’età di 31 anni. Il suo corpo è tutt’ora
veneratissimo a Lima (Perù) nella basilica
domenicana del Rosario.
Fu beatificata nel 1668
ed appena 2 anni dopo, nel 1670, fu proclamata
ufficialmente “patrona principale delle
Americhe, delle Filippine e delle Indie
occidentali”, con provvedimento del tutto
eccezionale dal momento che una norma papale del
1630 stabiliva che non potessero darsi come
patroni a città o regni delle persone che non
fossero state ancora canonizzate.
Fu comunque canonizzata il 12
aprile 1671 dal papa Clemente X. La sua festa
ricorre attualmente il 23 agosto
.
180. L’epigrafe, attualmente
visibile dalla strada, che sovrasta la porta di
accesso alla cappella dei Mastellone dice:
D O M
DOMINICVS
MASTELLONVS
SUBURBANUM
HOC
PRO SE
FAMILIAQVE SUA
COMPARAVIT
AT IBIDEM
ERUMPENTE INTER RUDERA
ROSA
ISTHOC SACELLUM
AN MDCXCIX
DIVAE MARIAE
ROSAE COGNOMENTO
NUNCUPATUM
INAUGURATO CONSTRUXIT
INGREDERE HOSPES
ET FLORUM REGINAE
SPARGE FLORES
Traduzione:
- A DIO
OTTIMO MASSIMO -
DOMENICO
MASTELLONE
QUESTO
SUBURBANO (EDIFICIO)
PER SE E LA
SUA FAMIGLIA
PREDISPOSE.
NELLO STESSO
LUOGO, ESSENDO SPUNTATA FRA I RUDERI
UNA ROSA,
COSTRUI’
NELL’ANNO 1699
QUESTA
CAPPELLA,
CONSACRATA E
CHIAMATA
COL NOME DI
S. MARIA ROSA.
ENTRA,
OSPITE,
E SPARGI
FIORI
ALLA REGINA
DEI FIORI.
181. A parte la vicenda del
terremoto del 1688 e della rosa spuntata fra i
ruderi, non meraviglia il fatto che Domenico
Mastellone abbia pensato di dedicare la cappella
di famiglia a S. Rosa da Lima, stante la grande
popolarità che questa Santa, patrona
“eccezionale” dei domìni d’oltremare spagnoli,
ebbe anche nel viceregno napoletano.
182. La cappelluccia, che aveva
anche la funzione di “tomba di famiglia” secondo
l’usanza di quel tempo, ha tuttora sull’altare
maggiore una immagine di Maria con la sua
“rosa”. Vi erano un tempo due grandi tele sulle
pareti laterali: se ne vede attualmente una
sola, che raffigura la Madonna con ai lati S.
Domenico e S. Rosa da Lima.
Casavaleria nel Seicento
183. All’inizio del Seicento, Casavaleria (ormai
parte integrante di Barra) aveva già perduto la
antica chiesetta di S. Martino, del tutto
diroccata, e dopo la eruzione del 1631 anche il
villaggetto omonimo si orientò sempre di più
verso S. Giorgio a Cremano (vedi sopra, n°36).
184. Il centro del piccolo
borgo agricolo diventava quindi la rimanente
chiesa di S. Maria del Pozzo, costituita in
Rettorìa, ma senza una corrispondente
confraternita stabile.
185. E’ interessante, a tal
proposito, osservare che quell’unico “romìto”
segnalato in Barra dagli Atti di Santa Visita
del 1699 viveva proprio nella zona di S. Maria
del Pozzo; il che dice molto circa la assoluta
pace e tranquillità del borgo, ma anche circa il
tipo di esperienza religiosa del tutto solitaria
che, in assenza di confraternita, vi si poteva
di preferenza sviluppare.
186. Nel corso del secolo,
Casavaleria si arricchì comunque di nuovi
insediamenti stabili di piccola nobiltà, come si
evince dalle due memorie storiche
seicentesche tuttora visibili nel borgo.
La villa Amalia (1617)
187. La prima è la villa
Amalia, della quale si è già detto che, insieme
alla villa Filomena e alla villa Mastellone,
costituisce esempio di villa nobile a carattere
rustico-residenziale. In altre parole, una
famiglia nobile risiedeva stabilmente nella
villa (naturalmente, negli appartamenti a ciò
appositamente riservati) mantenendo quindi un
diretto rapporto con il lavoro ed i lavoratori
delle campagne retrostanti, delle quali erano
“signori”.
188. La villa Amalia
(appartenuta, fra gli altri, al barone
Covelli, che fu probabilmente colui che così
la denominò) reca sul portale d’ingresso una
lapide di marmo con sopra incise le insegne e la
data: ANO DNI 1617
Si può quindi ritenere come la
più antica fra le ville tuttora esistenti in
Barra.
189. “Dal punto di vista
tipologico, presenta una pianta ad L con una
delle due ali dell’edificio articolata su
terrazze degradanti.
La corte irregolare, aperta sui
due lati, conserva tracce dei due depositi posti
ai lati dell’accesso alla proprietà agricola.
Sul piano formale, è da
sottolineare il raffinato disegno della
facciata, con la cornice continua in piperno del
marcapiano del piano nobile ed il portale con il
timpano spezzato, nonché il corpo scala a vista
sia verso il cortile che verso la strada”
.
La pietra sepolcrale in S. Maria
del Pozzo (1635)
190. La seconda memoria
storica del Seicento è la pietra sepolcrale
posta proprio sotto l’altare principale della
chiesa di S. Maria del Pozzo, la quale reca la
seguente iscrizione:
DDM
HIC SITUS EST DIDACUS PAPARIUS
DECY FILIUS REGY CENSUS PRAESIDIS
QUI PATRIS INTEGRITATEM SUIS MORIBUS VIVA
EXPRESSIT
OBYT DIE V FEBRUARY ANO DNI MDCXXXV (1635)
HOC SIBI SUISQU CONSANGUINEIS EX LEONISSAE ATQ
ALBITIORUM FAMILIA
MF. C
Traduzione:
QUI E’ POSTO
DIDACUS PAPARO
FIGLIO DI
DECIO, PRESIDE DEL REGIO CENSO,
CHE L’INTEGRITA’
DEL PADRE, CON I SUOI COSTUMI, VIVA ESPRESSE.
MORTO IL
GIORNO 5 FEBBRAIO DELL’ANNO DEL SIGNORE 1635.
QUESTO, PER
SE E PER I SUOI CONSANGUINEI, DALLA FAMIGLIA DI
LEONESSA E DEGLI ALBIZI.
191. Nella iscrizione mancano
alcune lettere (la E finale di SUISQUE; la
sillaba UE al termine di ATQUE); la scritta MF C
è probabilmente la sigla dell’artefice materiale
dell’ iscrizione.
192. La lapide, ed
evidentemente anche il pagamento della
prestigiosa collocazione in luogo diverso da
quello del restante popolo, furono quindi donate
dalla “famiglia di Leonessa e degli Albizi” alla
famiglia Pàparo, affinché potesse provvedere a
seppellire Didacus, che era il figlio di Decio,
il quale viene presentato come “regy census
praesidis”.
193. “Census” indica, in
latino, “l’elenco dei cittadini e dei rispettivi
patrimoni”, compilato ai fini della tassazione,
e quindi il nostro Decio Pàparo, essendo
“preside del censo regio”, doveva essere un
importante funzionario addetto alla ripartizione
del carico fiscale e alla riscossione delle
imposte sulle terre demaniali (come era Barra),
che appartenevano direttamente al re.
194. La famiglia “della
Leonessa”, dal francese “de la Lagonière”,
giunta nel Regno al seguito di Carlo I d’Angiò,
divenne una importante casàta nobiliare
napoletana, iscritta al Seggio di Capuana; gli
Albizi (si legge con l’accento sulla A) erano
invece una famiglia di ricchi mercanti
fiorentini, legati all’arte della lana. Il fatto
che si parli di una sola “familia” e non di due
è dovuto probabilmente al fatto che qualcuno
“della Leonessa” aveva sposato qualcuna degli
“Albizi” e fu questa “familia” a regalare lapide
e sepolcro ai Pàparo.
La “famiglia di Leonessa e
degli Albizi” era evidentente legata a Decio
Pàparo da rapporti di amicizia ed anche di
reciproca gratitudine, trattandosi di un
personaggio collocato in un ruolo strategico (la
riscossione delle imposte!).
L’elogio funebre sembra infatti
rivolto più al padre che al figlio, il che
lascia presumere che il figlio sia morto prima
del padre, ancora vivente, che si voleva
compiacere col dono della pietra.
La chiesa e
contrada dell’Oliva nel Seicento
195. Su una piccola lapide, che
sormonta l’arco di accesso al cortile
contrassegnato dal numero civico 5 della attuale
Via Comunale dell’Oliva in Barra, si legge la
seguente scritta:
FRVCTIFERV DIVI LAVRETI
ISABELLA DE GENNARO
FRATRIBVS VLTRO SPONTANEAMENTE
DIEDE IN DONO
HOC DONO DE ANNARVS QUESTO
TERRENO COLTIVATO A FRUTTETO
ISABELLA DEDIT 1601 AI FRATI DI
S. LORENZO 1601
196. Dall’altro lato della
strada, proprio di fronte al cortile, si trova
la chiesetta dedicata a S. Maria delle Grazie
“dell’Oliva”. La circostante contrada è tuttora
detta, anch’essa, “all’Oliva” e costituisce uno
degli ultimi esempi di piccolo borgo rurale
rimasti in Barra. Come possiamo interpretare
questa lapide?
Contesto storico della lapide del
1601
197. Come si è detto
,
sulla cresta dell’onda suscitata dal Concilio di
Trento (1545-1563), nella seconda metà del
Cinquecento arrivarono in Barra gli insediamenti
stabili dei Francescani e dei Domenicani. E per
primi, arrivarono i Francescani, ai quali nel
1585 il patrizio napoletano Gerolamo de Fazio
finanziò la chiesa e il convento che tuttora
esistono, aggiungendovi la rendita di 20 ducati
all’anno, affinché i frati celebrassero tre
messe alla settimana per i defunti della sua
famiglia.
198. I Francescani avevano (ed
hanno) la loro sede principale a Napoli nello
storico convento, con famosissima chiesa, di S.
Lorenzo Maggiore: sono essi, perciò, i “frati di
S. Lorenzo” cui accenna la lapide.
199. Non molti anni dopo la
donazione del de Fazio (nel 1601, appunto), la
nostra Isabella de Gennaro donò il suo frutteto:
agli stessi frati e, del tutto verosimilmente,
con la stessa motivazione, cioè far celebrare
Messe per i defunti.
200. I frati francescani del
convento di Barra, dunque, sia per soddisfare
all’obbligo imposto dal làscito sia per
assicurare un minimo di assistenza spirituale
alle due o tre famiglie dei contadini del posto,
cominciarono presumibilmente a celebrare la
Messa in un piccolo locale del cortile, che dava
sulla stradina esterna.
La villa e la cappella di
Dionìsio Làzzari (1617-1689) all’Abbeveratùro
201. Occorre inoltre considerare che, a non
molta distanza, vi era anche un’altra cappella,
privata ma pur sempre aperta al popolo per la
Messa domenicale: si trovava nel Largo
“dell’Abbeveratoio” ed era la cappella del
famoso “marmoraro”, architetto e scultore
napoletano Dionisio Lazzari.
202. Nella mappa del duca di Noja (1775), si
distingue chiaramente il celebre “Abbeveraturo”,
isolato ad un incrocio di strade campestri
(l’attuale Piazza Abbeveratoio): serviva, fino a
non molti anni fa, soprattutto per abbeverare
gli animali che trainavano i carretti contadini
di passaggio ed è addirittura identificabile con
il “Bibitùru” di cui parlano alcune carte del
periodo del ducato bizantino, intorno all’anno
1000.
203. Il primo storico di Barra, Pasquale
Cozzolino, scrivendo nel 1889, testimonia:
“Quivi (all’Abbeveratoio) vi si trova la
cappella del celebre pittore (!?)
Dionisio Lazzaro, oggi proprietà del signor
Antonio di Franco. In essa si veneravano due
Santi, S. Spirito e S. Antonio, ma sotto i
Borboni rimase la preferenza a S. Antonio”. E
più avanti dice: “Quivi… il famoso pittore
Dionisio Lazzaro, nella sua bella villa, oggi di
Franco, si conduceva a domandare le sue
ispirazioni!”
204. Ricordiamo qui, di passaggio, che Dionisio
Lazzari (1617-1689), architetto e
“ornamentista”, fu un tipico esponente del
barocco napoletano, di formazione toscana ed
influenzato dal gusto pittoricistico di Cosimo
Fanzago.
E’ autore, fra l’altro, del grande pulpito
(datato 1678) che si vede nella chiesa di S.
Maria della Sanità in Napoli; dei marmi
dell’altare maggiore nella chiesa di S. Gregorio
Armeno; della cupola, del chiostro grande e
della cappella di S. Filippo Neri nella chiesa
dei Girolamini; del magnifico altare della
cappella di Palazzo Reale (realizzato nel 1674
per la chiesa di S. Teresa agli Studi); di gran
parte della suggestiva decorazione marmorea
della chiesa di S. Maria del Purgatorio ad Arco;
del Palazzo Firrao a Piazza Bellini; e inoltre
delle chiese di S. Maria Egiziaca all’Olmo,
della Croce a S. Agostino, di S. Maria di
Montesanto, di S. Severo alla Sanità, del SS.
Salvatore a Capri, e tante altre ancora.
Ebbe come allievo, fra gli altri, l’architetto
Arcangelo Guglielmelli (1650-1717), che
collaborò con Francesco Solimena nella
costruzione della chiesa dei Domenicani in
Barra.
La costruzione della chiesetta
“dell’Oliva”
205. Solo in seguito, dunque,
aumentando la popolazione, si sentì l’esigenza
di costruire una vera e propria chiesetta
rurale, dedicata anch’essa alla Madonna delle
Grazie: più piccola di quanto non sia adesso, e
senza il campanile. Tale costruzione deve essere
avvenuta negli ultimi anni del Seicento o nei
primissimi del Settecento, stante il fatto che
il primo documento certo della sua esistenza è
datato al 1718.
Una presenza benedettina a Barra
nel Seicento (1607-1625)
206. Oltre al convento dei
Francescani ed a quello dei Domenicani, nel
periodo successivo al Concilio di Trento venne
fondato in Barra anche un altro convento, questa
volta benedettino, il quale però non vi rimase a
lungo.
207. E’ infatti ben documentato
che vi era, in un luogo non ben precisato di
Barra, un piccolo convento (dovevano essere una
decina di monaci) di Benedettini Cassinesi.
Fondato nel 1607, il convento venne però
trasferito, già nel 1625, nella zona di Chiaia,
“per ricavarne un convalescenziario e per
liberarsi dai ladri che spesso molestavano i
monaci in Barra”
.
208. Nasceva così il convento
di S. Benedetto a Chiaia, detto pure all’Arco
Mirelli o al Vomero, su una proprietà di
Giulio Cesare Guadagno, notaio della règia
corte, che ne aveva fatto dono (un dono del
valore di circa 4.000 ducati) al fiorentino
Gabriele Lapini, già priore di Barra,
il 4 aprile 1625.
209. Già nel novembre dello
stesso anno (1625), i monaci si trasferirono
nella nuova sede di Chiaia e, un po’ alla volta,
cominciarono a vendere la precedente proprietà
che avevano nel Casale della Barra, allo scopo
di dotare il nuovo S. Benedetto
.
210. Ma come mai i Barresi, che
avevano accolto positivamente gli insediamenti
francescano e domenicano, si mostrarono poi così
refrattari a quello benedettino?
211. Probabilmente, il convento
benedettino si trovava in un luogo troppo
isolato tra le campagne di Barra ed era quindi
più facilmente esposto ai malintenzionati.
Inoltre, si può supporre che,
mentre Francescani e Domenicani svilupparono
subito, conforme al loro carisma, una adeguata
“pastorale popolare”, mescolandosi al popolo e
vivendo con esso, i Benedettini furono invece
percepiti dalla popolazione come una presenza
“chiusa” in se stessa e con la quale,
oltretutto, i contadini venivano a trovarsi in
concorrenza per il possesso e l’uso del
territorio agricolo.
212. Quale differenza,
comunque, con il lontano periodo del ducato
bizantino, quando i conventi di tipo benedettino
erano i signori feudali della quasi totalità del
territorio “foris flubeum” ed i contadini
dipendevano interamente da loro!
La cappella
Bonvicino-Giordano-Fumaroli
213. Ma questa presenza
benedettina non lasciò proprio alcuna traccia
dietro di sé?
214. E’ merito di Romano Marino
aver riportato l’attenzione su una piccola
cappella, che tuttora si può vedere, a fianco di
palazzo Fumaroli, in Via Luigi Martucci, nel
tratto successivo all’incrocio di questa con Via
Repubbliche Marinare, andando verso S. Giovanni
a Teduccio.
215. All’interno di questa
cappella, si può leggere la seguente iscrizione:
D O M
SACELLUM
QUOD DIVO
BENEDICTO OLIM
VIRTUTE
PIETATE GENERE
CLARISSIMUS
RESTAURAVIT
DOTAVITQUE ONOFRIUS BONVICINUS
CUIUS FAMILIA
INTER VENETOS MAGNATES
AUREIS CARACTERIBUS
ADSCRIPTA
ANNO M DC XL
VI TRANSACTI SECULI
QUOTIDIE UT
SACRUM FIERET
NUNC
MARMOREO
EXPELITAM LAPIDE
SUCCESSOR
NON MINUS
SANGUINE ET
PIETATE QUAM NOBILITATE
DUX MONTIS
CORACY
DOMINUS
IOSEPH IORDANUS
SUE
DEVOTIONIS ETERNE ARGUMENTUM
IN EO ARAM
EREXIT
DECORAVIT DITAVIT
ANNO SAL. M
DCC III
Traduzione:
A DIO OTTIMO
MASSIMO
QUESTO
TEMPIO
GIA’
DEDICATO A SAN BENEDETTO
CHE IL
CHIARISSIMO PER VIRTU’ PIETA’ E NASCITA
ONOFRIO BONVICINO
LA CUI
FAMIGLIA
ERA ASCRITTA
A CARATTERI D’ORO
FRA I
MAGNATI VENETI
RESTAURO’ E
DOTO’
NELL’ANNO
1646 DEL SECOLO SCORSO
AFFINCHE’
FOSSE PER SEMPRE SACRO
ADESSO
ESSENDO
L’ALTARE PRIVO DI LAPIDE MARMOREA
IL
SUCCESSORE NON MINORE
PER ORIGINE
E PIETA’ CHE PER NOBILTA’
DUCA DI
MONTE CORVO
SIGNOR
GIUSEPPE GIORDANO
COME SEGNO
ETERNO DELLA SUA DEVOZIONE
IN ESSO UN
ALTARE
ERESSE
DECORO’ ARRICCHI’
ANNO DELLA
SALVEZZA 1703
216. Subito sotto, vi è
un’altra scritta, in italiano, più piccola:
QUESTO
TEMPIO
NEGLETTO DA
OTTO LUSTRI
GIOVANNI
FUMAROLI
RESTAURO’
E
SOLENNEMENTE FECE INAUGURARE
NEL GIORNO
VI MAGGIO M DCCC LX
(6 MAGGIO
1860)
COZZOLINO VINCENZO 1988
217. A quanto sembra, dunque,
Giovanni Fumaroli (ereditando dal padre,
magistrato Francesco Saverio Fumaroli) venne a
trovarsi in possesso del palazzo e della
cappella, chiusa da 40 anni (otto lustri;
quindi, dal 1820) e la fece restaurare e di
nuovo inaugurare il 6 maggio 1860.
218. Prima dei Fumaroli, la
cappella era evidentemente appartenuta ai
Giordano (Giuseppe Giordano, 1703), i quali a
loro volta erano succeduti ai Bonvicino (Onofrio
Bonvicino, 1646).
219. E prima dei Bonvicino?
Nella scritta, è affermato chiaramente che,
prima del restauro effettuato nel 1646 da
Onofrio Bonvicino, il tempio era dedicato a S.
Benedetto.
220. Poiché abbiamo detto (vedi
n°209) che i monaci benedettini cassinesi
lasciarono Barra nell’anno 1625 e, un po’ alla
volta, cominciarono a vendere le proprietà che
qui avevano, è del tutto ragionevole concludere
che il nostro Onofrio Bonvicino fu uno di quelli
che comprarono dai monaci: comprò, fra l’altro,
la cappella dedicata a S. Benedetto, che fece
poi restaurare nel 1646.
221. Si può quindi ritenere che
la attuale cappella Fumaroli costituisca
l’ultima traccia di quella lontana presenza
benedettina a Barra.
222. E chi è, in coda a così
grandi ed illustri predecessori, il “piccolo”
COZZOLINO VINCENZO 1988 ? Si tratta
semplicemente di un con-cittadino attuale, che
vive insieme alla moglie in un appartamento del
vicino palazzo, e che, animato da uno spirito
veramente nobile ed eroico, cerca di mantenere
con un minimo di decoro la sfortunata cappella
Fumaroli.
Uno strano prete nella Barra di
fine secolo (1694)
223. In una lettera pervenuta
al Tribunale del Sant’Ufficio di Napoli il 3
luglio 1694, il parroco di Barra Don Giuseppe
Carlino (1687-1709), che già abbiamo avuto modo
di conoscere (vedi sopra, n°1 e nn°159-161),
denuncia l’improvviso arrivo nelle campagne di
Barra, fin dal maggio di quello stesso anno, di
un uomo forestiero, di circa 30 anni, che dalla
parlata sembra calabrese, vestito con una tonaca
da prete piuttosto consunta.
Al contadino Giovanni Nappo che
gli ha chiesto chi fosse e da dove venisse, ha
risposto di chiamarsi Francesco di Palma e di
essere “fratello” di un Frate Antonio di cui il
contadino aveva molto sentito parlare
.
Gli addetti del Tribunale non
persero tempo e già nella successiva settimana
di luglio 1694 vennero in Barra per effettuare
una prima inchiesta
.
224. Si trattava, a quanto pare, di un “vero”
prete, nel senso che era stato regolarmente
consacrato, ma si trovava nella condizione,
chiaramente irregolare secondo i canoni
conciliari, di prete “acèfalo e giròvago” in
quanto andava girovagando al di fuori della sua
diocesi di appartenenza senza alcun permesso del
suo vescovo.
Era probabilmente originario di
Palmi (Reggio Calabria) e si presentava come
amico e seguace del famoso frate francescano
cappuccino P. Antonio da Olivàdi (1653-1720)
piccolo paese della Calabria vicino Catanzaro,
che proprio in quegli anni andava percorrendo
come predicatore missionario, “fra l’entusiasmo
delle folle che lo veneravano come santo”,
villaggi e campagne di tutta l’Italia
meridionale.
225. La spiritualità e la
predicazione del P. Olivàdi erano fortemente
incentrate sui “dolori” di Gesù e di Maria. Lo
stesso Padre era autore di un opuscolo, che
aveva avuto grande diffusione, intitolato
“L’anno doloroso – Meditazioni, per ogni giorno
dell’anno, sulla vita dolorosa di nostro Signore
Gesù Cristo”; al quale opuscolo, visto il
notevole successo, ne aveva poi fatto seguire
uno analogo, dedicato stavolta alla “vita
dolorosa” della Vergine Maria.
In effetti, questo tipo di spiritualità era
allora molto sentito e suscitava nei più fedeli
una fervente devozione e fin troppo accesi
desidèri di “disciplinarsi” vigorosamente, a
colpi di cinghie, fruste e funicelle, che i
confessori cercavano poi, di solito vanamente,
di mitigare. Abbiamo visto dianzi (n°148) che
anche le regole della Confraternita
dell’Annunziata di Barra prevedevano “mez’ora di
disciplina ogni venerdì sera”.
226. Salvatore Preite, sensale
di Barra, dichiara che: “… e perché pareva,
tanto a me quanto a gli altri del convicino, che
(Don Francesco) fusse un prete di buona
vita, et andava mendicando per carità, tanto io
quanto altri del nostro convicinato procuràimo
di farlo vivere et havere avuto molte elemosine,
tanto dalli detti miei vicini quanto da altri
del Casale”
.
Si stabilisce in una casa
abbandonata, nella corte in cui viveva Salvatore
Preite, e va in giro per elemosine. Ma “va
nascostamente, perché diceva di non voler essere
veduto da persona alcuna e ho osservato che,
quando andava elemosinando, caminava forte, e
sempre si voltava verso dietro, e non cercava
l’elemosine a tutti, se non a qualche persona
particolarmente o casa particolare”
.
Quando può, discute con la
gente sedendosi su una sedia in mezzo alla
strada, facendo così accorrere uomini, donne e
bambini dei dintorni; la sera, poi, la gente va
a trovarlo nel cortile di Salvatore Preite e lui
organizza veglie spirituali a carattere
fortemente penitenziale.
“Fece spogliare, in più volte,
più figliuoli ignudi, di età da circa 12 anni,
et in sua presenza fattoli disciplinare, lui
dicendo la litania, doppo disse essersi placata
l’ira di Dio, e sarebbero buoni …”
.
227. Comincia così ad essere
conosciuto in paese: la gente gli chiede
brandelli della sua veste per farne delle
reliquie; a chi va da lui, rivela i peccati
gravi commessi in passato e predice, per il
futuro, la salvezza per alcuni e la dannazione
per altri, se non si pèntono; distribuisce
oggettini di cera, da lui benedetti, per
allontanare le disgrazie dalle case …
A Salvatore Preite da’ un poco
di cera “dentro della quale vi stava un poco di
tela vecchia che diceva essere il sacco di S.
Francesco”; anche i vicini accorrono per avere
quella cera e lui ne da’ anche a loro, “e diceva
che avessimo operato bene, atteso che detto
sacco con detta cera chi lo portava addosso era
libero da ogni travaglio”
.
Ma qui il parroco lo viene a sapere ed
interviene facendo bruciare pubblicamente gli
amuleti.
228. Sempre nel cortile di
Salvatore Preite, Don Francesco fa recitare le
litanie della Vergine e, quando sono terminate,
Salvatore gli mostra il suo figliolo Carminiello
“il quale è molto obbediente e buono figlio” ma
lui rifiuta di riceverlo dicendo che il ragazzo
ha commesso un grave peccato, senza peraltro
specificare quale; il padre insiste, chiedendo
di perdonarlo e di benedirlo; e lui, dopo molte
insistenze, fa spogliare il ragazzo, fa
inginocchiare i presenti, e si mette a frustare
il ragazzo sulla schiena con una cinghia di
cuoio mentre gli astanti recitano in coro le
litanie della Vergine; alla fine, dichiara che
il ragazzo è stato perdonato e gli accorda
l’assoluzione e la sua benedizione
.
229. L’inchiesta del Tribunale,
a quanto pare, si svolse anche nei Casali di
Marano e di Quarto, a nord di Napoli, e nel
villaggio di Panecòcolo, sempre su denuncia dei
rispettivi parroci che segnalavano la presenza
di Don Francesco sul loro territorio; ma non
sortì comunque alcun ésito, perché nel frattempo
il nostro si era reso irreperibile, né risulta
d’altronde che siano stati fatti tentativi per
ritrovarlo.
230. La vicenda di questo
strano prete, non eretico né moralmente
riprovevole ma “al di fuori dei ranghi”, può
servire, forse, a mostrarci quale fosse il grado
di organizzazione e di preparazione ormai
raggiunto, alla fine del Seicento, dai parroci
che si erano formati nei Seminari
post-Tridentini.
A quanto pare, essi, da una
parte, avevano il pieno controllo del territorio
e nulla gli sfuggiva; d’altra parte, erano
perfettamente in grado di proporre ai loro
fedeli un tipo di esperienza religiosa, ben
fondata dogmaticamente e ben regolata
moralmente, che tendeva ad elevarli al di sopra
dell’ignoranza e della superstizione medioevali.
Provenienti dal popolo
contadino e ad esso legati, sono i parroci gli
“intellettuali organici” del popolo, alla fine
del Seicento, e ne hanno la direzione culturale
e morale.
In definitiva, nel contesto di
sfruttamento e di emarginazione in cui quel
popolo si trovava
[77], quei “pastori”, pur con tutti i
loro limiti e le loro debolezze, erano
praticamente gli unici che non volevano solo
tosare
[78] e portare alla guerra
[79] le “pecorelle”, ma le avevano a
cuore e se ne prendevano cura.
Cronologia dei Viceré Spagnoli di Napoli
(Nel
Seicento)
Sotto il Regno di Filippo III
(1598-1621):
1599-1601 Fernando Ruiz de
Castro, conte di Lemos
1599 - Fallito tentativo di
rivolta popolare organizzato in Calabria dal
frate domenicano Tommaso Campanella (1568-1639).
Rimane 27 anni in carcere a Napoli (1599-1626).
1601-1603 Francesco de Castro,
conte di Lemos (figlio del precedente)
1602 - Tommaso Campanella, in carcere, scrive
“La città del sole”.
1603-1610 Juan Alonso Pimentèl
de Herrera, conte di Benavente
1610-1616 Pedro Fernandez de
Castro, conte di Lemos (altro figlio di
Fernando)
1616-1620 Pedro Tèllez Giròn,
duca di Osuna (secondo)
1620-1622 Cardinale Antonio
Zapata y Cisneros
Sotto il Regno di Filippo IV
(1621-1665):
1622-1629 Antonio Alvarez de Toledo, duca d’Alba
(secondo)
1629-1631 Fernando Afàn de
Ribera, duca d’Alcalà (secondo)
1631-1637 Manuel de Zuniga y
Fonseca, conte di Monterey
1637-1644 Ramiro Nunez de Guzman,
duca di Medina de las Torres
1644-1646 Juan Alonso Enriquez,
ammiraglio di Castiglia
1646-1648 Rodrigo Ponce de Leon,
duca d’Arcos
1648-1653 Inigo Vèlez de
Guevàra, conte di Onate
1653-1659 Garcia de Avellaneda
y Haro, conte di Castrillo
1659-1664 Gaspar de Bracamonte
y Guzman, conte di Penaranda
1664-1666 Cardinale Pasquale
d’Aragona
Sotto il Regno di Carlo II
(1665-1700):
 |
|
Carlo e Maria Luisa |
1666-1672 Pietro Antonio
d’Aragona
1672-1675 Pedro Alvarez de
Toledo, marchese di Astorga
1675-1683 Fernando Fajardo,
marchese de Los Velez
1683-1687 Gaspar de Haro,
marchese del Carpio
1688-1696 Francisco de
Benavides, conte di Santisteban
1696-1702 Luis de la Cerda,
duca di Medinaceli
Sotto il Regno di Filippo V
(1700-1707):
1702-1707 Giovanni Emanuele
Fernandez Pacheco, marchese di Villena
Cronologia degli Arcivescovi di Napoli
(Nel
Seicento)
1596-1603 Card. Alfonso
Gesualdo
1605-1612 Card. Ottavio
Acquaviva
1613-1626 Card. Decio Carafa
1626-1641 Card. Francesco
Buoncompagno
1641-1666 Card.
Ascanio Filomarino
1667-1685 Card.
Innico Caracciolo
1686-1691 Card.
Antonio Pignatelli
1691-1702
Card. Giacomo Cantelmo
Vedi il paragrafo “Documenti e dati” in
“Il periodo Aragonese (1443-1501)”.
Giuseppe Ceci – “Un mercante mecenate
del secolo XVII-Gaspare Roomer” in
“Napoli nobilissima”, n.s. 1921,
pag.161.
L’ipotesi non è sicuramente
documentabile; si può solo osservare
che, ancora oggi, due corti che si
trovano lungo il Corso Sirena, prima del
rione e del palazzo Bisignano, recano il
nome e l’iscrizione “Cocozza”.
Teresa Colletta, op. cit.
P. Saverio Santagata – “Storia della
Compagnia di Gesù nel Regno di Napoli”,
Parte V – Manoscritto citato da Davide
Palomba in “Memorie storiche di S.
Giorgio a Cremano”, Napoli, 1881.
Citato da D. Palomba, op. cit.
D. Palomba, op. cit. - Alcuni religiosi
“mandati dal cardinale per aiuto e
conforto, trovarono arso e consumato il
tabernacolo e dentro a quello le pissidi
divenute nere, e nel toccarle,
divenivano cenere”.
Citato da Nicola Lapegna – “Origini e
storia di Barra”, Napoli, 1929.
Si veda: Giovanni Alagi – “Ricerche su
Casavaleria, antico Casale dell’agro
vesuviano” in “Asprenas”, anno X, n°4,
1963.
Vedi Cesare De Seta – “I Casali di
Napoli”, Ed. Laterza, Bari 1984, 1989.
Citato da Gabriele Monaco – “Piazza
Mercato: sette secoli di storia”, Ed.
Athena Mediterranea, Napoli, 1970.
Bartolommeo Capasso – “Masaniello”
(1919), ristampa Ed. Luca Torre, Napoli,
1993.
Salvatore de Renzi - ”Napoli nell’anno
1656”- Tip. di Domenico De Pascale,
1867.
Vedi D. A. Parrino “Teatro eroico e
politico dei viceré del regno di
Napoli”.
La Madonna di Costantinopoli è
raffigurata su una nuvola che sovrasta
la città, ed è circondata da angeli che
trasportano brocche d’acqua per spegnere
un incendio, rappresentando così il
grande acquazzone che pose fine
all’incendio della città stessa. Di per
sé, quindi, l’immagine si riferisce alla
salvezza da un incendio, ma a Napoli,
per i motivi detti, fu riferita alla
salvezza dalla peste.
Vedi il paragrafo “I gemelli Musella
allo Scassone (1849-1854)” nel capitolo
dedicato a “L’epoca delle rivoluzioni
borghesi (1790-1860)”.
Vedi il paragrafo “Il gioco del lotto”
nel capitolo dedicato a “La Varra di
Serino nel Cinquecento”.
Vedi il paragrafo “Le fasi della rivolta
dopo la morte di Masaniello” nel
presente capitolo, in particolare i
nn°70-71-72.
Vedi i paragrafi “L’estaurìta di Sirinum
viene data in feudo” e “La contésa” in
“Il periodo Angioino (1266-1442)” nonché
il paragrafo “La parrocchia Ave Gratia
Plena (detta di S. Anna)” nel capitolo
dedicato a “La Varra di Serino nel
Cinquecento”.
Anna Giannetti e Benedetto Gravagnuolo
in “I Casali di Napoli”, Ed. Laterza,
Bari,1984, 1989.
Vedi i nn°133 e seguenti in “La Varra di
Serino nel Cinquecento”.
J. Mazzoleni- “Archivi di monasteri
benedettini conservati presso l’Archivio
di Stato di Napoli”, in “Monastica” IV,
Montecassino 1983, pp. 85-190. Si veda
anche: A. Speme- “Il monastero di S.
Benedetto a Chiaia”, in “Benedictina”
11, 1957, pp. 235-274.
Deposizione di Giovanni Nappo del 5
luglio 1694: “che l’avesse tenuto
secreto, perché era fratello di detto
fra’ Antonio”.
Deposizione di Salvatore Preite, del 5
luglio 1694.
Vedi nn°16-17 e seguenti, in “La Varra
di Serino nel Cinquecento”.