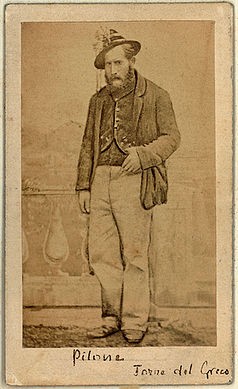Gli anni della Destra liberale
1. L’unità d’Italia
si realizzò, come detto, per opera della classe borghese e sancì
politicamente la egemonia di questa classe, che aveva di fatto nella
Massoneria il suo “partito” ovvero la sua “forma” organizzativa,
politica e ideologica, che si sovrapponeva, con la sua rete di
collegamenti non palesi, alle “libere” istituzioni elettive.
2. Il primo re
d’Italia, Vittorio Emanuele II (1860-1878), colui che i biografi
di corte definirono “il re galantuomo”, fu anche “il re dei
galantuomini”, nel senso che regnò su una società nella quale il
potere era, di fatto, esercitato dai cosiddetti “galantuomini” ossia
i nuovi padroni borghesi: banchieri e speculatori, proprietari
terrieri, proprietari di industrie …
Egli stesso, del resto,
ancorché “galantuomo”, si riservò un appannaggio (allora si diceva
“una lista civile”) che giunse fino al 2% del bilancio dello Stato:
una cifra superiore a quella di qualsiasi altro sovrano europeo del
tempo.
Quale uso facesse
poi, “il galantuomo”, di tutti questi soldi, è faccenda che ha molto
a che fare con la sua celebre amante, Rosa Vercellana, la “bella
Rosina” da lui stesso innalzata, per meriti di alcova, al rango di
“contessa di Mirafiori”: “È una donna ancor bella, ma senza grazia e
senza nessuna distinzione. L’ultima volta che la vidi era al Teatro
Alfieri: portava un cappello guarnito di piume, il suo corpo era
coperto di diamanti: impossibile immaginare una donna vestita con un
cattivo gusto più completo” (Henry d’Ideville – “Diario di un
diplomatico francese”).
 |
Rosa Vercellana (1833-1885), la bella Rosina del Re
galantuomo |
3. Il primo parlamento
italiano, che si insediò a Torino l’8 febbraio del 1861, era
composto in realtà di un solo partito (quello liberale e massonico),
espressione di una sola classe (quella borghese). I parlamentari
erano infatti eletti da non più di 500 mila persone in tutta Italia
(meno del 2% della popolazione): avevano diritto al voto solo i
cittadini di sesso maschile, che avessero compiuto i 25 anni di età,
sapessero leggere e scrivere, e pagassero almeno 40 lire all’anno di
imposte dirette; in pratica, solo i ricchi (maschi). La dialettica
parlamentare si articolava approssimativamente in una Destra e una
Sinistra, peraltro con frequenti cambiamenti di campo da parte dei
singoli parlamentari (trasformismo).
Le grandi masse popolari erano
quindi del tutto escluse da una partecipazione attiva al nuovo Stato
unitario ed i loro interessi sostanzialmente non rappresentati in
parlamento.
4. La Destra liberale, che
aveva egemonizzato il processo risorgimentale
[1], si trovò a gestire la prima fase della vita dello
Stato unitario
[2]: sue principali preoccupazioni furono completare e
consolidare l’unificazione.
Il completamento si
realizzò con l’annessione del Veneto (nel 1866, con la “terza guerra
d’indipendenza”) e poi di Roma (nel 1870, con la famosa “breccia di
Porta Pia”).
Per consolidare
l’unificazione, invece, non si imboccò la strada maestra di una
“assemblea costituente” per dare alla nuova Italia delle nuove
istituzioni, magari accompagnate da qualche pur timida riforma
sociale a vantaggio delle classi meno abbienti.
Si preferì invece la pura e
semplice estensione a tutta la penisola degli ordinamenti fino ad
allora in vigore nello Stato sabàudo, a partire dallo Statuto
“albertino”
: questo confermò, in molti, l’idea dell’unità
italiana come “conquista” e annessione degli altri Stati da parte
dei “piemontesi”.
La colonizzazione del Sud
5. Di conseguenza, nel Regno
meridionale, dove pure non c’erano “stranieri” da “cacciare fuori
d’Italia” e che era unito ed indipendente da 730 anni, si procedette
ad esempio a:
-
l’imposizione (nella patria di Vico e di Filangieri!) dei Codici e
dell’ordinamento giudiziario sabàudi, anche se “in materia di codici
e di amministrazione le province del Sud sono di gran lunga più
progredite del Nord” come protestava già allora il pur unitario
Francesco Crispi;
-
l’imposizione del sistema fiscale sabàudo, assai più esoso e
complicato di quello borbonico: nel Regno meridionale le tasse erano
poche ed assai tenui
, come pure mediamente basso era il “costo
della vita”, soprattutto dei generi di prima necessità;
-
l’imposizione brutale del servizio militare obbligatorio per i
Savoia, anche laddove, come in Sicilia, prima del 1860, la leva
obbligatoria non esisteva: alla prima “chiamata di leva” del 1861,
che prevedeva 5 anni di servizio, si presentarono solo 20.000 dei
72.000 uomini previsti; ne seguirono rastrellamenti indiscriminati
dell’esercito piemontese in tutti i paesi dell’Italia meridionale,
con deportazione di tutti i maschi dalla “apparente” età fra i 20 e
25 anni, e fucilazioni sommarie “per presunta renitenza alla leva”;
-
un forte accentramento amministrativo, con sindaci e prefetti
nominati dal governo: nel 1866, su 59 prefetti in Italia, 43 erano
piemontesi, il resto emiliani e toscani;
ed altre misure che provocarono
un grande e diffuso disagio.
Un ufficiale piemontese
6. Il peggioramento delle condizioni di vita della grande
maggioranza della popolazione del Sud dopo l’unificazione
era talmente clamoroso ed evidente che lo riconoscevano perfino i
più onesti e sensibili tra gli ufficiali dell’esercito
“conquistatore”.
Così, l’ufficiale piemontese, conte Alessandro Bianco di
Saint-Jorioz, capitano nel Corpo di Stato Maggiore Generale,
scriveva in un suo libro èdito nel 1864:
“Il 1860 trovò questo popolo del 1859 vestito, calzato, indùstre,
con riserve economiche. Il contadino possedeva una moneta. Egli
comprava e vendeva animali; corrispondeva esattamente gli affitti;
con poco alimentava la famiglia. Tutti, in propria condizione,
vivevano contenti del proprio stato materiale. Adesso, è l’opposto
...
La pubblica istruzione era sino al 1859 gratuita; cattedre
letterarie e scientifiche in tutte le città principali di ogni
provincia. Adesso, veruna cattedra scientifica …
Nobili e plebei, ricchi e poveri, qui tutti aspirano … ad una
prossima restaurazione borbonica”
.
7. Il buon conte Jorioz intendeva in realtà difendere la causa
“piemontese”, ma pensava di poterla difendere riconoscendo la verità
ed esortando il suo governo a cambiare atteggiamento verso il Sud.
Se non che: “Non poteva, la mal consigliata difesa, riuscire ad
un’accusa più sarcastica e acerba contro il nuovo ordine di cose in
Italia. Ciò fu agevolmente inteso dai liberali e dal loro Governo.
Onde il libro del sig. Jorioz, in cambio di accattar lode, venne
fieramente censurato dai giornali del partito e dai Deputati in
pubblico Parlamento, e il Jorioz, invece di promozione, come egli
forse s’imprometteva, fu quasi destituito coll’esser posto, come
dicono, alla seconda classe. Novello esempio del come i Governi
liberaleschi amano d’essere illuminati sulle calamità dei popoli, e
comportano la libertà di discussione, quand’ essa per la caparbietà
invincibile del vero torna a manifestazione delle loro vergogne” (P.
Matteo Liberatore, ivi).
Il duca di Maddaloni
8. Il 20 novembre 1861 il deputato di Casoria al nuovo parlamento
italiano, Francesco Proto, duca di Maddaloni (1815-1892),
presentò una “Mozione di inchiesta per le province napoletane” in
cui accusava apertamente il governo piemontese di avere invaso e
depredato il Napoletano e la Sicilia:
“Intere famiglie véggonsi accattar l'elemosina; diminuito, anzi
annullato il commercio; serrati i privati opifìci …
E frattanto tutto si fa venir dal Piemonte, persino le cassette
della posta, la carta per i Dicasteri e per le pubbliche
amministrazioni.
Non vi ha faccenda nella quale un onest’uomo possa buscarsi alcun
ducato che non si chiami un piemontese a disbrigarla.
A mercanti di Piemonte si danno le forniture più lucrose.
Burocrati di Piemonte occupano quasi tutti i pubblici uffizi, gente
spesso ben più corrotta degli antichi burocrati napoletani, e di una
ignoranza e di una ottusità di mente, che non tenèasi possibile
dalla gente del mezzodì.
Anche a fabbricar le ferrovie si mandano operai piemontesi, i quali
oltraggiosamente si pagano il doppio che i napoletani.
A facchini della dogana, a carcerieri, a birri, vengono uomini di
Piemonte; e donne piemontesi si prendono a nutrici dell’ospizio dei
trovatelli, quasi neppure il sangue di questo popolo più fosse bello
e salutevole.
Questa è invasione non unione, non annessione!
Questo è voler
sfruttare la nostra terra come terra di conquista.
Il governo di Piemonte vuol trattare le provincie meridionali come
il Cortez ed il Pizarro facevano nel Perù e nel Messico … come gli
inglesi nel regno del Bengala”.
 |
Francesco Proto, duca di Maddaloni (1815-1892) |
9. La presidenza della Camera invitò il deputato a ritirare la sua
mozione e, al suo rifiuto, ne vietò la discussione in Aula e non ne
autorizzò la pubblicazione negli Atti parlamentari. Il duca, il
giorno successivo, per protesta, rassegnò le dimissioni (erano
davvero altri tempi …).
Il bilancio di Fortunato e di Salvemini
10. Alcuni decenni più tardi, del resto, erano proprio i meridionali
unitaristi che traevano i più amari bilanci.
Così, il lucano Giustino Fortunato (1848 – 1932), in una famosa
lettera a Pasquale Villari (n. 89 del 2 settembre 1899), scriveva:
“L’unità d’Italia è stata e sarà, ne ho
fede invitta, la nostra redenzione morale (!?).
Ma
è stata, purtroppo, la nostra rovina economica. Noi eravamo, nel
1860, in floridissime condizioni per un risveglio economico, sano e
profittevole. L’unità ci ha perduti.
E come se questo non bastasse, è provato, contrariamente
all’opinione di tutti, che lo Stato italiano profonde i suoi
benefici finanziari nelle province settentrionali in misura ben
maggiore che nelle meridionali”.
11. Gli fece eco Gaetano Salvemini (1900):
“Se dall’unità d’Italia il Mezzogiorno è stato rovinato, Napoli è
stata addirittura assassinata … è caduta in una crisi che ha tolto
il pane a migliaia e migliaia di persone”.
L’economia “fino all’osso”: di chi?
12. Allora, però, subito dopo
l’unificazione, per i “galantuomini”, il problema più grave era
quello del debito pubblico del nuovo Stato.
Napoli aveva chiuso il suo
ultimo bilancio, prima della unificazione, con un avanzo di
circa 9 milioni (in lire).
Il Regno subalpino, al momento
della unificazione, aveva invece un dis-avanzo di più di 90
milioni (in lire) e la Toscana un dis-avanzo di più di 14
milioni (in lire).
L’ammontare degli interessi
sul debito pubblico, prima della unificazione, era
spaventosamente più alto nel Regno sabàudo (13,93 lire pro càpite)
che in qualsiasi altro Stato della penisola: nel Regno delle due
Sicilie era solo di 3,58 lire pro càpite
.
13. Il nuovo Regno d’Italia
nacque dunque gravato da un debito che aveva ereditato
esclusivamente dal Regno sabaudo e dalla Toscana; ed al primo
bilancio finanziario, nel 1862, aveva entrate (450 milioni in lire)
che erano meno della metà delle uscite!
14. Per far fronte a questa
situazione, gli economisti liberali (celebre, e meno peggio fra
tutti, il “risparmiatore di calamai”, ministro Quintino Sella)
pensarono di essere “rigorosi” facendo pagare a tutti i nuovi
“italiani” i debiti che avevano contratto solo quelli del
Nord, e per di più facendo pagare ai poveri i debiti di un
Regno governato esclusivamente dai ricchi.
Ricorsero, cioè, ad una forte
imposizione fiscale (che andò a gravare, naturalmente, soprattutto
sulle grandi masse più povere); nonché ad un rigoroso controllo su
tutte le spese dello Stato (“economia fino all’osso”) che però non
valeva quando si trattava di regalare soldi pubblici alla
“consorteria cavourrista” che era al potere (vedi appresso).
15. In conseguenza, si arrivò
(nel 1868) persino alla famigerata “tassa sul macinato”, che venne
giustamente definita “l’imposta progressiva sulla miseria” perché
colpiva in pratica il consumo del pane, proprio mentre i contadini
perdevano anche i loro diritti di “usi civici” sulle terre
demaniali, comprate a prezzi stracciati dai ricchi proprietari
terrieri.
La tassa veniva
calcolata per mezzo di un contatore applicato alle màcine dei mulini
e procurava allo Stato un introito sicuro di un centinaio di milioni
l’anno. Al momento della sua applicazione, vi furono ovunque
proteste e rivolte, che vennero represse con ben 250 morti!
16. Si procedette, inoltre,
come nel Decennio francese, alla (s)vendita di terre demaniali,
ed alla espropriazione e (s)vendita dei beni ecclesiastici,
incamerati attraverso la soppressione degli Ordini religiosi.
La soppressione cominciò subito dopo il 1860, e divenne
generalizzata con la Legge nazionale del 7 luglio 1866. A Napoli, in
particolare, il cardinale arcivescovo Sisto Riario-Sforza
(1846-1877) fu costretto all’esilio, dal 1860 al 1866.
Nel 1875, venne finalmente
conseguita la agognata “parità di bilancio”: durò poco, ma il
rapporto della Destra liberale con la società, nel conseguimento di
questo obiettivo, si era ormai ampiamente logorato. L’anno dopo,
andò al governo, con Agostino Depretis, la così detta Sinistra.
“La così detta Destra
(“liberale” o “storica”) era più una cricca di burocrati,
generali e proprietari terrieri che un partito politico”
[7]. La così detta Sinistra fu migliore?
La sintetica opinione di Antonio Gramsci
17. “Lo Stato borghese italiano si è formato per la spinta di
nuclei capitalistici dell'Italia settentrionale che valevano
unificare il sistema dei rapporti di proprietà e di scambio del
mercato nazionale, suddiviso in una molteplicità di staterelli
regionali e provinciali.
Fino all'avvento della Sinistra (liberale) al potere
(quindi, negli anni della Destra liberale), lo Stato italiano ha
dato il suffragio solo alla classe proprietaria, è stato una
dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l'Italia
meridionale e le isole, crocifiggendo, squartando, seppellendo vivi
i contadini poveri, che scrittori salariati tentarono d’infamare col
marchio di «briganti».
Lo sviluppo dell'industria rafforzò lo Stato unitario: la
Sinistra (liberale) andò al potere, allargò il suffragio,
introdusse un pizzico di «democrazia». La dittatura industriale
non fu però meno feroce della dittatura della media borghesia e
dei proprietari terrieri che si erano saziati coi beni
ecclesiastici: lo Stato si pose al servizio dell'industria e
nel 1898 soffocò i movimenti nei quali la classe operaia per la
prima volta si sollevò contemporaneamente ai contadini poveri di
Sicilia e di Sardegna”
.
Il Risorgimento: di chi?
18. In definitiva, che cosa era
veramente accaduto in quel 1860 e negli anni immediatamente
successivi?
Semplicemente, aveva ragione il
duca di Maddaloni: il Regno meridionale era stato conquistato
militarmente dal Regno sabàudo ed era diventato una colonia
di esso, né più né meno di quei paesi extra-europei che erano
stati conquistati militarmente ed erano diventati colonie
dell’Olanda, della Spagna, del Portogallo, della Francia,
dell’Inghilterra …
19. “L’unità d’Italia
non era avvenuta su una base di uguaglianza ma come egemonia
del Nord sul Mezzogiorno … il Nord, concretamente, era una
piovra che si arricchiva a spese del Sud ed il suo
incremento economico-industriale era in rapporto diretto con
l’impoverimento dell’economia e dell’agricoltura meridionale”
.
“La egemonia del Nord
sarebbe stata normale e storicamente benefica se
l’industrialismo avesse avuto la capacità di ampliare con un
certo ritmo i suoi quadri, per incorporare sempre nuove zone
economiche assimilate …
Si sarebbe avuta, allora, una
rivoluzione economica di carattere nazionale anche se il suo
motore fosse stato temporaneamente e funzionalmente regionale.
Tutte le forze economiche sarebbero state stimolate e, al
contrasto, sarebbe succeduta una superiore unità. Ma invece non
fu così.
L’egemonia si presentò come
permanente; il contrasto si presentò come una condizione
storica necessaria, per un tempo indeterminato e quindi
apparentemente perpetua, per l’esistenza di una industria
settentrionale”
.
20. Non è vero, infatti, che,
al momento dell’unificazione, il Nord fosse prevalentemente
“industriale” (e genericamente “più progredito”) ed il Sud, invece,
prevalentemente “agricolo” (e genericamente “più arretrato”).
I dati numerici sono chiari e
precisi:
-
censimento ufficiale del 1861: nell’Italia meridionale, gli addetti
alle attività industriali sono il 51% del totale degli occupati
nell’industria in Italia;
-
censimento ufficiale del 1951: nell’Italia meridionale, gli addetti
alle attività industriali sono il 12,8% del totale degli occupati
nell’industria in Italia.
In 90 anni di “unità nazionale”
(1861-1951), si è
quindi attuato un vero e proprio processo, complementare e costante,
di de-industrializzazione del Sud e industrializzazione
del Nord.
Sempre dai dati ufficiali si
rileva che l’incidenza del reddito del Sud, su quello
complessivo dell’Italia, è del 40% nel 1861; scende al 22% nel 1901.
Quindi: sia in termini di struttura industriale sia in
termini di reddito pro-càpite,
il Nord, come dice
Gramsci, “concretamente, era una piovra che si arricchiva
a spese del Sud”.
21. Il “meccanismo” è ben noto
agli storici, è del tutto generale, e si può dire che si presenti,
in forme analoghe, in tutte le epoche (“cambia il maestro,
cambiano i suonatori dell’orchestra, ma la musica è sempre la
stessa”).
La forma specifica
dell’epoca moderna ha la sua data ufficiale di nascita nel
1492, con l’inizio della colonizzazione delle Americhe da parte
degli Europei: la conquista e lo sfruttamento economico di paesi
“altri” consentono alla borghesia dei paesi conquistatori e
colonizzatori di realizzare quella “accumulazione primitiva” di
capitale che fa da “innesco” al modello capitalistico di società.
La borghesia meridionale
22. In tutte le colonie, è però
necessaria anche una borghesia locale che fa da tramite con
la metropoli: si allea servilmente con i conquistatori e ne ottiene,
in cambio, una posizione privilegiata.
23. In questo senso, mutati i
tempi ma non i costumi, nell’Italia meridionale accadde nell’Ottocento
qualcosa di analogo a quanto era accaduto nel Duecento.
Nel Duecento, una parte
decisiva dell’aristocrazia feudale meridionale abbandonò e
tradì Manfredi e Corradino di Svevia, e passò armi e bagagli dalla
parte degli invasori Angioini, con l’intento di conservare ed anzi
di accrescere, nel nuovo “regime”, il suo potere ed i suoi
privilegi.
Nell’Ottocento, una parte
decisiva della borghesia meridionale (e degli antichi nobili,
opportunisticamente riciclatisi come “liberali”) abbandonò e tradì
Ferdinando II e Franceschiello di Borbone, e passò armi e
bagagli dalla parte degli invasori Sabàudi, con l’intento di
conservare ed anzi di accrescere, nel nuovo “regime”, il suo potere
ed i suoi privilegi.
24. Di questa borghesia
meridionale abbiamo già parlato (vedi i nn°1-6 e 255-263 del Cap.
10.II).
Erano i “nuovi proprietari
terrieri nelle provincie”: i Mastro Don Gesualdo e i Mazzarò, di
Giovanni Verga; i don Calogero Sedàra, di Tomasi di Lampedusa. Erano
i gradi medio-alti delle forze armate e della burocrazia statale.
Era il vasto ceto medio dei professionisti: notai, giuristi,
avvocati, medici, farmacisti, professori universitari,
proto-giornalisti …
Ruotavano intorno alla corte,
ai tribunali, alla règia amministrazione, ai palazzi dei nobili di
cui ambivano le terre, i titoli, i privilegi sociali e le fortune
economiche …
“Al Sud questa classe è stata,
ed è, un’autentica maledizione, un morbo sociale … un male
relativo, prima dell’unità; un male assoluto dopo, allorché passa al
servizio della Tosco-Padania, che la insignisce del potere
politico e della gestione della spesa pubblica …” (Zitara,
pag.16).
25. In altri termini: la
borghesia meridionale, che non aveva avuto nel 1799 né aveva nel
1860, le capacità e la forza di fare da sé la sua rivoluzione
e di prendere il potere come era accaduto in altri paesi europei,
raggiunse tuttavia il suo scopo con l’aiuto dell’esercito e della
diplomazia sabàudi
, accettando in cambio di sub-ordinarsi alla
borghesia del Nord.
Oggi come allora
26. “E’ questo un punto-chiave, che ha consentito la
realizzazione e consente la perpetuazione della
dipendenza allora realizzata.
Si è poco ragionato, fin ad ora, sulla costituzione di fatto,
di tipo neo-feudale, che la conquista ha assegnato al territorio,
sequestrandolo, ancor prima che nella capacità di esprimere
produzione, nella capacità di elaborare proprie forme di
potere.
Tale costituzione di fatto si articola in un sistema
politico che ingloba, in posizione dipendente, le classi
dirigenti meridionali, a cui è rimessa la gestione delle risorse
pubbliche e l’amministrazione dei rapporti civili, cioè
praticamente tutte le risorse della vita di un Meridione di
cui è stata sterilizzata la capacità produttiva.
Con la costruzione di un tale sistema, la conquista entra nei gangli
delle relazioni quotidiane della vita sociale, de-potenzia le
resistenze, annebbia le volontà e le menti”
.
Il contesto economico internazionale
27. Ben chiaro è anche il
contesto economico internazionale nel quale questo processo avvenne.
Già il 27 ottobre 1860 (solo il giorno prima, 26 ottobre, vi era
stato il famoso “incontro a Teano” fra Garibaldi e Vittorio Emanuele
II) il Ministro degli esteri britannico, Russel, inviò un dispaccio
ufficiale all’Ambasciatore inglese a Torino, sir James Hudson, che
diceva:
“Il
governo di Sua Maestà non vede motivi sufficienti per partecipare
alla severa censura che l’Austria, la Francia, la Prussia e la
Russia hanno inflitto all’operato del re di Sardegna … piuttosto
preferisce volgere lo sguardo alla lusinghiera prospettiva di un
popolo che costruisce l’edificio della sua indipendenza”.
28. In effetti: “A metà ottocento, la rivoluzione commerciale aveva
già trasformato il mondo nel consumatore universale delle merci
inglesi ed il nazionalismo di Ferdinando II di Borbone dava fastidio
a chi (gli inglesi) intendeva spadroneggiare sugli zolfi
siciliani e sulle rotte mediterranee. Cosicché, la diplomazia
britannica offrì il Sud in dono al sussiegoso conte di Cavour ed al
libero saccheggio sabàudo” (Zitara, pag. XV della Premessa).
Uno stato “liberale”: con chi?
29. Abbiamo già detto (vedi nn°414-426
del Cap. 10.II; e sopra, n°20), che la prima rivoluzione
industriale, sia pure in ritardo rispetto all’Inghilterra e ad
altre nazioni europee, era arrivata anche nella nostra penisola,
intorno alla metà dell’Ottocento e, stando ai dati numerici, era
arrivata al Sud più che al Nord.
Dopo l’unificazione, e grazie
ad essa, lo Stato liberale borghese, che in teoria era
neutrale e non interveniva nel “libero gioco della competizione di
mercato”, in pratica intervenne molto attivamente
nell’economia.
Ed intervenne, precisamente,
per smantellare l’industria meridionale e favorire quella
incipiente del Nord, consentendo così a quest’ultima di
realizzare la sua “accumulazione primitiva” e di poter partecipare a
pieno titolo, sia pure come “ultima della classe” europea, alla
seconda rivoluzione industriale del capitalismo internazionale,
sul finire dell’Ottocento e l’iniziare del Novecento.
Lo Stato unitario italiano,
cioè, non intervenne solamente per eliminare le barriere doganali
fra le varie parti della penisola e creare così le condizioni di un
“libero mercato” interno, come era previsto dalla dottrina economica
liberale, ma fu il “braccio operativo” direttamente utilizzato dalla
borghesia del Nord per accrescere le proprie fortune.
Il programma economico del
Risorgimento
30. Al Nord, intorno al 1860,
vi erano solo piccoli nuclei di borghesia industriale, che
non avevano ancora realizzato “l’accumulazione primitiva di
capitale” necessaria per innescare uno sviluppo industriale su larga
scala.
La maggior parte della
borghesia sabàuda (come lo stesso Cavour, del resto) era una
borghesia agraria: erano proprietari terrieri interessati
anzitutto ad ampliare l’area di smercio dei loro prodotti agricoli.
A questo, però, si opponevano
le barriere doganali che separavano fra di loro i vari stati in cui
era divisa la penisola, nonché la carenza di una rete di trasporti
moderni (le ferrovie).
Inoltre, vaste aree di terreni
agricoli erano demaniali, ed aree ancor più vaste appartenevano alla
Chiesa, ed i nuovi proprietari terrieri borghesi ambivano ad
impadronirsi di queste terre per “renderle produttive” ovvero
utilizzarle secondo il criterio del “massimo profitto” (per loro).
31. A costoro, nei suoi
“Scritti economici” e nei suoi discorsi al parlamento sabàudo prima
dell’unità, il Cavour esponeva, in solida prosa liberista, il
“programma economico” del Risorgimento italiano:
-
il libero commercio favorirà le nostre esportazioni agricole in
tutta la penisola;
-
una organica rete ferroviaria favorirà gli scambi fra le sue varie
parti;
-
l’espropriazione delle terre ecclesiastiche, già utilmente
sperimentata nel periodo “francese”, potrà diventare ancor più
ampia;
-
potremo fare anche noi la nostra rivoluzione industriale “come
l’Inghilterra”.
32. Con questi “concretissimi”
argomenti, il Cavour convinse quella borghesia sabàuda, che si era
arricchita ed aveva comprato titoli nobiliari sotto il dominio
francese, che in famiglia parlava francese, che mandava i suoi figli
a studiare nelle Università francesi e svizzere … a diventare
“patriotticamente” italiana, anzi addirittura porta-bandiera
dell’unità d’Italia.
Naturalmente, purché ciò
avvenisse … sotto lo Statuto “albertino” … Italia e Vittorio
Emanuele … avanti, Savoia!
Tanto per cominciare …
33.
Coerentemente, quando siffatta classe sociale raggiunse il potere
nell’Italia “una e indipendente”, gli strumenti iniziali (e non
solo) della sua politica di sfruttamento coloniale ai danni
del Sud furono: un prelievo fiscale esoso fino al limite della
sopportabilità; il drenaggio dei capitali verso il Nord e la
strozzatura del credito al Sud; gli investimenti pubblici
preferenziali per il Nord e la diminuzione delle commesse alle
imprese del Sud.
“Prima di morire, nel giugno
del 1861, appena 3 mesi dopo la proclamazione del Regno d’Italia,
Cavour fece in tempo: a chiudere l’industria di Stato
duo-siciliana; a mettere sul lastrico gli imprenditori privati
(fra cui gli stranieri richiamati nel Regno dal protezionismo
borbonico); a stendere al tappeto il Banco delle due Sicilie;
a liquidare il porto di Napoli spostando la dogana con la
Francia a Genova …” (Zitara, pag. 281).
E dopo Cavour …
34. Dopo di lui, il “programma
economico” da lui delineato proseguì implacabile, ad opera della
“consorteria cavourrista” che con lui era arrivata al potere.
I fatti e le cifre sono
ampiamente illustrati e documentati in numerose pubblicazioni e non
è quindi necessario riportarle in questa sede.
Basterà qui riferire l’espressivo bilancio di tutto il periodo
liberale, tratto nel 1923 non da un nostalgico dei Borboni ma da
colui per il quale “l’unità d’Italia è
stata e sarà, ne ho fede invitta, la redenzione morale delle genti
del Sud”, e cioè Giustino Fortunato (lettera n. 58 del 14
giugno 1923, diretta a Salvemini):
“Non disdico il mio unitarismo. Ho modificato soltanto il mio
giudizio sugli industriali del nord. Sono dei porci più porci dei
maggiori porci nostri. E la mia visione pessimistica è completa”.
Facciamo i nomi …
35. Poiché però agli allievi
delle scuole italiane, fin da piccoli, vengono indicate, circonfuse
di gloria, le figure aureolate degli “eroi del Risorgimento” (i vari
Cavour, Vittorio Emanuele, Garibaldi, Mazzini, etc.) e poiché le
città meridionali sono state riempite di strade e piazze ad essi
dedicate, non sarà qui inutile “fare i nomi” almeno di alcuni dei
veri (anti) eroi del cosiddetto Risorgimento ovvero dei
primi artefici dell’asservimento e del saccheggio del Sud a
vantaggio di una piccola minoranza di predoni e saccheggiatori in
guanti bianchi.
36. Accortamente celati-si, in
vita, sotto la retorica delle fanfare dei bersaglieri che avanzano
sventolando il tricolore e suonando l’Inno del povero Goffredo
Mameli, questi personaggi si meritano invece una ben più larga
in-famia presso i posteri.
Ci premuriamo pertanto qui di
“fare i nomi” di alcuni esponenti di quella “consorteria
cavourrista” e sono i nomi di Carlo Bombrini, Pietro Bastogi e
Domenico Balduino.
La banca di Carlo Bombrini (e dello
Stato)
37. Il Banco delle due Sicilie,
fin da quando ricevette la sua classica forma dal ministro Luigi de’
Medici nel 1815, era una banca pubblica: lo Stato ne era
l’unico ed esclusivo proprietario.
Il Banco coniava la moneta (il
ducato napoletano), raccoglieva i risparmi dei privati cittadini (ai
quali rilasciava una accorsata “fede di credito”) e, con entrambi,
concedeva prestiti a privati e faceva investimenti pubblici in
economia.
38. Per contro, “la Banca
Nazionale del Regno di Sardegna fu una azienda privata sin
dalla nascita e tale rimase … fino alla fine dei suoi giorni nel
1894”: il banchiere massone genovese Carlo Bombrini
(1804-1882) ne era direttore e, cospicuamente, proprietario.
Cavour ne aveva voluto fare
anche la banca centrale del Regno sabàudo: come dire, due in
una, in cui gli interessi privati, a partire da quelli di Bombrini e
suoi, si intrecciavano con quelli pubblici.
La rapida ascesa dell’Ansaldo
di Genova, di cui Bombrini era con-proprietario, favorita dallo
Stato italiano a scàpito di Pietrarsa, costituisce solo uno degli
esempi più durevoli di questo intreccio.
 |
Carlo Bombrini (1804-1882) |
39. Comunque, “nel giugno 1859,
la Banca Nazionale sabàuda era sull’orlo del fallimento. Due anni
dopo, grazie all’unificazione italiana, aveva centinaia di
milioni-oro in cassa. Su come abbia fatto, non ci sono altre
spiegazioni che: il bottino del vincitore. Sul saccheggio, non
esistono dubbi” (cfr Zitara, cap.12).
Pietro Bastogi: chi era costui?
40. Il ministro delle finanze
dell’ultimo governo Cavour, e dunque il primo dell’Italia unita, fu
invece il banchiere massone livornese Pietro Bastogi
(1808-1899).
Personalmente, non aveva altri
meriti “patriottici” se non quello di essere stato, in gioventù,
assai cautamente mazziniano: gestiva, con discrezione, la cassa del
partito.
Ma “il padronato toscano,
che egli rappresentava, oltre a rivendicare il merito di aver
trascinato con sé nelle braccia dei Savoia l’Italia centrale, era
alquanto ricco e riscuoteva la fiducia dei banchieri massoni del
Regno Unito: cosa che aveva avuto notevole peso nel momento in
cui Cavour era stato costretto a battere cassa. A vittoria ottenuta,
avendo portato molto, i toscani pretesero di entrare nella stanza
dei bottoni” (cfr Zitara, pagg. 282-283).
 |
Pietro Bastogi (1808-1899) |
41. Fu Pietro Bastogi, ben più
delle pallide figure politiche che si succedettero come primi
ministri dopo Cavour, il “fiero leader dei profittatori di
regime” (Zitara).
In particolare, fu lui, amico
personale nonché socio in affari di Cavour, a confezionare “le 3
polpette avvelenate” fatte ingurgitare fin dalla culla alla neonata
Italia e cioè: la unificazione del debito pubblico degli ex Stati;
il sistema fiscale nazionale; la costituzione della cosiddetta
Società Italiana per le Strade Ferrate “Meridionali”.
Domenico Balduino e le terre ecclesiastiche
42. Dal canto suo, il banchiere
Domenico Balduino (1824-1885), divenuto grazie a Cavour l’animatore
della Società di Credito Mobiliare con sede a Torino, “emulò
sfacciatamente e superò in ingordigia Pietro Bastogi. Se questi,
infatti, scroccò denaro pubblico ma almeno stese i binari della
ferrovia promessa, Balduino rubò soltanto. Stranamente, fu uno dei
pochi illustri malfattori dell’epoca che il re non fece conte” (Zitara,
pag. 308).
43. Si è già detto sopra che,
subito dopo l’unificazione, si procedette, come nel Decennio
francese, alla vendita sotto costo (per realizzare subito nuove
entrate) delle terre demaniali e delle terre
ecclesiastiche confiscate attraverso la soppressione degli
Ordini religiosi.
“Questa gigantesca operazione,
avviata nel 1862, raggiunse nel 1868 il suo punto culminante, era
compiuta circa per metà nel 1870, e continuò con notevole intensità
fino al 1880.
Essa riguardò: 750.000 ettari
di beni dell’asse ecclesiastico; 190.000 ettari di beni
ecclesiastici siciliani; 30.000 ettari di beni demaniali. In tutto,
perciò, 1.240.000 ettari, di cui la maggior parte erano i 940.000 di
terre ecclesiastiche.
Dalla (s)vendita, lo Stato
incassò circa 1 miliardo di lire, somma certamente assai
inferiore al valore reale dei beni”
.
44. Le terre, naturalmente,
furono acquistate da chi le poteva pagare cioè da quelli che erano
già latifondisti: le condizioni di vita dei contadini, che erano più
miti sulle terre ecclesiastiche, peggiorarono drasticamente sotto i
nuovi padroni borghesi ed in più essi perdettero gli “usi civici”
sulle terre demaniali.
“Al centro di questa nobile e
patriottica vicenda sta Domenico Balduino” (Zitara, pag. 307).
45. Lasciamo al volenteroso lettore interessato il còmpito di
approfondire le “nobili gesta” dei tre sopra lodati, con tutto il
necessario corredo scientifico di analisi e di documentazione,
studiando la fondamentale opera citata di Nicola Zitara (vedi sopra,
nota 3).
 |
Nicola Zitara (1927-2010), grande storico ed
economista meridionale |
La repressione a Pietrarsa (giovedì 6 agosto 1863)
46. Per il lettore, invece, non specialista di economia e finanza,
sarà forse più esplicativa la semplice lettura del seguente articolo
di giornale, riguardante un emblematico episodio accaduto proprio
non lontano da Barra, a Pietrarsa nel 1863.
47. “Il Popolo d’Italia” del 7 agosto di quell’anno scrive:
“Un tal Jacopo Bozza, uomo di dubbia fama, ex impiegato del
Borbone, già proprietario e direttore del giornale “La Patria”,
vendutosi anima e corpo all’attuale governo, aveva avuto in
compenso da questo governo moralizzatore la concessione di
Pietrarsa.
Costui, divenuto direttore di questo ricco opificio, che è il più
bello e il più grande d’Italia, avea per lurido spirito
d’avarizia accresciuto agli operai un’ora di lavoro al giorno, cioè
11 ore da 10 che erano prima; ad altri licenziamento, pur se nel
contratto d’appalto c’era l’obbligo di conservare tutti ...
Gli operai così detti battimazza, che avevan prima 32
grana di paga al giorno, eran stati ridotti a 30 grana; e
questi, dopo aver invano reclamato su tale torto, ieri annunziarono
al Bozza che essi erano decisi piuttosto ad andar via anziché
tollerare la ingiustizia, e perciò gli domandarono il certificato di
ben servito.
Pare che il Bozza non solo abbia negato il certificato, ma abbia
risposto con un certo Ordine del giorno ingiurioso a’ poveri
operai.
Allora ci fu che uno di questi suonò una campana dell'opificio,
verso le 3 p. m., ed a tale segnale tutti gli operai, in numero di
600 e più, lasciarono di lavorare ammutinandosi, e raccoltisi
insieme gridarono “Abbasso Bozza” ed altre simili parole di sdegno.
Il Bozza, impaurito a tale scoppio, si dié alla fuga; fuggendo
precipitosamente, cadde tre volte di seguito per terra; indi si recò
personalmente, o mandò un suo fido, com’altri dice, a chiamare
i bersaglieri che erano di
guarnigione in Portici,
perché accorressero a ristabilire l’ordine in Pietrarsa, non
sappiamo in che modo narrando l’avvenimento al comandante.
E così accorse un maggiore con una compagnia di bersaglieri. Nel
frattempo un capitano piemontese, addetto a dirigere i lavori
dell’opificio, uomo onesto e amato dagli operai, mantenne questi
in quiete, aspettando che arrivasse qualche autorità di Pubblica
Sicurezza o la Guardia Nazionale per esporre le loro ragioni.
Ma ecco che invece giunsero i bersaglieri con le baionette in canna:
gli operai stessi, che erano tutti inermi, aprirono il cancello, ed
i soldati con impeto inqualificabile si slanciarono su di essi
sparando i fucili e tirando colpi di baionetta alla cieca,
trattandoli da
briganti
e non da cittadini italiani, qual erano quegli infelici!
Il capitano che dirigeva i lavori, e del quale abbiamo accennato più
sopra, si fece innanzi con kepì in mano, e gridando a nome
del Re fece cessare l'ira della soldatesca …
Cinque operai
rimasero morti
sul terreno, per quanto si asserisce: altri che gettaronsi a mare,
cercando di salvarsi a nuoto, ebbero delle fucilate nell’acqua, e
due restarono cadaveri.
I feriti sono in tutto circa venti:
sette feriti gravemente
furono trasportati all'Ospedale de’ Pellegrini, altri andarono nelle
proprie case.”
Ferdinando II di Borbone a Pietrarsa
48. in questo articolo, notiamo anzitutto che, nel 1863, quindi
subito dopo l’unità d’Italia, è per tutti ovvio ed evidente (tanto
che l’autore dello scritto lo dà per scontato) che lo stabilimento
industriale di Pietrarsa è non soltanto “un ricco opifìcio” ma “il
più bello e il più grande d’Italia”.
In effetti, esso era stato voluto da Ferdinando II di Borbone (mezzo
secolo prima della Breda e della Fiat) ed era stato costruito con
fondi pubblici (= Banco delle due Sicilie) e con il lavoro di operai
e tecnici qualificati meridionali.
“Spesso i vecchi operai di Pietrarsa ricordavano l’aitante figura
del Re che percorreva le corsie da lavoro con un fare bonario,
compiacendosi chiamarli per nome per sentire i loro bisogni e
prendere consiglio su questo e quello”
.
Luigi Corsi
49. A dirigerlo, fin da quando era ancora una piccola officina nel
1837, fu chiamato il tenente d’artiglieria Luigi Corsi, che ne fu il
geniale direttore tecnico ed organizzativo fino al 1860, quando,
raggiunto il grado di colonnello, “intese condividere la sorte del
suo profugo Re (Francesco II di Borbone), ritirandosi a vita
privata”.
Gli stessi operai, in quella circostanza, vollero unanimi a lui
rivolgere un commosso messaggio:
“Perché si ricordassero la solerzia, l’onestà e la rara intelligenza
che rifulsero nel colonnello Luigi Corsi nella direzione
dell’opificio di Pietrarsa dal 1840 al 1860 … è stato necessario
sottolineare i punti salienti della sua attività al riguardo … fu
sotto la sua direzione che, per ben 20 anni, 800 artefici ebbero
lavoro e pane … noi umili lavoratori gli mandiamo reverente un
saluto e, a testimonianza dell’opera sua, indichiamo qui sotto i
lavori di maggior pregio compiuti nell’opificio dal 1840 al 1860 …”
.
50. Il nome di Luigi Corsi è anche ricordato nel piedistallo della
colossale statua in ghisa (4,50 metri di altezza) che gli stessi
operai vollero dedicare a Ferdinando II di Borbone l’11 gennaio
1853, giorno di compleanno del Sovrano.
Dopo la conquista sabàuda
51. Al momento della conquista sabàuda, nel 1860, a Pietrarsa
lavoravano 850 operai, più 200 “operai straordinari” e 75
artiglieri.
52. Il nuovo governo italiano diede incarico all’ing. Sebastiano
Grandis, Ispettore delle Ferrovie, di preparare una relazione sullo
stato di quelle officine ed egli, il 15 luglio 1861, presentò una
relazione in cui evidenziava tutti e soltanto gli aspetti
negativi dell’attività dell’opificio, magnificando quindi, per
contrasto, tutti e soltanto i vantaggi e le prospettive di
sviluppo della Ansaldo di Genova: della quale, guarda caso, erano
comproprietari il Bombrini ed altri esponenti della “cricca
cavourrista” allora al potere (vedi sopra).
L’ing. Grandis concludeva la sua relazione proponendo, per Pietrarsa,
la vendita a un industriale privato o, in alternativa, addirittura
la demolizione completa.
53. Il 10 gennaio 1863, presso il Ministero delle Finanze, fu
stipulata la convenzione che affittava lo stabilimento napoletano,
per 20 anni e per un canone di 46.000 lire annue, al sig. Jacopo
Bozza, subordinandola peraltro ad una successiva approvazione
parlamentare.
Jacopo Bozza: il capitalismo
“all’italiana”
54. Chi era codesto Jacopo Bozza? Notizie di lui, seppur non
completamente esaustive, abbiamo in: Angelo Nesti – “Jacopo Bozza:
imprenditore siderurgico nell’Italia post-unitaria”, Rivista
Quadrimestrale di Ricerche storiche, Università di Siena, N°3, anno
XL, settembre-dicembre 2010.
55. Nato a Milano il 22 aprile 1824, nel 1849 era ufficiale di
Marina (asburgica) di stanza a Venezia, laddove qualche anno dopo
aprì una fabbrica di fiammiferi, che dovette però fallire assai
presto, visto che nel 1856 lo troviamo già a Napoli impegnato nel
settore della “telegrafia elettrica”.
56. Nel Regno meridionale fece le sue fortune, ottenendo dal governo
borbonico l’appalto per la costruzione della rete telegrafica in
Calabria, in Sicilia, nel tratto Napoli-Ischia, etc. fino a
diventare addirittura “Ispettore generale del servizio e delle linee
telegrafiche delle due Sicilie”, con l’incarico di trattare con il
Governo Turco Ottomano il progetto di una linea telegrafica
sottomarina che doveva collegare la Turchia con la Sicilia.
Ben presto però sul suo conto si levarono dubbi e sospetti, sia di
scarsa competenza tecnica sia di lucrare più del dovuto sugli
appalti pubblici ricevuti.
57. Rimosso pertanto dal suo incarico, cominciò a manifestare, in
modo peraltro assai accorto, inusitati sentimenti di italico
patriottismo e, dopo il 1860, cercò subito di accreditarsi presso i
nuovi arrivati “fratelli d’Italia”, pubblicando anche una sua
auto-difesa apologetica, intitolata: “Cenni storici sulla telegrafia
elettrica nelle Due Sicilie dalla sua istituzione (1812) fino
a’ nostri giorni (1860)”, presso Giuseppe Dura, Strada
Toledo, Napoli, 1861.
Però, nonostante la sua esplicita richiesta, anche Garibaldi, nel
suo periodo di reggenza napoletana, lo escluse da qualsiasi incarico
o appalto nell’amministrazione telegrafica: vuoi che non si fidasse
di lui, vuoi che avesse altri esponenti del suo partito da
sistemare, vuoi l’una e l’altra cosa insieme.
58. Il nostro decise allora di cambiare nuovamente il suo campo di
attività: dopo i fiammiferi e dopo i telegrafi, di dedicò
all’industria pesante, presentandosi come imprenditore
metalmeccanico e siderurgico.
Di fatto, come abbiamo visto, riuscì ad ottenere dai governi della
Destra liberale la concessione di Pietrarsa; è però da notare che,
evidentemente, nemmeno la “consorteria cavourrista” si fidava
troppo di lui, perché la concessione venne data solo in forma di
affitto e comunque “subordinata ad una successiva approvazione
parlamentare”.
59. Invece, prima che questa definitiva approvazione giungesse,
accaddero i luttuosi eventi che guastarono la festa a questo
personaggio, giustamente dipinto nell’articolo come “di dubbia fama
… ex impiegato del Borbone, già proprietario e direttore del
giornale La Patria che … vendutosi anima e corpo all’attuale
governo”, ne aveva avuto “in compenso … la concessione di
Pietrarsa”.
60. A scanso di equivoci, per dirigere il personale era stato
chiamato un capitano piemontese di artiglieria, di nome
Ferrero (vedi quanto diceva il duca di Maddaloni).
E subito il Bozza, non contento di aver ricevuto la fabbrica quasi
in regalo … aveva attuato le misure tipiche del capitalismo
selvaggio (“lurido spirito di avarizia”): licenziamento di
operai (nonostante gli impegni in contrario, ne aveva licenziati
circa 250, oltre ad eliminare i circa 200 operai “straordinari”);
diminuzione del salario (da 32 a 30 grana al giorno) e
contemporaneamente aumento dell’orario di lavoro (erano 10
ore al giorno, le portò a 11).
61. Da notare qui, di passaggio, che anche per quanto riguarda
l’orario di lavoro nell’industria, il Regno borbonico meridionale
era evidentemente all’avanguardia: infatti, la giornata lavorativa
di 10 ore esisteva, a quel tempo, solo in Inghilterra dove era stata
introdotta per legge nel 1847.
Comunque, alle più che giustificate proteste degli operai, il Bozza
rispose … chiamando la forza pubblica ovvero l’esercito
d’occupazione piemontese che, “per ristabilire l’ordine in Pietrarsa”,
senza tanti complimenti sparò sugli operai inermi.
La “giustizia proletaria”
62. Qualcuno però decise, quella volta, di non attendere i risultati
della “Commissione parlamentare d’inchiesta” che, allora come oggi,
venne prontamente attivata e, allora come oggi, concluse i suoi
lavori dopo vari anni, senza individuare alcun colpevole per i morti
di Pietrarsa.
E così, solo qualche giorno dopo, i giornali riportavano la seguente
notizia: “Domenica 9 agosto 1863 … Il sig. Jacopo Bozza, transitando
in vettura nei pressi del Rione Mercato di Napoli, veniva da uno
sconosciuto colpito con una pistolettata ad un braccio”.
63. Non possiamo sapere chi siano stati gli attentatori né se
volessero veramente uccidere il nostro o solamente intimidirlo.
Sappiamo soltanto che egli, il 30 settembre 1863, indirizzò una
missiva a “Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze” nella quale fra
l’altro diceva:
“In seguito ai dispiacevoli avvenimenti di Pietrarsa ed al tentato
assassinio sulla mia persona, e considerando inoltre … che in
coscienza io non potrei aumentare il canone di affitto stabilito …
io rinunzio al mio contratto del 10 gennaio 1863”.
Jacopo Bozza dopo i fatti di
Pietrarsa
64. Sembra quindi che il Bozza, in seguito alla pistolettata
ricevuta, avesse capito che a Napoli non c’era più aria buona per
lui, e così decise di dare una nuova svolta alla sua avventurosa
esistenza, trasferendosi … a Piombino (Livorno).
Perché proprio a Piombino? In realtà, egli era uomo di molte
risorse, e il suo stoico “io rinunzio” non era proprio una rinuncia:
infatti, il 9 ottobre 1863, egli cedette (= a pagamento) il
suo contratto di affitto ad una nuova società, denominata Società
Nazionale d’Industrie Meccaniche, della quale inoltre lui rimaneva
comunque socio per una quota di 400 azioni.
Con tale provvista, dunque, oltre a quanto aveva guadagnato come
“capitalista telegrafico”, lasciò Napoli ed arrivò a Piombino che,
grazie alla sua vicinanza alle miniere di ferro dell’isola d’Elba,
era la “terra promessa” della siderurgia della nuova Italia.
65. Così, nel 1864, lo troviamo associato con l’inglese Joseph
Novello, con Alessandro Gigli ed Auguste Ponsard, nel richiedere al
Comune di Piombino un permesso per la costruzione di uno
stabilimento siderurgico.
“Sappiamo inoltre che nel settembre del 1864 partirono da Piombino
due bastimenti con destinazione Napoli allo scopo di imbarcare le
macchine necessarie agli impianti che si volevano inaugurare
nell’ottobre del 1864. Si trattava di una spedizione che avrebbe
oltrepassato il peso di 300 tonnellate, e non è difficile associare
questa operazione alle conoscenze che Bozza aveva maturato a Napoli,
quando era affittuario dello stabilimento di Pietrarsa, e ai
contatti che aveva mantenuto. È assai probabile che l’attrezzatura
necessaria per lo stabilimento di Piombino provenisse infatti dalla
Società Nazionale d’Industrie Meccaniche, di cui Bozza deteneva 400
azioni, anonima condotta da Gregorio Macry, della Macry & Henry, che
aveva rilevato proprio dal Bozza l’affitto di Pietrarsa. Di sicuro
provenivano da Pietrarsa le macchine soffianti
e due laminatoi acquistati usati”
.
66. Di lì a poco, però, i rapporti fra i soci si guastarono e
qualche mese più tardi si giunse alla creazione di due distinte
società: la Novello-Ponsard-Gigli, registrata formalmente il 27
maggio 1865, e la società individuale “La Perseveranza” di proprietà
del solo Bozza.
“La Perseveranza” fu, a quanto pare, l’ultima delle sue imprese: la
cedette però ad altri prima di morire. Il suo successore, Guido
Dainelli, fece apporre una lapide commemorativa, con la data 28
ottobre 1888, sulla casa “che gli fu per 10 anni dimora” a Piombino,
ma la casa venne demolita poco dopo la Seconda guerra mondiale e la
lapide scomparve con essa.
Considerazioni finali su Jacopo Bozza … ed altri
67. Jacopo Bozza sembra quindi essere il tipico capitalista “di
prima generazione della prima rivoluzione industriale”,
tutto intento alla “accumulazione primitiva” di capitale (vedi
sopra, nn°21-29-33).
Il suo stesso biografo, che pure tende ad essere piuttosto benevolo
nei suoi confronti, non può fare a meno di annotare: “aveva spiccata
sensibilità per gli affari … ma un suo modo specifico di cercare il
profitto industriale … conosceva la realtà italiana e il suo mercato
… aveva sempre avuto a che fare con la domanda statale, con le
commesse, e quindi conosceva assai bene le dinamiche e il sottobosco
della politica, come muoversi, su chi agire, quali leve innescare
per ottenere favori e lavori …”
68. Il semplice confronto tra la figura del borbonico Luigi Corsi
(vedi sopra, nn°49-50) e quella dell’italiano Jacopo Bozza mostra
chiaramente la differenza non solo fra due persone ma fra due
diverse “concezioni del mondo”: differenza culturale e morale, oggi
e sempre attuale.
69. Luigi Corsi era un solerte, onesto ed intelligente funzionario
pubblico, che lavorava al servizio del suo Paese e del suo Re,
contentandosi del suo stipendio e traendo la sua gloria dal fatto
che “sotto la sua direzione circa 800 lavoratori ebbero lavoro e
pane” e dai “lavori di maggior pregio compiuti nell’opificio” da lui
guidato.
70. Jacopo Bozza, invece, era ovviamente un capitalista privato che,
come tutti i capitalisti privati, usava la sua intelligenza per
ottenere per se stesso il massimo profitto individuale.
Inoltre, specificamente, il suo fine era solo quello di
accumulare quanto più denaro possibile, non importa facendo che cosa
e con quale utilità per gli altri, ed il mezzo per
raggiungere questo fine non era la britannica onesta competizione
fra talentuosi imprenditori in un libero mercato, ma l’abilità
nell’ottenere appalti pubblici (= i soldi di tutti i cittadini)
corrompendo politici e funzionari.
71. In definitiva, la logica è questa: “arricchire se stessi a spese
della comunità”, operando nel dispregio di qualunque senso di
responsabilità sociale.
Era solo la logica di Jacopo Bozza? Sembrerebbe di no. Certamente è
la logica che ha guidato le azioni di una parte significativa dei
capitalisti italiani sia nella prima sia nella seconda
rivoluzione industriale ed il risultato è stato l’italico
“capitalismo accattone”. Ma tuttavia non disperiamo: nuovi
“orizzonti di gloria”, e non solo in Italia, si aprono sul finire
del Novecento con l’avvento della terza rivoluzione
tecnologica ...
Il “brigantaggio” post-unitario
nell’Italia meridionale (1860-1870)
72. Abbiamo visto come i bersaglieri piemontesi-italiani furono
piuttosto sbrigativi nel “ristabilire l’ordine a Pietrarsa” (vedi
sopra, n°47 e n°61).
Del resto, nella contemporanea repressione del “brigantaggio”, i
soldati piemontesi si erano abituati a fare questo ed altro: “si
autorizza a decapitare i briganti, per comodità di trasporto”
(dall’Ufficio Storico dell’Archivio dello Stato Maggiore
dell’Esercito Italiano).
73. Nell’ex-Regno borbonico,
infatti, le misure impopolari prese dai nuovi governanti sommate
alla delusione delle speranze che aveva suscitato il Garibaldi (che
si era dimostrato solo un “utile idiota” nelle mani di Cavour e di
Vittorio Emanuele II), provocarono una eccezionale ripresa del
tradizionale “brigantaggio”, il quale venne configurandosi, nel
decennio 1860-1870, come un vasto fenomeno popolare di rivolta
sociale anti-borghese e di resistenza all’invasore sabaudo.
Ben sintetizzò la situazione,
all’epoca, “Civiltà cattolica”, la rivista dei Gesuiti, che nel suo
primo numero dell’anno
1861 (Anno XII, vol. IX, serie IV) scriveva: “Nelle
province, non che scemare, va crescendo il fuoco
dell’insurrezione contro i novelli padroni del Regno, nei quali
i popoli si sono ostinati di non voler riconoscere altri diritti che
quelli che rampollano da còmpera per tradimento e da
conquista per forza”.
Ma il popolo in disperata
rivolta, in quegli anni, non trovò come nel 1799 un Card. Fabrizio
Ruffo che sapesse unirlo ed organizzarlo né d’altronde riuscì (ma
avrebbe potuto?) ad esprimere dal suo stesso grembo dei veri e
propri “dirigenti organici” del suo movimento: persone, cioè, che
avessero una autonoma e cosciente visione politica e non fossero
semplici agenti infiltrati dai Borbone o dallo Stato pontificio.
74. D’altra parte, la risposta
del governo liberale piemontese alle esigenze e sofferenze delle
masse contadine fu solo una insipiente e brutale repressione armata.
Già durante la spedizione dei
Mille, Garibaldi aveva inviato il suo luogotenente Nino Bixio a
reprimere ferocemente, in alcuni paesi siciliani (Bronte, etc.), le
rivolte di contadini che avevano preso “troppo” sul serio le
promesse di Garibaldi medesimo ed avevano iniziato addirittura ad
occupare le terre dei latifondisti: vedi, a titolo illustrativo, la
novella intitolata “Libertà” di Giovanni Verga.
Dopo l’annessione, fu
l’esercito piemontese ad ereditare tale nobile missione, procedendo
a massacri indiscriminati della popolazione di interi paesi (noti i
casi di Pontelandolfo e di Casalduni, ma ve ne furono certamente
altri).
75. Secondo le stesse cifre
ufficiali, fornite in quegli anni dai capi militari “italiani”, solo
nel periodo 1861-65 furono uccisi dall’esercito piemontese (in
guerra o fucilati) più di 7.000 briganti ovvero, come osserva lo
storico inglese Denis Mack Smith, … più morti che in tutte le
“guerre di indipendenza” messe assieme. Inoltre, più di 5.000
persone vennero arrestate e condannate a lunghissima carcerazione.
76. Ma queste sono le cifre
“ufficiali” dei vincitori; quelle reali sono, con ovvia probabilità,
ben maggiori.
Lo storico borbonico casertano
Giacinto de’ Sivo (Maddaloni, 1814 – Roma, 1867), scrivendo mentre i
fatti erano ancora in corso, parla di 47.700 carcerati e 15.665
fucilati.
Lo storico leccese Roberto
Martucci, professore di Storia delle Istituzioni politiche e di
Storia costituzionale presso l’Università del Salento, scrivendo nel
1999, calcola: “Il fenomeno del brigantaggio investì circa 1.400
centri abitati; e vide più di 100.000 soldati, l’equivalente di 10
divisioni in campagna militare, contrapporsi ad almeno 40 bande a
cavallo (le bande in totale, secondo la documentazione ufficiale,
erano 388, composte da 10 fino ad alcune centinaia di persone: al
minimo, circa 50.000 uomini in armi).
I soldati avevano l’ordine di
sparare a vista e, come abbiamo già detto, quando si trattava di
fucilare contadini e di bruciare catapecchie non si tiravano
indietro.
Otteniamo una cifra minima di
20.075 ed una massima di 73.875 fucilati ed uccisi in vario modo …
mentre le carceri arrivarono a contenere dai 30 ai 40 mila detenuti
politici”
.
 |
Giacinto de Sivo (1814-1867) |
77. Ma quale che sia l’entità
esatta delle cifre, che è ovviamente difficile determinare con
precisione … rimane in ogni caso vero, come scrive Gramsci (vedi
sopra, n°17) che lo Stato “liberale” e “unitario” italiano “è stato
una dittatura feroce, che ha messo a ferro e fuoco l’Italia
meridionale e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i
contadini poveri, che scrittori salariati tentarono di infamare col
marchio di briganti”.
“Briganti noi,
combattenti in casa nostra, difendendo i tetti paterni; e
galantuomini voi, venuti qui a depredar l’altrui? Il padrone di
casa è brigante, e non voi piuttosto, venuti a saccheggiare la
casa?” (Giacinto de’ Sivo).
Carlo Antonio Gastaldi: un operaio di
Biella fra i briganti del Sud
78. In questi avvenimenti, vi furono molti ex garibaldini ed anche
regolari piemontesi che disertarono e si unirono ai briganti.
Tra i disertori, è da ricordare come esempio quello dell’operaio
biellese Carlo Antonio Gastaldi, decorato con medaglia d’argento al
valor militare nella battaglia di Palestro del 1859.
Inviato nelle Puglie a combattere i briganti, divenne
addirittura luogotenente del Sergente Romano ovvero Pasquale
Domenico Romano (1833-1863) di Gioia del Colle (Bari), un ex
sergente dell’esercito borbonico che era a capo di una banda di
oltre 200 uomini in quella regione.
79. Gustavo Buratti, grande studioso delle minoranze linguistiche
esistenti in Italia, ha scritto la storia del Gastaldi in dialetto
piemontese con traduzione italiana a fronte.
In appendice al libro, sono anche elencati, con brevi cenni
biografici, 169 uomini della banda del Sergente Romano, quasi tutti
morti in battaglia: sono più dei famosi 120 “martiri” della
Repubblica napoletana elencati da Vincenzo Cuoco ma i loro nomi non
sono stati inscritti su alcuna lapide.
Fra di loro, anche un altro piemontese, Antonio Pascone, ed ex
garibaldini come Cosimo d’Oria di Alberobello e Giuseppe Valente
(detto “Nenna-nenna”) che prima di essere capitano nella banda
Romano era stato sottufficiale con Garibaldi.
“Il Piemonte non sono solo i Savoia, sono anche e soprattutto i
Gastaldi, i contadini delle Langhe, del Cuneense, delle sue
campagne. Sono i Nuto Revelli, i Gustavo Buratti. E’ con loro, e
tramite loro, che è possibile un incontro fra Nord e Sud”
.
La guerra delle fotografie
80. Questa vera e propria “guerra civile” fu combattuta, per la
prima volta, anche con la neo-nata fotografia.
E’ noto che il governo sabàudo commissionò e fece divulgare il
foto-montaggio di una prostituta ignuda con il volto della moglie di
Francesco II, per screditare la figura della “eroina di Gaeta”, la
regina Maria Sofia. E di simili foto-montaggi propagandistici se ne
fecero parecchi e di vario tipo.
81. L’esercito sabàudo viaggiava con fotografi e giornalisti al
seguito, incaricati di “raccontare” i fatti secondo la versione
ufficiale dei comandi militari; e i soldati, dopo un’azione militare
ben riuscita, esibivano in foto i corpi degli uccisi, spesso
facendosi fotografare accanto alle loro vittime, come si faceva per
i “trofei di caccia”.
In tal modo, i “briganti” erano letteralmente “visti” e
“raccontati”, sui giornali che si leggevano nei salotti borghesi
“italiani”, come crudeli e selvaggi assassini, ladri e stupratori
senza possibilità di redenzione, e di loro non si poteva avere
alcuna pietà, andavano (“purtroppo”?) abbattuti come cani rabbiosi.
Così, a titolo di esempio, per il signor avvocato e professore
Antonio Vismara da Vergiate (Varese), disceso nel napoletano con gli
invasori,
i briganti sono “un’onda di melma composta di tutte le sozzure
mondane … che rubano, che assassinano, che seviziano, che stuprano,
che insultano all’umanità, alla morale, alla religione, alla
civiltà, alla patria … si ritengono per difensori dell’altare e del
trono e non sono altro che i giannizzeri del delitto più abbietto …
gente che si dissetava col sangue umano, si cibava di carne umana,
gente peggiore della tigre che non divora la sua specie! Gente più
schifosa dello scarafaggio, orrida più del rusco, più vile dell’alga
abbietta …”
 |
Un bersagliere sabaudo esibisce il cadavere del
brigante Nicola Napolitano |
82. La corte borbonica in esilio a Roma, con mezzi economici molto
inferiori, riusciva talvolta a produrre foto che cercavano di
restituire ai “briganti” non solo la loro dignità semplicemente
umana ma anche quella di un popolo che combatte fieramente in nome
della sua identità storico-culturale, del suo Re, della sua Patria,
della sua Fede.
 |
Michelina Di Cesare (1841-1868) |
Restituire la verità
83. Personaggi come il pugliese
Pasquale Domenico Romano (1833-1863) detto “il sergente Romano”, la
brigantessa di Montelungo Michelina
Di Cesare (1841-1868) moglie di Francesco Guerra, il vesuviano
Antonio Cozzolino (1824-1870) detto “Pilone”, e tanti altri … erano
già allora leggendari presso il popolo meridionale.
La propaganda sabàuda dell’epoca e la trasmissione ideologica
fàttane dagli storici liberali hanno infangato queste figure,
presentandole come volgari banditi, ladri e assassini sanguinari e
crudeli.
Già da un po’ di tempo, però, la attenta e documentata ricostruzione
storica delle loro biografie sta restituendo la verità: non erano
comuni delinquenti, erano patrioti combattenti, spesso ex
soldati dell’esercito regolare borbonico che continuavano la lotta,
in collegamento politico con i comitati borbonici clandestini, per
restituire l’indipendenza al loro Paese occupato; ed erano
l’avanguardia armata del popolo contadino che si ribellava
all’imposizione, da parte della borghesia, dei nuovi rapporti di
proprietà nelle campagne
.
 |
Michelina Di Cesare |
84. Certamente, come sempre capita in questi casi, furono commesse
violenze e crudeltà, furti e saccheggi, e vi furono delinquenti
comuni, approfittatori, opportunisti e traditori: ma da ambedue
le parti, non da una parte sola.
Se, in sede
storica, si vuole considerare Antonio Cozzolino, Michelina Di Cesare
o il sergente Romano come comuni assassini, allora almeno a
pari titolo si dovrà considerare i pluri-decorati generali
“italiani” Enrico Cialdini (1811-1892) o Giuseppe Govone (1825-1872)
come criminali di guerra.
Come scrisse il
Duca di Maddaloni nella sua “Mozione di inchiesta” (vedi sopra,
n°8):
“Gli uomini di Stato del
Piemonte, e i partigiani loro, hanno corrotto nel Regno di Napoli
quanto vi rimaneva di morale. Hanno spoglio il popolo delle sue
leggi, del suo pane, del suo onore ... e lasciato cadere in
discredito la giustizia ...
Hanno dato l'unità al paese, è
vero, ma lo hanno reso servo, misero, cortigiano, vile. Contro
questo stato di cose il paese ha reagito.
Ma terribile ed inumana è stata
la reazione di chi voleva far credere di avervi portato la libertà
... Pensavano di poter vincere con il terrorismo l'insurrezione, ma
con il terrorismo si crebbe l'insurrezione, e la guerra civile
spinge ad incrudelire e ad abbandonarsi a saccheggi e ad opere di
vendetta.
Si promise il perdono ai
ribelli, agli sbandati, ai renitenti. Chi si presentò fu fucilato
senza processo. I più feroci briganti non furono certo da meno di
Pinelli e di Cialdini”.
Lasciamo al
volenteroso lettore di approfondire lo studio delle gesta dei
generali sabaudi durante la “repressione del brigantaggio”. Ci
limitiamo qui a citare solo due casi esemplari.
 |
Enrico Cialdini (1811-1892) |
Alcuni numeri esemplari del criminale Cialdini
85. Ecco il già pluri-decorato, e poi Senatore del Regno, generale
Enrico Cialdini, il macellaio di Gaeta, il massacratore di Casalduni
e Pontelandolfo … Dal 1861 plenipotenziario a Napoli del re Vittorio
Emanuele II di Savoia, in un rapporto al suo governo, riferiva lui
stesso queste cifre sulla sua opera, solo per i primi mesi e
solo nel Napoletano: 8.968 fucilati, tra i quali 64 preti e
22 frati; 10.604 feriti; 7.112 prigionieri; 918 case bruciate; 6
paesi interamente arsi; 2.905 famiglie perquisite; 12 chiese
saccheggiate; 13.629 deportati; 1.428 comuni posti in stato
d'assedio … ed era solo l’inizio!
 |
Giuseppe Govone (1825-1872) |
Alcuni numeri esemplari del criminale Govone
86. Ed ecco l’altrettanto glorioso generale Giuseppe Govone, che
morì suicida nel 1872 forse per il rimorso delle nefandezze compiute
… Anche lui dal 1862 plenipotenziario del re Vittorio Emanuele II di
Savoia, ma per la Sicilia.
Dopo un lunghissimo periodo di occultamento, dagli Archivi Storici
dell’Esercito emergono a suo carico (ed a carico del gen. Pietro
Quintino, ex garibaldino poi decorato, esecutore materiale) fatti
come questo:
Castellammare del Golfo (Trapani), 3 gennaio 1862.
Fucilati dopo sommario interrogatorio, per presunta complicità coi
briganti:
Mariana Crociata,
cieca, analfabeta, 30 anni, figlia di Antonino e di Antonia Messina,
sposata con Giuseppe Provenzano;
Marco Randisi,
bracciante agricolo, storpio, analfabeta, 45 anni, figlio di
Francesco e di Vincenza Messina, sposato con Antonia Lombardo;
Benedetto Palermo, sacerdote, 46
anni, figlio di Leonardo e di Maria Pilara … rimase agonizzante per
più di un’ora, fino a quando un bersagliere, forse mosso a pietà,
non lo infilzò alla gola con la sua baionetta;
Angela Catalano, contadina, zoppa,
analfabeta, 50 anni, vedova di Giuseppe Di Bona;
Angela Calamia, disabile,
analfabeta, 70 anni, figlia di Pietro e di Margherita Gallo, sposata
con Pietro Colomba;
Antonino Corona, disabile, 70 anni,
fu Bartolomeo, sposato con Paola Coci
.
Ed infine:
Romano
Angela, filia Petri et Joanna Pollina consortis, etatis suae anno 9
circa, hodie hora 15 circa in Castriadmare, animam Deo reddidit
absque sacramentis in villa sic dicta della Falconera, quia
interfecta fuit a militibus Regis Italiae. Ejus corpus sepultum est
in Campo Sancto novo.
Romano Angela, figlia di Pietro e della consorte Giovanna Pollina,
all’età sua di anni 9 circa, alle ore 15 circa di oggi in
Castellammare, rese l’anima a Dio senza i sacramenti, nella villa
cosiddetta della Falconera, poiché fu uccisa dai soldati del Re
d’Italia. Il suo corpo è sepolto nel Campo Santo nuovo
(dal Liber defunctorum del giorno 3 gennaio 1862, Chiesa
Madre di Castellammare del Golfo).
87. Questo
fecero i milites regis Italiae contro il popolo del Regno
delle due Sicilie!
 |
Michelina Di Cesare fotografata dopo la sua uccisione |
I prigionieri di guerra meridionali
88. L’ Esercito Nazionale delle Due Sicilie, all’inizio del 1860,
contava circa 95.000 uomini.
“Tra tanti scandali di generali che tradivano, le defezioni delle
soldatesche furono tanto rare che potrebbero dirsi nulle … Tra i
quattro e cinquecento, che costituivano l’armamento di ciascuna di
varie navi da guerra rubate al Re (Francesco II di Borbone),
non uno solo si trovò che consentisse a rimanersi coi predatori …
Tra le parecchie migliaia di prigionieri, tramutati
nell'Italia superiore, benché tentati colla fame, col freddo in
clima per essi rigidissimo, e con ogni genere di privazioni, appena
i tre o quattro sopra cento si piegarono ad arrolarsi nelle
milizie di un altro Re, e quasi tutti, all'invito, non fecero altra
risposta che questa molto laconica: - Il nostro Re sta a Gaeta”
.
“Se i 40 o 50 mila soldati napoletani ricusano l’alto onore
della coccarda tricolore, come si farà a mettercela per forza? … Per
vincere la resistenza dei prigionieri di guerra, già trasportati in
Piemonte e in Lombardia, si ebbe ricorso ad uno spediente crudele e
disumano, che fa fremere. Quei meschinelli, appena coperti da cenci
di tela, e rifiniti di fame perché tenuti a mezza razione con
cattivo pane e acqua e una sozza broda, furono fatti scortare nelle
gelide casematte di Fenestrelle e d’altri luoghi posti nei
più aspri luoghi delle Alpi. Uomini nati e cresciuti in clima sì
caldo e dolce, come quello delle Due Sicilie, èccoli gittati, peggio
che non si fa coi negri schiavi, a spasimar di fame e di stento fra
le ghiacciaie! E ciò, perché fedeli al loro giuramento militare ed
al legittimo Re! Simili infamie gridano vendetta da Dio, e tosto o
tardi l’otterranno”
.
“Le vittime dovettero essere migliaia, anche se non vennero
registrate da nessuna parte. Morti senza onore, senza tombe, senza
lapidi e ricordo. Morti di nessuno. Terroni”
.
89. “In Italia esiste proprio la tratta dei Napoletani. Si arrestano
da parte di Cialdini soldati napoletani in gran quantità, si stipano
ne’ bastimenti peggio che non si farebbe degli animali, e poi si
mandano in Genova.
Trovandomi testé in quella città ho dovuto assistere ad uno di que’
spettacoli che lacerano l'anima. Ho visto giungere bastimenti
carichi di quegli infelici, laceri, affamati, piangenti; e sbarcati
furono distesi sulla pubblica strada come cosa da mercato.
Spettacolo doloroso che si rinnova ogni giorno in via
Assarotti dove è un deposito di questi sventurati.
90. Alcune centinaia ne furono mandati e chiusi nelle carceri di
Fenestrelle, qui cospirarono e se non si riusciva in tempo a
sventare la congiura, essi ímpadronivansi del forte di
Fenestrelle, e poi unendosi con altri napoletani incorporati
nell'esercito, piombavano su Torino.
Un 8.000 di questi antichi soldati Napoletani furono
concentrati nel campo di San Maurizio, ma il governo li
considera come nemici, e dice l’Opinione che a tutela della
sicurezza pubblica sia dei dintorni, sia del campo, furono inviati a
S. Maurizio due battaglioni di fanteria.
Ma si sa che, inoltre, vi stanno a Guardia qualche batteria di
cannoni, alcuni squadroni di cavalleria, e più battaglioni di
bersaglieri, tanto ne hanno paura! E costoro, così guardati e
malmenati, pensate con che valore vorranno poi combattere pel
Piemonte! Eccovi in che modo si fa l’Italia!”
La prima guerra del nuovo Stato
91. La prima guerra combattuta
dal nuovo Stato italiano fu, dunque, quella contro i contadini
del Sud; si confermava così, in modo aperto e violento, la
natura spiccatamente classista (borghese) di quel nuovo Stato.
Per i contadini, invece, si
trattò solamente di un’altra tappa della loro millenaria epopea di
sconfitte.
92. Vicino alla verità, anche
se non del tutto, è andato forse lo scrittore torinese, di
origini ebraiche, Carlo Levi (1902-1975). Con intuito artistico
unito alla acutezza di analisi, egli definisce il “grande
brigantaggio” del 1860-70 come “la quarta guerra nazionale” dei
contadini meridionali.
I contadini del Sud, scrive
Levi (nel 1945!), costituiscono da secoli una nazione a sé, erede
della civiltà degli antichissimi “itàlici”; questa nazione è stata
sempre sottomessa, dai vari dominatori venuti dall’esterno, ma mai
completamente assimilata né distrutta; come la terra con i suoi
ritmi immutabili, così i contadini sono rimasti sempre eguali a se
stessi.
“Il loro cuore è mite e l’animo
paziente. Secoli di rassegnazione pesano sulle loro schiene, e il
senso della vanità delle cose, e della potenza del destino. Ma
quando, dopo infinite sopportazioni, si tocca il fondo del loro
essere e si muove un senso elementare di giustizia e di difesa,
allora la loro rivolta è senza limiti e non può conoscere
misura. E’ una rivolta disumana, che parte dalla morte e non
conosce che la morte, dove la ferocia nasce dalla disperazione”
.
Le quattro “guerre nazionali” dei
contadini del Sud
93. Solo queste rivolte
sono le loro vere “guerre nazionali”.
La prima
fu quella contro Enea, ovvero contro la teocrazia militare di stampo
greco ed asiatico che questi rappresenta, e l’Eneide di
Virgilio ne è il poema mitologico.
La seconda
fu quella contro i Romani, quando il grande impero cominciava a
formarsi attraverso la sottomissione delle antiche genti italiche.
La terza
fu quella a fianco degli Svevi contro la conquista Angioina:
Federico II, per quanto anche lui straniero, fu il sovrano più amato
dai contadini, perché vìndice dei soprusi della aristocrazia feudale
e del potere mondano della Chiesa, ed essi parlano del giovane
Corradino di Svevia “come di un loro eroe nazionale e ne piangono la
morte” Carlo Levi - “Cristo si è fermato a Eboli” - Ed. Einaudi,
1945..
94. Infine, “quarta
guerra nazionale” dei contadini fu il brigantaggio post-unitario.
“Ma che cosa poteva fare una
povera Madonna dal viso nero contro lo Stato Etico
degli hegeliani di Napoli? Il brigantaggio non è che un ascesso di
eroica follia e di feròcia disperata, un desiderio di morte e di
distruzione senza speranza di vittoria ...
I briganti tagliavano le
orecchie, il naso e la lingua dei signori, per farsi pagare i
riscatti; i soldati tagliavano la testa dei briganti che riuscivano
ad acciuffare e le attaccavano su dei pali, nei paesi, perché
servissero di esempio”
.
E quando le bande furono
disperse ed i briganti uccisi o imprigionati, alle masse contadine
non rimase che partire in silenzio sulle vie dell’emigrazione.
Antonio
Cozzolino, detto “Pilòne”, il brigante della zona vesuviana
95. Il più significativo
esponente del brigantaggio nella provincia di Napoli operò
prevalentemente proprio nella nostra zona, nelle campagne ad oriente
della città ed intorno al Vesuvio
.
Si chiamava Antonio Cozzolino,
era nato nell’ospedale civile di Torre Annunziata il 21 gennaio
1824, da Vincenzo e da Carolina Liguori, cresciuto a Boscotrecase
nei vicoli di Contrada Casa Vitelli, e soprannominato “Pilòne”
[29] perché quando nacque aveva il volto ricoperto da una
fitta lanugine che lo accompagnò poi per tutta la vita.
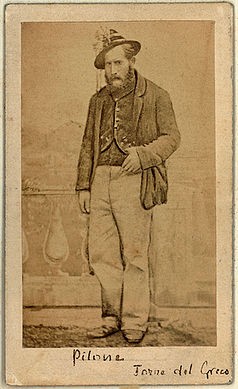 |
Antonio Cozzolino (1824-1870) |
Valoroso soldato dell’esercito borbonico
96. Di mestiere “scalpellino” come il padre, nel 1844 divenne
soldato dell’esercito borbonico, e nel
1860 combatté contro i garibaldini a Calatafimi, dove strappò la
bandiera dei Mille dalle mani dell’alfiere Menotti (la bandiera
venne poi esposta, come trofeo di guerra, nella Reggia di Portici).
Continuò a combattere contro gli invasori prima in Sicilia, dove fu
promosso secondo sergente dei Cacciatori borbonici, poi a Caiazzo
dove si guadagnò i gradi di sergente maggiore, ed infine nella
battaglia del Volturno al termine della quale venne fatto
prigioniero dall’esercito piemontese.
97. Scarcerato poco dopo, ritornò da sua moglie Luigia Falanga a
Boscotrecase ed al mestiere di scalpellino.
Ma già nella primavera del 1861, preso contatto con il Comitato
Borbonico clandestino di Napoli in una riunione che si tenne a
Portici il 29 marzo di quell’anno, si unì alle bande che sul Monte
Somma continuavano a combattere sotto la bandiera del Regno delle
Due Sicilie.
Guerrigliero sul Vesuvio
98. In breve, divenne il
“comandante delle truppe in guerra nella provincia di Napoli” e fece
dei boschi del Vesuvio il suo quartier generale, a partire dal quale
effettuava i suoi colpi di mano con la tecnica della guerriglia:
assaliva le caserme ed i convogli dell’esercito piemontese, liberava
i prigionieri borbonici detenuti nelle carceri, attaccava i presìdi
della Guardia Nazionale, e si finanziava e manteneva i suoi uomini
sottraendo viveri e soldi ai nuovi proprietari borghesi nelle loro
masserie e ai notabili professionisti nei loro “Casini” per
gentiluomini.
Il rapimento del marchese Avitabile
99. La mattina del 30 gennaio 1863, in territorio di Torre del
Greco, sequestrò il marchese Michele Avitabile, direttore del Banco
di Napoli, chiedendo un riscatto di 20.000 ducati.
100. “Pilone, per via, intavolò con l’Avitabile una conversazione
che si aggirò intorno a mille argomenti e fu durante questo
colloquio che il marchese, come disse più tardi, si convinse che il
Pilone non era tanto una belva come la fama lo dipingeva.
Pilone gli disse, fra l’altro:- Poiché voi ed i vostri parenti di
Calabria avete dato 60.000 ducati a Garibaldi, potreste darne
altrettanti a me; ma io ne ho tolto il valore dei danni che avete
sofferto per il bruciamento del bosco in provincia di Salerno.
I
briganti dal canto loro dicevano al marchese che se, pel suo
riscatto, soffriva il dispiacere di sborsare una forte somma, questa
gli sarebbe stata compensata dalla protezione di Pilone, che avrebbe
per lui implorata la grazia al prossimo ritorno di Francesco II,
cosa che sarebbe successa nella prossima primavera …
101. A condurre il riscatto furono il signor Francesco Pastore,
congiunto della moglie dell’Avitabile … insieme ad alcuni coloni ...
portando con loro due sacchi di monete d’oro.
Pilone ordinò al suo segretario di enumerare quel denaro e questi,
posto a terra un cappotto di incerata, si accinse a contarlo al
chiarore della luna.
Il signor Francesco Pastore, che per via aveva sottratta buona parte
della somma, perché credeva che Pilone non l’avrebbe fatta numerare,
disse:- Questo è il solo denaro che abbiamo potuto raccogliere.
Pilone allora si avvicinò al marchese e, in tono da incutere
terrore, gli disse:- Aggiustate la somma in 20.000 ducati. Se no,
guai a voi!
L’Avitabile, che ignorava la gherminella del Pastore, a tale
minaccia venne assalito da crisi convulse, che lo portarono fuori
dai sensi.
102. A questa straziante scena, Pilone non seppe più resistere,
s’intenerì fino ad inumidire il ciglio e, dopo aver richiamato ai
sensi l’Avitabile con del rhum, lo congedò augurandogli
felice il ritorno in famiglia.
Nello stringergli la mano … gli restituì il suo fucile da caccia,
dicendo che glielo ridava perché non dicesse che erano dei comuni
ladri.
E 4 briganti ebbero l’ordine di far scorta d’onore all’Avitabile
fino alla linea ferroviaria.
Michele Avitabile poté riabbracciare i suoi … già alle 4 del mattino
del 31 gennaio 1863. La somma ottenuta dal Pilone … sui 20.000
richiesti … non superò i 9.000 ducati”
.
La beffa ad Umberto I di Savoia
103. Successivamente, sulla strada che porta al Vesuvio dal versante
di Boscotrecase, si trovò a transitare, in carrozza e corteo,
l'allora principe ereditario Umberto I, figlio di Vittorio Emanuele
II di Savoia: Pilone e la sua banda assalirono il corteo e,
neutralizzati i soldati che l’affiancavano, spogliarono principe e
compagnia di tutto quello che avevano, lasciandoli poi liberi.
L’arresto e la fuga dal carcere
104. Nel gennaio del 1864,
insieme ad altri, cercò rifugio nello Stato pontificio. L’intento
era quello di entrare in Roma e mettersi sotto la protezione di
Francesco II di Borbone. “Ma non ci riuscirono perché, prima che
essi fossero entrati in città, furono arrestati dai soldati francesi
e poscia rinchiusi nelle Terme …”
105. Il governo sabaudo chiese
la loro estradizione, la quale però non fu concessa dal governo
pontificio, con la esplicita motivazione che si trattava di
delinquenti politici e non di comuni malfattori; e che, del
resto, trovandosi in carcere non potevano apportare nessun
nocumento.
106. Il giorno 6 marzo 1869,
Pilone fu fatto evadere dal carcere, come risulta da un rapporto del
Ministero dell’Interno sabaudo del 12 aprile 1869 “circa la fuga da
quelle carceri dei capi-briganti Pilone e Viola …
L’evasione di Pilone e di Viola
non sarebbe stata che una facilitazione, da oltre un anno decisa; e
la loro fuga dovevasi operare a mezzo di un bastimento per
trasportarli all’estero. Però, il bastimento che li trasportava,
trovandosi di fronte ad una crociera italiana, retrocedette e sbarcò
i tre malfattori Pilone, Viola e Crocco, i quali si allontanarono
per le campagne.
Viola è stato di nuovo
arrestato e rinchiuso alle Terme; del Crocco non si avrebbe più
notizia; e Pilone, a quel che si assicura, trovasi nel Palazzo
Farnese sotto la protezione dei Borbone”
.
107. Il 20 aprile 1869, lo
stesso Ministero ebbe conferma che “Antonio Cozzolino, nella sua
fuga dalle carceri, si era fratturato una gamba” e che “trovavasi
tuttavia nascosto nel Palazzo Farnese” e si aggiungeva che “si
riteneva difficile la guarigione di lui”.
In effetti, in seguito alla
frattura, Pilone rimase leggermente zoppo ma, non appena fu
assicurato dal medico curante che poteva liberamente camminare, ebbe
da Re Francesco e dalla Regina Maria Sofia una discreta somma e
lasciò Roma nel febbraio del 1870, per rientrare clandestinamente in
Napoli e continuare la lotta.
La morte
108. La sua sorte fu segnata
quando anche Roma, il 20 settembre 1870, con la famosa “breccia di
Porta Pia”, venne conquistata dalla monarchia sabauda e venne quindi
meno il governo borbonico in esilio.
In seguito ad un accordo fra la
Polizia “italiana” ed i camorristi della “Bella Società”
[33], Antonio Cozzolino venne tradito ed attirato
in una trappola da un suo vecchio compagno, Salvatore Giordano; e
così la mattina di venerdì 14 ottobre 1870, in Via Foria, era atteso
da una squadra di poliziotti in borghese, composta da 10 guardie più
il Brigadiere e il Delegato, che lo assalirono e lo uccisero a colpi
di stocco
[34].
Quasi (?!) dignitoso …
109. Addosso, oltre a pochi
soldi, gli fu trovato: “l’abitìno” di S. Ciro (patrono di Portici);
alcune reliquie di Santi (ve ne erano molte in circolazione, ancora
a quel tempo: tutte molto venerate anche se, la maggior parte,
false); un foglietto con una meditazione della Passione di Gesù; un
abbecedario seguito da una dottrina cristiana; e una immaginetta di
S. Maria delle Grazie alle Paludi
.
“Le adiacenze della Questura,
per due giorni, si videro affollate di gente per vedere il
famigerato brigante. Era il corpo di una bianchezza estrema, senza
adipe, di una fisionomia calma e quasi (!) dignitosa, con
piedi e mani quasi signorili. In tutto un certo che di placido ed
attraente. Ecco il cadavere di Pilone”
.
continua