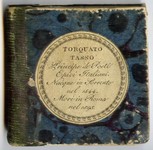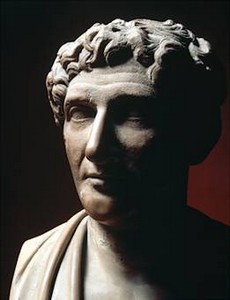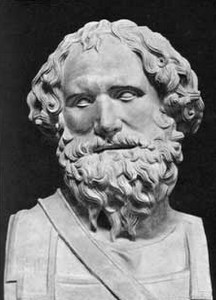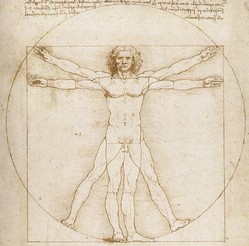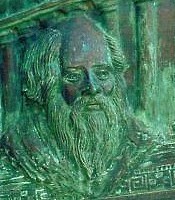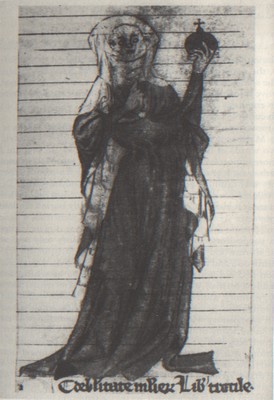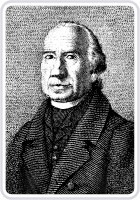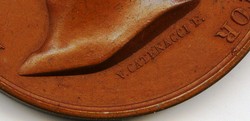|

|
|
|
La serie di medaglie borboniche
degli uomini illustri delle Due
Sicilie
a cura di
Francesco di Rauso
|
|
|
|
Si ringrazia il sig. Francesco di Rauso per aver
messo a disposizione del Portale le immagini della sua preziosa
collezione |
|
La bellissima serie di 17 medaglie del
diametro di 40 millimetri coniata a Napoli e dedicata agli nomini illustri
delle Due Sicilie, è stata a lungo considerata di committenza privata e
quindi non facente parte della medaglistica borbonica. Tuttavia nel 2006 è
stata meritevolmente inserita da Salvatore D'Auria nella sua opera
Il medagliere.
Queste medaglie sono borboniche a
tutti gli effetti in quanto regolarmente approvate dal Re con documenti
ufficiali che ne autorizzano l'incisione e coniazione servendosi degli
artisti della zecca di Napoli che in quel momento già lavoravano per la
creazione di altre medaglie. La coniazione fu approvata dal Re in diversi
periodi a cavallo tra il 1830 ed il 1834. Ecco i personaggi illustrati nella
serie. |
Torquato Tasso
|
 |
|
Torquato Tasso in un'incisione del 1780, Caserta,
collezione privata |
|
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a Torquato Tasso - 20
gennaio 1830
(collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
Astuccio originale, clicca sull'immagine per
ingrandire
|
|
Torquato Tasso (Sorrento 1544-Roma 1595) è
stato un famoso scrittore e poeta. Figlio del poeta
Bernardo Tasso, a diciotto anni esordì con il poema
Rinaldo, dedicato al cardinale Luigi D'Este. Si trasferì
alla corte di Ferrara dove condusse una vita intensa e di
grande attività artistica. È in questo periodo che, tra
l'altro, terminò il suo capolavoro, Gerusalemme Liberata.
A causa del suo particolare carattere, pieno di insicurezze
e contraddizioni, fu colto da uno squilibrio mentale, che lo
portò ad una vita solitaria, viaggiando attraverso l’Italia,
fino a che, tornato a Ferrara, il duca Alfonso lo fece
rinchiudere nell'ospedale di Sant’Anna, dove rimase per
sette anni. Liberato per intervento della duca di Mantova,
riprese i suoi viaggi in Italia, finché morì a Roma nel
monastero di Sant'Onofrio. La sua sensibilità così spiccata
e talvolta addirittura malata, si riflette nelle sue opere,
liriche e appassionate, anche nella tragedia e nell'epos. |
|
Pietro Novelli
|
 |
|
Pietro Novelli, monumento in marmo |
|
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a Pietro Novelli - 20
gennaio 1830 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Pietro Novelli detto il Monrealese
(Monreale 1603 - Palermo 1647) è stato un famoso pittore. Si
formò presso la bottega del padre pittore a Monreale. In
seguito, a Palermo, subì l'influenza dei dipinti di scuola
genovese presenti nell'Oratorio di Santo Stefano Protomartire al
Monte di Pietà e dell’Adorazione dei Pastori di Caravaggio
dell'Oratorio dì San Lorenzo. Furono anche forti le influenze
dei pittori fiamminghi presenti all'epoca a Palermo, come per
esempio Antoon van Dyck che soggiornò nella capitale siciliana
nel 1624. I viaggi di Novelli ebbero una grande importanza
nell’evoluzione della sua pittura. Visitò Roma tra il 1622 e il
1625, dove ebbe modo di studiare i maggiori pittori del
Rinascimento. Nel corso di un viaggio a Napoli nel 1630 vide i
lavori di Jusepe de Ribera e di alcuni pittori naturalisti
napoletani che lo incoraggiarono a sviluppare una pittura più
realistica. Fu uno dei maggiori pittori del suo tempo e fu
nominato "pittore reale". Inoltre gli furono commissionati
quadri religiosi per numerose chiese ed affreschi che adornarono
le ville della nobiltà siciliana. Numerose sue opere sono
esposte presso la Galleria Regionale di Sicilia di Palazzo
Abatellis a Palermo. |
|
|
|
Marco Tullio Cicerone
|
 |
|
Marco Tullio Cicerone, busto in marmo, Roma,
Musei Capitolini |
|
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a Marco Tullio
Cicerone - 20 gennaio 1830 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Marco Tullio Cicerone (Arpino 106 a.C. -
Formia 43 a.C.). Oratore, uomo politico e scrittore latino.
Nacque in una famiglia ricca e influente dell'ordine
equestre e fu avviato agli studi di retorica, diritto e
filosofia, prima a Roma e in seguito ad Atene, a Rodi e a
Smirne. Ritornato in patria nel 77 a.C., intraprese la
carriera politica: divenne questore nel 75 a.C., senatore
nel 74, edile curule nel 69, pretore nel 66 e console
nel 63. Fu l'esilio in Macedonia (58 a.C.); un anno dopo
riuscì a tornare a Roma grazie all'aiuto di Pompeo.
Costretto a restare lontano dalla vita politica dal
triumvirato di Pompeo, Cesare e Crasso, Cicerone si dedicò
alla letteratura fino al 51 a.C., quando accettò la carica
di proconsole in Cilicia (Asia Minore). Di nuovo a Roma nel
50, affiancò Pompeo, diventato nel frattempo nemico di
Cesare. La sconfitta dei sostenitori di Pompeo a Farsalo (48
a.C.) lo convinse a venire a patti con Cesare, che gli
perdonò la passata ostilità. Per qualche anno, fino
all'uccisione di Cesare (44 a.C.), Cicerone rimase assente
dalla scena politica, dedicandosi agli studi filosofici e
alla letteratura. Nel conflitto che si accese tra il figlio
adottivo di Cesare, Caio Ottaviano (che sarebbe stato
insignito del titolo di Augusto) e Marco Antonio, Cicerone
si schierò dalla parte del primo, ma la temporanea
riconciliazione dei due nemici segnò la sua fine. Ottaviano
non si oppose alla decisione di Antonio di inserirlo nelle
liste di proscrizione. Catturato presso Formia, Cicerone
venne giustiziato come nemico dello stato (43 a.C.). |
|
|
|
Publio Ovidio Nasone
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a Publio Ovidio
Nasone - 20 gennaio 1830 (collezione Francesco di Rauso,
Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire. |
|
Publio Ovidio Nasone (Sulmona 43 a.C. - Tomi sul
Mar Nero 17 d.C). Fu un celebre poeta. Ancora molto giovane
arrivò a Roma, dove studiò. Presto entrò in contatto con i
maggiori poeti e filosofi del tempo. Frequentò la corte di
Augusto, e condusse una vita agiata. La tragedia, Medea, da lui
composta, ottenne molti riconoscimenti, e intorno al 14 a. C.,
compose un canzoniere in distici-elegiaci, gli Amores. A
queste poesie leggere seguirono le Heroides e l'Ars
amatoria. Quest'ultima opera contribuì notevolmente a
estendere la sua fama. Compose le Metamorfosi ed i
Fasti. I Fasti dovevano essere composti da dodici
libri, uno per ogni mese dell'anno, ma Ovidio lo lasciò dopo la
composizione del sesto. Nell'8 d. C. il poeta venne in disgrazia
presso l'imperatore Augusto (per cause che non sono del tutto
chiare) e fu colpito da un decreto che lo costringeva all'esilio
a Tominella Scizia, dove rimase sino alla morte. In viaggio
verso l'esilio compose il poemetto Ibis e i primi due
libri dei Tristia (elegie). Nel luogo del suo esilio sul
Mar Nero, compose le Epistulae ex Ponto, elegie in forma
epistolare, ed un poemetto sulla pesca. Muore a Tomi, sul Mar
Nero, nel 17 d. C. |
|
|
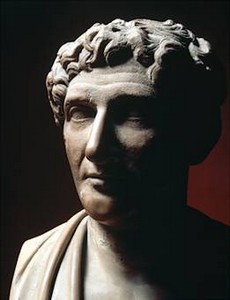 |
|
Publio Ovidio Nasone, busto in marmo, Firenze,
Galleria degli Uffizi |
|
|
|
Archimede
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata ad Archimede
- 3 agosto 1830 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Archimede (Siracusa 287 a.C. - 212 a.C.). La
sua tomba fu scoperta e restaurata da Cicerone nel 75 a.C.
Il suo nome è legato a fondamentali studi dell'idrostatica
(equilibrio dei liquidi) e soprattutto sul calcolo delle
aree, dei volumi e delle spinte (il Principio d'Archimede).
Archimede studiò ad Alessandria d'Egitto, dove conobbe
Eratostene da Cirene (studioso dell'epoca). Rientrato a
Siracusa, si applicò ai suoi studi: la matematica, la
fisica, la geometria, l'ottica e l'astronomia. Egli riteneva
anche di avere delle idee sulla quadratura del cerchio, il
rompicapo di tutti i matematici. Il padre Fidia molto
stupito dall’intelligenza del figlio, decise di presentarlo
al re Gerone II, che lo tenne sempre in grande
considerazione. Nel 212 a.C. le truppe romane saccheggiarono
la città di Siracusa; un soldato entrò in casa di Archimede
e gli chiese chi fosse, ma Archimede, preso dal suo lavoro,
gli rispose male, quindi il soldato sentendosi offeso lo
uccise. Archimede volle che sulla sua tomba fosse scolpita
una sfera racchiusa da un cilindro (che indicava il rapporto
fra il volume dei due solidi). Nella guerra
contro Roma
Archimede aveva
partecipato genialmente alla difesa della città
con l’invenzione degli specchi che, riflettendo la luce del
sole, incendiavano le navi assedianti. |
|
|
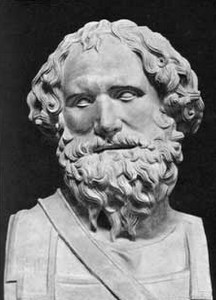 |
|
Archimede, busto in marmo, Napoli, Museo Archeologico
Nazionale |
|
|
|
Flavio Gioia
|
 |
|
Flavio Gioia, monumento in bronzo, Amalfi |
|
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a Flavio Gioia
- 3 agosto 1830 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Flavio Gioia, o Gioja (Amalfi o Positano XIV
secolo), è stato un navigatore ed inventore vissuto tra il
XIII ed il XIV secolo. È considerato da alcuni l'inventore
della
bussola magnetica. Flavio Gioia sarebbe nato ad Amalfi
o a Positano nella seconda metà del Duecento. Intorno al
1302 egli avrebbe perfezionato la bussola inventata dai
Cinesi, mettendo a punto un metodo per rendere lo strumento,
già adottato in precedenza dai naviganti arabi, veneziani e
gli stessi Amalfitani, più utilizzabile e pratico. Lo
strumento, costituito da un ago magnetico sospeso su di un
disegno a fleur-de-lis (il giglio araldico),
racchiuso in una scatola con coperchio in vetro, indica il
nord. Il giglio si presume fosse adottato in onore di Carlo
I d'Angiò, re di Napoli. È da rimarcare che Marco Polo al
suo ritorno dalla Cina nel 1295, può avere contribuito a
diffondere la conoscenza di dispositivi magnetici per la
navigazione usati dai Cinesi e dai popoli dell'Asia
visitati. |
|
|
|
Marco Vitruvio Pollione
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a Marco Vitruvio
Pollione - 3 Agosto 1830 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Marco Vitruvio Pollione - Marcus Vitruvius
Pollio (Formia 80-70 a.C. ca - 23 a.C.) è stato un
architetto, ingegnere e scrittore latino. Ex ufficiale
sovrintendente alle macchine da guerra sotto Giulio Cesare
ed architetto-ingegnere sotto Augusto (aveva progettato e
costruito la basilica di Fano), è l'unico scrittore latino
di architettura la cui opera sia giunta fino a noi. La sua
autorità in campo tecnico e architettonico è testimoniata
dai riferimenti alla sua opera presenti negli autori
successivi come Frontino. Della sua vita si hanno scarse
notizie. Scrisse il trattato De architectura
(L'architettura), in 10 libri, dedicato ad Augusto (che gli
aveva concesso una pensione), probabilmente tra il 27 e il
23 a.C. L'edizione dell'opera avvenne negli anni in cui
Augusto progettava un rinnovamento generale dell'edilizia
pubblica. Tale trattato, riscoperto e tradotto in epoca
rinascimentale (1414) da Poggio Bracciolini per primo, è
stato il fondamento dell'architettura occidentale fino alla
fine del XIX secolo.
L’uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci – disegno
1490 ca.
Leonardo da Vinci affermò: "Vetruvio
architetto mette nella sua opera d'architettura che le
misure dell'omo sono dalla natura distribuite in questo
modo. Il centro del corpo umano è per natura l’ombelico;
infatti, se si sdraia un uomo sul dorso, mani e piedi
allargati, e si punta un compasso sul suo ombelico, si
toccherà tangenzialmente, descrivendo un cerchio,
l’estremità delle dita delle sue mani e dei suoi piedi." |
|
|
San Tommaso D’Aquino
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a San Tommaso d'Aquino
- 8 Agosto 1830
(collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
San Tommaso d'Aquino (Roccasecca, 28 gennaio
1225 – Fossanova, 7 marzo 1274) è stato un filosofo e
teologo della Scolastica, definito Doctor Angelicus o
Doctor Universalis dai contemporanei. Rappresenta uno
dei principali pilastri teologici della Chiesa cattolica,
che lo venera come santo, lo considera Dottore della Chiesa.
Tommaso fu forse il pensatore più importante del Medioevo e
la sua influenza, nell’ambito della Chiesa cattolica, è
tuttora fondamentale. Era un uomo grande e grosso, bruno, un
po’ calvo ed aveva l’aria pacifica e mite dello studioso.
Per il suo carattere silenzioso lo chiamarono "il bue muto".
Tutta la sua vita fu spesa nell’attività intellettuale e la
sua stessa vita mistica la sua ricerca instancabile di Dio.
Fu canonizzato nel 1323. |
|
|
 |
|
Tommaso d’Aquino in un dipinto olio su tela del
pittore del ‘700
Paolo de Majo, Caserta, collezione privata |
|
|
Gian Lorenzo
Bernini
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a Gian Lorenzo
Bernini - 14 gennaio 1832 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
|
 |
|
Autoritratto, 1630 ca, collezione Cassa di Risparmio
di Calabria e Lucania |
|
|
Gian Lorenzo Bernini (Napoli 1598 - Roma
1680). Dominatore del secolo in cui visse, con la sua
personalità, il suo genio, le sue imprese artistiche, Gian
Lorenzo Bernini è stato per Roma e per il Seicento quello
che Michelangelo Buonarroti è stato per il secolo
precedente. Nasce a Napoli il 7 dicembre 1598 dove il padre
Pietro, sculture, e la madre Angelica Galante si erano da
poco trasferiti. Nel 1606 la famiglia fa ritorno a Roma:
Pietro ottiene la protezione del cardinale Scipione
Borghese. In questo contesto ci sarà occasione per il
giovane Bernini di mostrare il suo precoce talento. Gian
Lorenzo si forma alla bottega del padre e con lui realizza i
suoi primi lavori. Le opere del Bernini definiscono la sua
personalità, forte degli insegnamenti del padre ma nello
stesso tempo innovatore dello spirito di tutta una
generazione. E' ancora giovanissimo quando papa Urbano VIII
Barberini, con il quale l'artista stabilirà un durevole e
proficuo rapporto di lavoro, gli commissiona il "Baldacchino
di S. Pietro" (1624-1633), un colosso bronzeo di quasi
trenta metri. Nel 1629 Papa Urbano VIII nomina Bernini
architetto sovrintendente alla Fabbrica di S. Pietro. Le
fontane sono un prodotto tipico del gusto barocco; Bernini
inaugura una nuova tipologia, quella a vasca ribassata:
sempre per il papa esegue la "Fontana del Tritone" in Piazza
Barberini e la "Fontana della Barcaccia" in Piazza di
Spagna, a Roma. Nel 1644 muore papa Urbano VIII e si
scatenarono le gelosie rivali tra Bernini e Borromini, con
il quale ci ebbe ripetuti attacchi e polemiche in occasione
dei lavori per la facciata di Palazzo Barberini, sin dal
1630. Nel 1656 Bernini progetta il colonnato di San Pietro,
compiuto nel 1665 con le novantasei statue del coronamento.
Nel 1665 si reca in Francia per eseguire il busto di Luigi
XIV. Rientrato in Italia porta a compimento i lavori in San
Pietro e si dedica, tra altre attività. L'attività
dell'artista si conclude sotto il pontificato di Innocenzo
XI Odescalchi. L'ultima sua scultura è il "Salvatore" che si
trova custodita nel Museo Chrysler di Norfolk in Virginia.
Dopo una lunghissima vita dedicata all'arte, dopo aver
imposto il suo stile a tutta un'epoca, Gian Lorenzo Bernini
muore a Roma il 28 novembre 1680, all'età di 82 anni. A lui
è intitolato il cratere Bernini presente sul pianeta
Mercurio. La sua effigie è stata presente sulla banconota da
50.000 Lire italiane. |
|
Francesco Maurolico
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a Francesco Maurolico - 14 gennaio 1832
(collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Francesco Maurolico (Messina, 16
settembre 1494-22 luglio 1575) è stato un famoso matematico.
Ordinato sacerdote nel 1521, divenne in seguito abate
benedettino. Fu matematico, astronomo, architetto, storico e
scienziato dal multiforme ingegno. Per primo intuì e
sviluppò il principio di induzione matematica, studiò metodi
per la misurazione della Terra, fece osservazioni
astronomiche come quella della supernova apparsa nella
costellazione di Cassiopea, fornì le carte geografiche alla
flotta cristiana, in partenza dal porto di Messina per la
Battaglia di Lepanto, collaborò con lo scultore Giovanni
Angelo Montorsoli nella realizzazione di due delle più belle
fontane monumentali del Cinquecento, quella di Orione e
quella del Nettuno, fornendo i distici latini incisi sulle
fontane. Vasta fu la sua ricerca in moltissime discipline
scientifiche e corposa la sua opera manoscritta e le
pubblicazioni a stampa. Rimane uno dei geni del Rinascimento
italiano anche se ancora oggi la sua figura è poco
conosciuta. Uno dei più antichi crateri degli altopiani
meridionali della Luna, il cratere Maurolycus dal
diametro di circa 114 Km, è stato così denominato in suo
onore dall'astronomo gesuita Giovan Battista Riccioli nel
1651. |
|
|
 |
|
Busto di Francesco Maurolico, Messina, Museo
Regionale |
|
|
Caio Mario
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a Caio Mario
- 14 gennaio 1832 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Caio Mario - Gaius Marius (Casamari, 157 a.C.
- Roma, 13 gennaio 86 a.C.) è stato un generale e politico
romano, per sette volte console della Repubblica Romana.Combatté
in Spagna sotto il generale Scipione Emiliano; nel 119 a.C.
diventò tribuno della plebe. Pretore nel 115 a.C., ritornò
in Spagna per condurre una campagna contro i briganti che
terrorizzavano il paese. Accompagnò poi il generale romano
Quinto Cecilio Metello in Africa nel 109 a.C.; due anni
dopo, eletto console, ebbe il comando della guerra contro il
re di Numidia, che sconfisse e catturò nel 106 a.C. Dopo
aver sottomesso la Numidia, Mario diventò console per la
seconda volta, ebbe poi il comando nella guerra contro le
tribù germaniche dei Teutoni e dei Cimbri: sconfiggendole
entrambe nel 102 e 101 a.C. Considerato il salvatore della
patria, nel 100 a.C venne riconfermato console per la sesta
volta consecutiva. Quando a Silla, divenuto console, venne
affidata la guida della guerra contro il potente re
Mitridate VI il Grande nell'88 a.C., Mario, già da tempo in
conflitto con Silla, cercò di privarlo dell'incarico.
Scoppiò allora la guerra civile che oppose le due fazioni in
cui si divise l'esercito romano: quella "popolare",
sostenitrice di Mario, e quella "patrizia" di Silla. In una
prima fase prevalse Silla, che costrinse l'avversario a
fuggire dall'Italia, successivamente il conflitto volse a
favore di Mario, grazie a Lucio Cornelio Cinna che si
schierò con lui e organizzò tumulti a Roma. Sulla capitale
si diressero le truppe di Mario e Cinna che, dopo la resa
della città, massacrarono gli aristocratici della fazione di
Silla. I due vincitori si proclamarono consoli (86 a.C.) ma,
pochi giorni dopo, Mario morì. |
|
|
 |
|
Busto in marmo di Caio Mario, Monaco di Baviera,
Gliptoteca |
|
|
Alcmeone di
Crotone
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata ad Alcmeone di
Crotone
- 14 gennaio 1832 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Alcmeone (Crotone 560 a.C. ca - ?) padre
fondatore della medicina antica proprio negli anni della
mitologica battaglia della Sagra perduta contro l'esercito
di Locri Epizefiri. Non si conosce il luogo dei suoi studi
di medicina, ma le sue qualità mediche e scientifiche si
sviluppano da subito nell'antica Kroton, tanto che
all'arrivo di Pitagora in città, avvenuto intorno al 536
a.C. la fama di Alcmeone è già nota e diffusa in tutta la
Magna Grecia. Sezionando corpi umani e animali per studiarne
attentamente l'anatomia, e la causa scatenante le
disfunzioni corporali, Alcmeone diede origine al metodo
della ricerca scientifica, basato sull'analisi reale delle
cose. Scoprì nel cervello il centro motore delle attività
umane, andava infatti dicendo, il medico crotoniate, che
l'uomo sente tramite l'orecchio, ma capisce tramite il
cervello, e che gli animali sentono ma non capiscono perché
non dotati di cervello umano. Alcmeone studiò attentamente i
nervi ed il sistema nervoso, intuendone le funzioni motorie. |
|
|
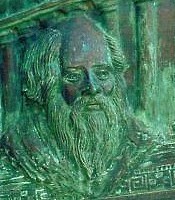 |
|
Alcmeone nel monumento in bronzo di Ludovico
Graziani, 1991, Crotone |
|
Alcmeone e Pitagora nel monumento in bronzo di
Ludovico Graziani, 1991, Crotone
|
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata ad Antonio Genovesi -
12 febbraio 1834
(collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Antonio Genovesi (Castiglione, Salerno 1713 -
Napoli 1769), filosofo ed economista. Ordinato sacerdote nel
1737, si dedicò all'insegnamento ed agli studi
nell'Università di Napoli, dove ottenne, nel 1741, la
cattedra di Metafisica. Orientatosi in seguito verso gli
studi economici, dal 1754 tenne la prima cattedra di
economia politica istituita in Europa, dalla quale fu
maestro e ispiratore per un'intera generazione di
riformatori napoletani. Filosofo empirista influenzato da
Locke nella Metafisica, che iniziò a pubblicare nel 1743,
Genovesi volle dare maggiore concretezza alle proprie
riflessioni affrontando i problemi dell'economia e
suggerendo ai governanti le possibili soluzioni nelle
Lezioni di commercio (1765-1767). Convinto della
necessità di stimolare l'industria interna con alte tariffe
doganali alle importazioni, sostenne invece, in accordo con
il pensiero economico riformatore, il libero commercio del
grano, la funzione positiva del lusso, la nocività dei
privilegi nobiliari ed ecclesiastici; collaborò alle riforme
introdotte nel Regno di Napoli da
Bernardo
Tanucci.
Visita la pagina dedicata ad Antonio Genovesi |
|
|
|
Alessandro D'Alessandro
|
 |
|
Alessandro d'Alessandro in un dipinto del XVI
sec. proprietà della famiglia d'Alessandro |
|
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata ad Alessandro
D'Alessandro - 12 febbraio 1834 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Alessandro D'Alessandro (Napoli 1461 - Roma
1523), nacque da una famiglia patrizia è stato un umanista e
giurisperito italiano ma anche giureconsulto. Discepolo del
Fidelfo e studioso di A. Gello delle di lui Notti Attiche.
Visse a Napoli in gioventù, ove si perfezionò negli studi
giuridici, si spostò a Roma seppur a fine età ottenne la
gestione di commenda di un monastero lucano. E’stato tra i
membri maggiori dell'Accademia Pontaniana. A lui si devono,
tra l'altro, le ricerche sulla legge delle Dodici tavole,
che descrisse nel famoso libro "Dies geniales",
commentato e tradotto in varie lingue da eminenti giuristi
europei.
(Un ringraziamento speciale al dr. Ettore D’Alessandro
autore delle note bibliografiche sopraccennate). |
|
|
Trotula De
Ruggiero
|
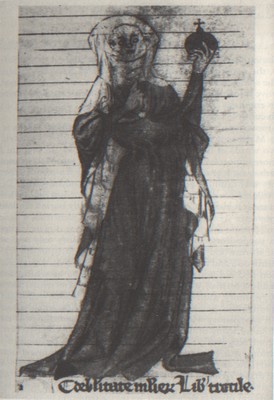 |
|
Trotula
de Ruggiero
in una raffigurazione tratta da un codice medioevale |
|
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a Trotula
de Ruggiero
- 12 febbraio 1834 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Trotula De Ruggiero (Salemo - XI sec.) è
stata un medico che nel XI secolo operò nell'ambito della
Scuola
medica salernitana.
Nata a Salerno dalla nobile famiglia salernitana De Ruggiero
(che rimase nella storia anche per aver ceduto a Roberto il
Guiscardo una parte dei suoi terreni per la costruzione del
Duomo di Salerno), Trotula ebbe l'opportunità di
intraprendere studi superiori e di medicina. Sposò Giovanni
Plateari, medico, i due figli della coppia proseguirono
l'attività dei genitori. La maggiore notorietà di Trotula,
la cui fama rimase per tutto il medioevo, era dovuta alla
sua grande abilità nel campo medico ed in special modo
ginecologico. Fu una delle più note Mulieres Salernitanae
ovvero le studiose che insegnavano o erano attive intorno
alla Scuola Medica Salernitana. I suoi trattati sulle
malattie femminili sono stati la base della moderna
medicina. La sua competenza si allargava anche alla
chirurgia e alla cosmesi. |
|
|
Giovanni Meli
|
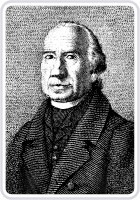 |
|
Giovanni Meli in una incisione del XIX sec. |
|
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata al poeta Giovanni
Meli
- 12 febbraio 1834 (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Giovanni Meli (Palermo 1740 - 1815) è stato
poeta e drammaturgo. Nella Sicilia del Settecento,
caratterizzata dalla monarchia riformista di Carlo di
Borbone, grazie al buon governo del Vicerè Caracciolo che
favorì con una serie di riforme la rinascita della vita
culturale e civile specie di Palermo, nacque il 6 marzo
1740, da Antonio di professione orefice e da Vincenza
Torriquas, il poeta Giovanni Meli, che raggiunse notorietà
in tutt'Italia, aderendo ai modi e allo stile dell'Arcadia
con una dimensione tutta sua e con l'uso della lingua
siciliana. Per poter vivere aveva intanto intrapreso gli
studi di medicina, spinto anche dalla madre, e nel 1764
conseguì il titolo professionale presso l'Accademia degli
Studi di Palermo. Esercitò la professione di medico
soprattutto a partire dal 1767, trasferendosi come condotto
nel paesino di Cinisi, dove veniva chiamato l'abate Meli. La
sua fama crescente lo richiamò a Palermo, conteso dalle dame
dell'aristocrazia nei loro salotti. Sensibile alla bellezza
femminile, questo singolare medico-poeta ebbe vari amori che
cantò alla maniera arcadica nelle sue Odi e nelle
Canzonette, che sarebbero state imitate da tanti poeti
come il Goethe e il Foscolo e tutta la serie dei poeti
dialettali siciliani. Divenne professore di chimica presso
l'Università e venne chiamato a far parte come socio
onorario delle più importanti accademie italiane come quella
di Siena (1801) e quella peloritana di Messina. Nel 1810 il
re Ferdinando gli concesse una pensione annua, ma nel 1815,
dopo le rivolte giacobine gliel'avrebbe sospesa. Morì a
Palermo il 20 dicembre 1815, mentre l'Europa dei Lumi
assisteva al concludersi della vicenda napoleonica. |
|
|
Giuseppe Gioeni
|
 |
|
Giuseppe Gandolfo, Giuseppe Gioeni dei duchi
d'Angiò, olio su tela, Catania, Università degli Studi, Palazzo
Centrale |
|
|
 |
 |
|
Medaglia in bronzo dedicata a Giuseppe Gioeni -
12 febbraio 1834
(collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
 |
 |
|
Medaglia c.s. con la scritta; “V.CATENACCI F. /
L.TAGLIONI CON.NEAP” (collezione Francesco di Rauso, Caserta) clicca sull'immagine per ingrandire |
|
|
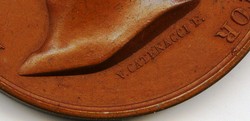 |
 |
|
particolari delle firme dei due esemplari, clicca sull'immagine per ingrandire |
|
Giuseppe Gioeni dei duchi d'Angiò (Catania
1747-1822) prese ad interessarsi di vulcanologia dopo aver
letto l'opera sui campi flegrei edita a Napoli nel 1776 da
William Hamilton, l'ambasciatore inglese che era a corte dei
Borbone a Napoli. Cominciò a raccogliere produzioni
mineralogiche e zoologiche con l'intento di allestire un
museo. Nel 1780 l'Università di Catania gli affidò la
cattedra di storia naturale e botanica legandola ad una
procedura speciale, poiché tale conferimento venne concesso
a vita. Negli anni ottanta compie frequenti soggiorni a
Napoli, ove conosce sir Hamilton e si integra con successo
nella vita di corte borbonica. All'apice della sua fama
scientifica, la vita di Gioeni dopo il 1790 fu interamente
legata a disavventure di carattere economico e politico, che
lo distolsero praticamente in maniera definitiva dalla
ricerca scientifica. |
|
|
Tempo fa,
confrontando alcuni doppioni, notai nella medaglia raffigurante Gioeni una
variante al dritto; mancava infatti la scritta “L.TAGLIONI CON.NEAP.” sotto
il taglio del busto. E’ chiaro che gli esemplari con suddetta mancanza
vennero coniati per primi e che dopo essersi resi conto dell’errore si
provvide ad aggiungere la frase mancante, continuando così la coniazione.
Non posso stabilire con certezza quale sia la più rara tra le due varianti.
Posso dire, però, che finora la maggior parte degli esemplari apparsi sul
mercato sono quelli senza la scritta “L.TAGLIONI CON.NEAP.” Ritengo che chi
ha collezionato queste medaglie abbia fatto un ottimo investimento.
Sfogliando infatti alcuni cataloghi d’asta e listini a prezzi fissi, ho
constatato che, nel decennio 1990-2000, potevano essere facilmente
acquistate a cifre che oscillavano tra 80.000 e 130.000 Lit circa (40-65
Euro circa), da lì poi un balzo in avanti fino a toccare i circa 100-130
Euro nel triennio 2001-2003, oggi in conservazione spl/fdc valgono circa 250
Euro fino ad arrivare ad un massimo di 400 Euro in Fdc. Per quanto concerne,
invece, quelle di Trotula De Ruggiero, Giovanni Meli e Giuseppe Gioeni, le
quotazioni oscillano oggi, dai 350 euro per una splendida conservazione,
fino ai 600 euro per il Fdc (vedi aggiudicazioni asta Varesi del 4-2007) …
il motivo? Queste ultime sono sicuramente più richieste e quindi
difficilmente più reperibili sul mercato rispetto alle altre. Mi risulta,
infatti, che subito dopo la loro coniazione, ogni serie coniata completa da
17 esemplari complessivi (venduta ai privati su richiesta), era composta da
16 soggetti in bronzo più un esemplare in argento di un soggetto a caso. Non
si sa quante serie complete furono fatte in quanto non sono stati ancora
trovati i documenti ufficiali della zecca che ne stabilirono la tiratura.
Una cosa è certa … queste medaglie hanno tutte lo stesso grado di rarità,
mentre quelle in argento (anch’esse aventi lo stesso grado di rarità tra
loro), sono ben “17 volte” più rare di quelle in bronzo. Gli esemplari in
argento quindi, sono da considerarsi di grande rarità in quanto mancano
nella maggior parte delle collezioni pubbliche e private. Va aggiunto,
inoltre, che gli esemplari (sia in bronzo che in argento) giunti fino ai
giorni nostri, corredati dall’astuccio originale, sono da considerarsi ancor
più pregiati. A conclusione del presente articolo, va ricordato che il primo
a fare degli studi su queste medaglie fu il celebre studioso dr. Giovanni
Bovi, e difatti, possiamo trovarle anche nel volume riguardante gli
“Studi di Numismatica (1934-1984)”, Napoli 1989.
La seguente parte è tratta da
“Il Medagliere” di Salvatore D’Auria (2006)
Da una
lettera del 5 Agosto 1829 diretta per conto del ministro delle finanze al
ministro degli affari interni risulta che il direttore dell’Amministrazione
delle monete faceva sapere con un rapporto del 28 Luglio …, “che alcuni
incisori stan costruendo delle medaglie per diversi uomini illustri
napoletani e che queste medaglie debbono battersi col torchio che il signor
Lorenzo Taglioni fece venire dalla Francia tempo fa per la sua fabbrica di
bottoni. Osserva il ridetto “direttore che siffatte operazioni non debbono
essere permesse fuori dalla Regia Zecca perché potrebbe aversi il dispiacere
di veder sotto l’occhio del Real Governo battute medaglie con figure
scandalose, con segni simbologi e con leggende non convenienti e ciò per la
parte politica, giacchè per ciò che concerne la parte fiscale a suo opinare
questa operazione dovrebbe essere proibita, mentre i torchi che battono
medaglie possono agevolmente battere le monete di una perfezione tale da
potersi confondere con le vere. Senza dunque macchiare in minima parte la
conosciuta onestà e delicatezza del Signor Taglioni, ma per regolare
andamento della cosa, egli provoca quelle energiche misure che si crederanno
più convenienti pel torchio anzidetto e per riguardo alle medaglie in
discorso, che desse in qualunque stato si trovano per l’incisione, siano a
lui presentate per esaminare le figure e le leggende, e quindi farle battere
in Zecca: ov’è prossima ad istallarsi un gabinetto d’incisione. “Nel darmi
dunque l’onore di manifestare quanto di sopra a V.E. “La prego a voler dare
quelle disposizioni che crederà opportune per “l’oggetto in conseguenza
degli antecedenti sufferiti. Il Taglioni ottenne i permessi di battere le
medaglie servendosi del proprio “bilanciere” e dell’opera degli incisori
addetti alla Regia Zecca di Napoli, quali i maestri Vincenzo Catenacci,
Achille e Luigi (o Aloysius) Arnaud. |
Si
ringrazia per la gentile collaborazione il dr. Salvatore
D'Auria.
Molte delle
notizie sui personaggi illustrati in questa serie di medaglie
qui riportate sono tratte da Wikipedia.
Articolo pubblicato nel Luglio 2008
Pubblicazione on-line del Luglio 2008
|
|
Centro Culturale e di Studi Storici "Brigantino- il Portale del Sud" - Napoli e Palermo
admin@ilportaledelsud.org ®copyright 2008: tutti i diritti riservati. Webmaster: Brigantino.
Sito derattizzato e debossizzato
|