vai alla pagina precedente
Il degno Omero di quell’Iliade:
Alexandre Dumas (1802-1870)
304. “Che sperpero si facesse delle cose règie (dopo
l’entrata di Garibaldi in Napoli, il 7 settembre 1860)
si può intendere; ma va notato che a’ 14 settembre Don
Liborio menò a mano il romanzatore Alessandro Dumas
nella règia casina al Chiatamone; e una lettera del
Garibaldi gliela die' per un anno; acciò cotesto comico
repubblicano francese potesse in Napoli vivere da re.
305. Avea costui già fatto danari mescolandosi nelle
forniture d'arme; e molta moneta avea presa all'erario.
Ma
quasi le sue spampanate narranze garibaldesche non
fossero pagate abbastanza, a' 16 di quel mese andò
direttore del Museo; e quantunque negasse il giuramento
a Vittorio, pur venne insediato. Il primo suo atto fu
l'apertura della sala di statue oscene, che pel costume
si tenea chiusa.
306. Niente di manco i giornali, anche liberalissimi,
stomacarono: dicevano, quegli straniero, ignorante e
avido, non potere in quell'uffizio far altro che
rapinare cose di valore; e così strepitarono, ch'ei si
dimise il 28”.
Rimase però direttore onorario del Museo (=
percepiva lo stipendio senza fare alcunché) e continuò
“ad impiastrare un giornalaccio detto L’Indipendente,
pagato dal dittatore” … e pagato poi dai luogo-tenenti
sabàudi suoi successori, fino a che se ne ritornò, ben
rimpinguato, in Francia nel 1864.
307. Alessandro Dumas è proprio il famoso romanziere
francese, autore, fra le tante cose più o meno scritte
da lui (aveva infatti molti collaboratori), del ciclo
detto “dei 3 moschettieri” ovvero “I
tre moschettieri” (1844), “Vent’anni dopo” (1845) e “Il
visconte di Bragelonne” (1848); ed inoltre de “Il conte
di Montecristo” (1844), “La regina Margot” (1845) e
decine e decine di altri romanzi, che venivano
pubblicati a puntate sui giornali dell’epoca.
Il quale Dumas, dunque, giunto all’età di circa 55 anni,
dopo aver invano tentato di diventare editore,
pubblicando un suo giornale dal titolo “Il
moschettiere”, affranto
dalla delusione economica, intristito dalle conseguenti
noie giudiziarie, e perseguitato dai creditori, aveva
gran desiderio di distrarsi con nuove avventure.
Nel giugno 1858, una coppia di aristocratici russi, suoi
ammiratori, se lo portò (gratis) a San Pietroburgo e gli
fece girare da turista (sempre gratis) tutta la Russia,
fino a Tiblisi in Georgia, per dieci mesi.
308. Rientrato poi evidentemente entusiasta in Francia, volle
subito intraprendere niente di meno che “il grande
viaggio di Ulisse” ovvero ripercorrere tutte le tappe,
descritte nell’Odissea, dell’itinerario di ritorno del
mitico eroe fra le braccia della fedelissima consorte a
Itaca.
Avuta però notizia dello sbarco dei Mille a Marsala l’11 maggio
1860, modificò il suo itinerario e, invece che sulle
orme di Ulisse, si pose sulle orme di Garibaldi,
approdando a Palermo, su una goletta di sua proprietà
chiamata "Emma", per aggregarsi, a modo suo, all’epica
impresa.
.jpg) |
|
Alexandre Dumas (1802-1870) |
Il grande Alessandro a Palermo
309. Come questo accadde, è efficacemente narrato da un testimone
oculare, il garibaldino Giuseppe Bandi:
“Nel tornare a casa, mentre eravamo per scavalcare una
barricata, un bel pezzo d’uomo ci venne incontro, e da
lungi salutò in lingua francese il generale.
Quell’omaccione era tutto vestito di bianco ed aveva in
testa un gran cappello di paglia, adorno d’una penna
azzurra, d’una penna bianca e d’una rossa.
– Indovinate un po’ chi è colui? – mi chiese Garibaldi.
– Chi può essere? – risposi – Louis Blanc, Ledru Rollin?
– Oibò – soggiunse il generale, ridendo – è Alessandro
Dumas.
– Come? L’autore del Conte di Montecristo e dei
Tre Moschettieri?
– Proprio lui.
Le grand Alexandre
abbracciò Garibaldi con infinite dimostrazioni
d’affetto, ed entrò insieme a lui nel Palazzo Pretorio,
predicando e ridendo forte, non altrimenti che della sua
voce e della sua allegria volesse riempire il palazzo.
310. Fummo chiamati a colazione … Il grande
Alessandro mangiò come un poeta, e si mostrò tanto
voglioso di discorrere, che mai non volle prestar lo
staio a nessuno. Vero è che parlava come sapeva
scrivere, e io stetti a bocca aperta ad udirlo, anche
quando per la soverchia velocità del discorrere, non
capivo un’acca delle sue parole …
Quando comparve in tavola la zucca delle monache,
il grand’Alessandro fece tanto d’occhi, e se ne cacciò
in bocca una gran fetta; poi si die’ a cantarle il
magnificat, e tanto l’ebbe commendata, che il
generale la fece riporre in un cartoccio, e tutta gliela
offerse perché la portasse con sé.
Monsù Dumas tolse lietamente il cartoccio e lo consegnò
al suo ammiraglio, cioè alla femminuccia che
aveva seco; e poi disse a Garibaldi: – Voi mi avete
regalato una delizia, ma io saprò ben ricambiare il
dono.
E, bevendo un ultimo bicchiere di vino di Marsala, dette
la fausta novella d’aver recato, a bordo della piccola
sua nave che si chiamava Emma, tante e bellissime
armi, le quali eran tutte del dittatore, senz’altra
fatica che quella di mandarle a prendere.
311. Noto, a questo proposito, che il generale ci mandò
più tardi a pigliare le armi d’Alessandro Dumas, e noi
ci andammo con un grosso navicello; ma le armi che ci
dette il francese, non avrebbero empiuto un carrettino
di competenza d’un somaro.
Infatti, tutto quel gran tesoro consisteva in sette o
otto sciaboloni da cavalleria, e in dodici vecchie
carabine: roba degnissima del ferravecchio.
Ossequienti però al proverbio che a caval donàto non
si guarda in bocca, pigliammo le armi e le recammo
al generale, che rise assai, paragonando i doni
minuscoli del gran romanziere francese colla
magnificenza delle sue promesse”.
312. In realtà Garibaldi sapeva benissimo che il
contributo militare di Dumas all’impresa sarebbe
stato praticamente nullo, ma sapeva anche che assai
grande poteva essere, invece, il suo contributo
propagandistico; e quindi, come scrive giustamente
il de’ Sivo, “decise apposta di portarsi dietro
quel cicalòne, che voleva far l'Omero di quell’Iliade”,
rimanendo però prudentemente a bordo della sua navicella
ad osservare le battaglie a distanza di sicurezza. E
così …
Dumas inebriato a Milazzo
313.
“(Sempre in Sicilia, dopo la battaglia di Milazzo: 17-24
luglio 1860)
… ancor venne a visitare Garibaldi il romanziero Dumas,
cui die' il carico d'un giornale, L' Indipendente;
e inoltre, sotto titolo d'avere a comprare 1.500 fucili,
gli die' lettere per 100 mila franchi, da riscuotere a
Palermo.
Il
sindaco La Verdura non volle pagare; ma il Depretis
(deputato piemontese, inviato del Cavour, nominato
pro-dittatore da Garibaldi) ne fece pagar subito 60
mila (dalla cassa del Comune).
314. Allora il Dumas, inebriato di quei denari, sciorinò
cose magne: stampò 7.000 Napoletani vinti da 2.500
garibaldini; né so quante dozzine di duelli da epopea;
vi ficcò Svizzeri, Bavaresi, e altre baie.
Ma
il Garibaldi s'aveva a posta menato questo cicalone, che
tolse a far l'Omero di quell’Achille”.
Dumas nel golfo di Napoli
e Don Liborio
315. Poco dopo, “il romanzatore Dumas, corifeo della
rivoluzione, dandosi gran da fare, s'era impunemente
ancorato nel golfo, avanti la reggia, sur un battello
detto l'Emma, donde spargeva arme e
proclamazioni, e teneva le corrispondenze de' felloni
col Garibaldi.
316. Don Liborio Romano anch'esso, con mezzano un
Muratori, dicentesi presidente del general comitato
rivoluzionario, vi trescava; anzi, la notte del 23 andò
egli stesso sul battello, e col Dumas convenne:
s'affrettasse il Garibaldi; ed egli indurrebbe il re a
lasciar Napoli; in contrario, o si salverebbe sur un
legno inglese, o dichiarerebbe Francesco traditore della
costituzione e solleverebbe la guardia nazionale ed il
popolo.
Gli
promise, inoltre, che al primo tentativo di reazione del
re andrebbe al Garibaldi con due colleghi, per dichiarar
lui decaduto, e questo riconoscere dittatore.
Anche gli presentò una gentildonna che gli recherebbe
l'ambasciata; intanto domandasse per lui la protezione
del Par Kings ammiraglio inglese. Questa di fatto
ottenne; e alla dimane mandò al Dumas il suo ritratto,
con sotto così scritto: Ritratto d'un vile, se non vi
mantengo le promesse che vi feci ieri.
Tali lordure essi stessi hanno poi stampate, per vanto.
317. Il re, per verità, ebbe prove di quella visita
notturna; e consigliato dal generale duca di S. Vito,
stette per far arrestare il traditore Don Liborio; ma
questi, o ne avesse sentore o a maggiore inganno, gli si
presentò baldanzosamente a raccontare la sua gita sull’Emma,
dicendo lavorar col Dumas per far retrocedere il
Garibaldi. Non credo Francesco se ne persuadesse; ma
(purtroppo) il fe' restar libero, e ministro del suo
nemico”.
Dumas in Napoli
318. Entrato poi Garibaldi in Napoli, il Dumas ebbe
regale appartamento ed onori, e molti soldi (vedi sopra)
per raccontare a modo suo le trascorse vicende.
Ed
anche dopo che Garibaldi ebbe lasciato la dittatura,
giunto il
14 luglio 1861 il massacratore generale Cialdini come
quarto luogo-tenente
dopo il Farini, il Carignano e il Ponza … “al
Dumas, cui si dava casa al Chiatamone, crèbbesi il
sussidio a 16 mila franchi, per impiastrare storie
contro i Borboni; e giustamente, perché occorreva
proprio lui per sì sozzo mandato … Napoli pagava”.
319. A quel tempo, il Dumas aveva già scritto “Il
corrìcolo (= Il piccolo calesse)”, pubblicato nel
1843: era stato a Napoli per una quindicina di giorni
nel 1835, ed alcuni anni dopo, le impressioni e i rapidi
incontri avuti in quei giorni, congiunti alla sua
fertile fantasia, generarono un volumetto composto di
aneddoti e personaggi in gran parte inventati, e di
luoghi comuni su Napoli e i napoletani, di facile e
gradevole lettura ma di nessun valore quanto a
documentazione storica.
Nel periodo napoletano, scrisse un libro di “Memorie di
Garibaldi” (1860) ed un altro parallelo su “I
garibaldini” (1861) e subito dopo, sempre ben alloggiato
nella casina borbonica, elaborò una infamante quanto
infondata “Storia dei Borboni di Napoli” (1862).
Scrisse anche un, parimenti improbabile, excursus
su
“Cento anni di brigantaggio nelle province meridionali
d’Italia”, pubblicato nel 1863, e poi varie volte
ristampato; nonché alcuni sconclusionati appunti sulla
camorra.
320. Nel frattempo, nel 1862, si era ascritto alla
Loggia massonica napoletana denominata “Fede italica”,
fondata dal “Grande Oriente d’Italia” il 18 agosto 1861,
cioè subito dopo l’arrivo come luogo-tenente del
massacratore Cialdini, ed in seguito “demolita”
ufficialmente il 23 luglio 1877.
Dumas in patria sua
321. Ritornato infine in patria sua, continuò ad
infierire su personaggi storici della patria nostra,
scrivendo nel 1864-65 le “biografie romanzate” prima di
Emma Lyon (“Le confessioni di una favorita”) e poi di
Luisa Sanfelice (“La Sanfelice”): entrambe consigliabili
a chi voglia amabilmente pàscere la propria fantasia ma
assolutamente controindicate a chi ricerchi la verità
storica dei fatti.
Ultimamente (2002), le autorità liberali e massoniche
francesi hanno voluto collocare addirittura nel
Panthéon nazionale di Parigi la ingombrante salma di
questo loro menestrello, evidentemente riconoscenti a
colui che ha procurato ai francesi l’indiscutibile
privilegio di avere una doppia versione della
loro storia: una vera, e l’altra inventata, ma molto più
romantica …
Arriva il Savoia: il celebre incontro
presso Teano
322. La dittatura garibaldina durò 2 mesi, dal 7
settembre al 7 novembre 1860. Il 21 ottobre si fece il
plebiscito. Il 26 ottobre avvenne il celebre incontro
fra Garibaldi e Vittorio Emanuele II presso Teano.
323. “(I garibaldini) … si spinsero in labirinti
di viuzze tra Gerusalemme, Bellona e Vitulaccio,
saccheggiando la campagna, e pigliando prigionieri qua e
là qualche centinaio di soldati borbonici malati, e
parecchi degli stranieri, che a posta s' eran rimasti
indietro.
Presso Bellona, il Bixio cadde di cavallo in una
pozzanghera, e si ruppe una gamba, onde il portarono a
Napoli, ed ei si pose nel palazzo Angri.
324. Gli altri fermarono a Calvi; la sera accamparono a
Caianello … La notte, il Garibaldi si teneva vicino
(come infermiera …) la famosa inglese Jessie
White (1832-1906), moglie del garibaldino Alberto
Mario; e il Rustow ancor più vicino l'altra non men
famosa contessa della Torre (Maria Luisa Salasco,
moglie separata di Enrico Martini Giovio della Torre;
1830-1913); le quali due, quando al mattino furono
messe insieme in una carrozza, vennero a tali
scaramucce, che bisognò torne una, e porla col
cocchiere.
.JPG) |
|
Maria Luisa Salasco, moglie separata di
Enrico Martini Giovio della Torre (1830-1913) |
325. Questo mattino del 26 ottobre, Vittorio col
Cialdini e due divisioni veniva da Venafro su Caianello.
Il
Nizzardo, co' suoi avviato sur un sentiero che mena a
Vairano e Marzanello, avea mandato avanti il Missori con
cavalli; il quale tornò con Piemontesi, nunziando il re
poco discosto sulla via consolare.
Ei,
lasciata la gente, volse là, e incontrò prima il
Cialdini, poi Vittorio, cui disse: - Saluto il re
d'Italia. Rispose: - Grazie. Se arrossisse,
non so.
Si
fe' accompagnare da esso a Teano; ma con poco gradimento
dei suoi, che dietro le spalle sussurravano i
Garibaldini potersene andare; perciò, dopo mezzodì,
mandò a questi l'ordine di retrocedere a Calvi.
Il
dittatore vide a Teano, con mal piglio, alcuni suoi
vecchi con-settàri: il Fanti ministro di guerra; ed il
Farini, venuto a soppiantarlo. Si ritrasse a Calvi, il
re dormi a Teano”.
 |
|
Il famoso incontro fra Garibaldi e
Vittorio Emanuele II il 26 ottobre 1860 |
Il Savoia entra in Napoli (7 novembre
1860)
326. Il 7 novembre, sotto una pioggia torrenziale, il re
giunse a Napoli.
“Acciò i Napolitani s'accorgessero che dovevano gioire,
i congiuratori già alto insediati, volean fargli
magnifica I'entrata; e i bruchi piombati sul municipio
si davano a spese magne.
Disegnarono dodici archi trionfali e piramidi, un
monumento a Napoleone III, quattro statue al Cavour e a
tre generali sardi, un certo tempio al Garibaldi
con una iscrizione ridicola, tutto carta, pali, tele e
funi, con pitture trasparenti, lumi e ghirlande.
Cominciarono venti giorni prima, ma lenti, mancando i
denari, o non bastevoli alla sete de' sovrastanti …
Rimediarono parecchi simulacri posticci, con vittorie
garibaldine e ritratti di Fanti, Cialdini, Turr, Medici,
Cosenz, e altri massoni. Quello di Garibaldi, già fatto
e posto, tolsero in fretta.
Avanti la reggia, nascosero con panni le colossali
statue di Carlo III e Ferdinando I; e v'alzarono sopra
un enorme catafalco quadrato, vero mausoleo di carta, e
stracci, con pitture.
Il bello furono cento statue di gesso simili, poste per
Toledo su piedistalli, con una mano alta e una giù,
quasi sonassero il contrabbasso; certe nude femminone,
che dicevano essere le cento città d'Italia proclamanti
l'unità. Ma tutti ne ridevano; e il garibaldino Rustow
ha poi scritto che i napoletani avevano messe quelle
bagasce in mostra, per allettare Vittorio a rimanere con
noi. Pigliarono da 200 mila ducati, per tali baie.
Ma
il cielo, nemico d'Italia, guastò tutto; la notte
precedente, acque dirotte e venti e turbini: a pezzi le
“città d’Italia”, colanti le pitture, sbrandellati i
canavacci, bucherati i cartoni; tutto scollato, vedevi
travi e funi, forche e non archi trionfali.
 |
|
Il Re Vittorio Emanuele II di Savoia in
un ritratto 'ufficiale' |
327. Tra quei squallori, e piovendo, entrò Vittorio quel
dì 7 novembre 1860, sull'ore nove e mezzo, in carrozza,
col Garibaldi a lato, e il Pallavicino e il Mordini,
pro-dittatori di Napoli e Palermo, a fronte.
Gli
facevano corteggio a piedi lazzaroni scamiciati, e
camorristi plaudenti e saltellanti con ombrelli e
frasche; poi carabinieri armati, lo Stato maggiore, e un
drappello di guide, poca gente, scarsi plausi, rari
fiori. Ei salutava col guanto dove vedea qualche balcone
pieno, quasi voglioso di saluti protettori.
Carlo III borbonico era entrato gittando danari d'oro,
bello e giovine; Gioacchino Murat napoleonico, tutto
diamanti e pennacchi, da eroe di cento vittorie; costui
tapino, sgradevole, spauriva. Faccia scura, occhi gonfi,
baffoni, tozzo, sporco; il popolo strabiliava, né si
persuadeva sì laida figura portasse tante belle promesse
cose.
Ma
gli facean rumore attorno i camorristi, tra' quali un
Antonio Lubrano, famigerato omicida, che co' suoi
strepitanti gli stette sullo sportello della carrozza
sino a palazzo. Questi dappoi andò alla Polizia a
vantare tal servigio alla causa, protestando non dover
più esser carcerato, dopo avuto l'onore di stare ai
fianchi di Sua Maestà”.
8 novembre 1860
328. Appena giunto alla reggia in Largo di Palazzo, il
“re galantuomo” subito prudentemente vi si rinchiuse, né
si fece più vedere.
Il giorno dopo, 8 novembre, in quella stessa sede, nella
stanza del trono, ricevette ufficialmente i risultati
del finto plebiscito con il quale i napoletani avevano
“liberamente deciso” di volere lui e i suoi discendenti
come re nella nuova Italia.
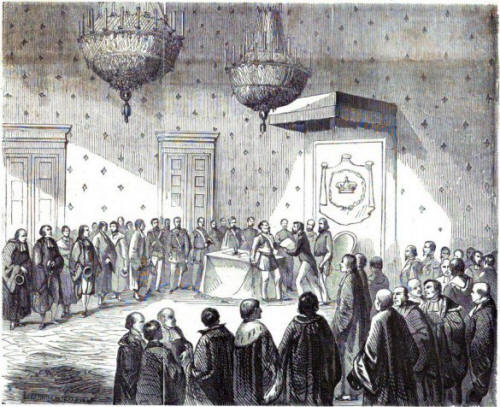 |
|
Vittorio Emanuele II riceve ufficialmente
i risultati del plebiscito |
329. “L'Omnibus, già favorito dai Borboni, stampò
la venuta di Vittorio Emmanuele esser quella del
Messia, la venuta di Dio! E questo Dio nero, la
sera, al teatro S. Carlo, ebbe l'inno, scritto da
Domenico Bolognese.
Costui, inneggiato a libertà nel 1848, non solo scansò
qualsiasi pena, ma ottenne da re Ferdinando due impieghi
e due stipendi; eppure cantò Garibaldi precursore e
angelo di Dio, ed Emmanuele d'Italia Dio. Pose il
Petrella la musica, che riuscì misera.
Il
re niente n'udì; perché, cominciato lo spettacolo, certi
garibaldini, volendo entrare nel teatro già pieno,
trassero le pistole, e si fe' rumore, e accorsero
Carabinieri, di che turbato Vittorio poco stante si
ritirò …
330. Lumi non si videro, e incolparono la pioggia;
venuto il sereno, il sindaco supplichevole più volte
invitò la popolazione ad illuminare almeno Toledo e
qualch'altra strada; ebbe meschino effetto … Ma il
cielo, niente adulatorio, piovve quasi sempre … ed anche
quelle poche luci, con rovesci d'acqua le spense”.
9 novembre 1860: Garibaldi se ne va
331. Il terzo giorno, 9 novembre, il Garibaldi
angelo precursore del novello Messia
se n’andò.
“Pien di livore, sull’alba del 9, lasciò la città, ben
diversamente da quel che v'era entrato; era seco il
figlio, un Bassi, un Gusmarolo, un Forsecanti e un servo
Manuele. Prima di salpare, salì a far visita al Mundy
ammiraglio inglese, e n'ebbe saluto con l'artiglierie …
e sull'Annibale, vascello inglese, alla sterile
Caprera si riduceva”.
Se ne va anche il Savoia, la notte di S.
Stefano
332. Liquidato il Garibaldi, Vittorio rimase ancor poco
in Napoli. Anche lui, infatti, il novello Messia,
aveva i suoi problemi con i napoletani.
Un
giorno, “le donne di certi carcerati camorristi
fermarono la sua carrozza, gridando grazia, e
rinfacciandogli i loro mariti aver fatto entrare il
Garibaldi; sentì l'insulto, sferzò i cavalli, e le
piantò strepitanti …
Anzi, a fuggire i dimostranti, i minaccianti e gli
affamati, se ne salì a Capodimonte; e tra donne e
animali, come in harem, si chiuse”.
333. Infine, “essendo dunque Napoli e il reame in
anarchia e guerra civile … Vittorio un dì si pensò
appagare di sua persona il popolo, in pubblica
udienza.
Nessun onesto v'andò, v'andò il popolo del plebiscito;
entrarono a torme, tutti postulanti, in mille divise;
camice rosse, sciabole, stili, e pistole, grida strane e
confuse; lazzari, femmine, frati, tutti a sospingere e
urtare.
Egli, spinto sotto una finestra, ebbe bisogno delle
guardie per ritrarsi, pure in recondite stanze pressato.
Sgombrate a forza le sale, si trovò quel popolo
sovrano aver fatto parecchie annessioni
d'arnesi di su le tavole.
334. Sgomentato, stanco di tanto gridìo, sentendosi a
Napoli straniero e mal sopportato … partì a mo' di
fuggiasco, improvvisamente, la notte seguita al 26
dicembre; ed a furia, per le poste a Bologna, di là su
vie ferrate, a Torino trionfante giunse la sera del 29”.
Il primo luogo-tenente: Farini,
l’eccelso
335. Lasciava in vece sua
Luigi Carlo Farini (1812-1866),
già preventivamente nominato il 6 novembre da Sessa
Aurunca e stato al suo fianco, come “Luogo-tenente
generale” dei territori napoletani.
Ma l’opera del Farini venne ritenuta tanto poco
soddisfacente, che già nel gennaio 1861 fu sostituito da
un principe di casa reale,
Eugenio di Savoia-Carignano (1816-1888),
affiancato dal diplomatico
Costantino Nigra (1828-1907)
che aveva essenzialmente il compito di inviare continui
e dettagliati rapporti al Cavour.
336. Era il Farini un massone romagnolo, dai suoi
confratelli denominato in tutta serietà “l’eccelso”,
essendo egli vero tempio di virtù, gran politico, gran
scienziato e grande scrittore.
In realtà, dopo molto questuare, aveva solamente
l’incarico di medico condotto in un paesino del
ravennate, donde era assurto, per meriti “patriottici”,
al corteggio del re galantuomo.
337. Essendo uomo da chiacchiere, esordì in Napoli con
molte promesse … ma “da sì largo promettitore, avemmo
due mesi d' incredibili stoltezze”.
Costituì un consiglio di luogotenenza, più una consulta,
entrambi formati da persone che non avevano altro merito
se non quello di aver fatto parte della delegazione
mandata a chiedere al “re galantuomo” di invadere il
Regno meridionale.
Si auto-assegnarono anzitutto lauti stipendi … “si
dettero ducati 400 mensili per ciascuno, e a un certo
Bonghi, segretario, 200. Esso Farini tirava 200 mila
franchi per spese di viaggio (che non viaggiava) e 11
mila ducati il mese.
Non potendo, e non sapendo, far altro, mutò i nomi: il
Prefetto di polizia si disse Questore,
perché così a Torino, quasi avesse a cercare denari.
E chiamò impiegati dalla questura di Torino.
%20primo%20luogo-tenente%20generale%20dei%20territori%20napoletani.jpg) |
|
L'eccelso Luigi Carlo Farini (1812-1866)
primo luogo-tenente generale dei territori napoletani |
338. I liberali stessi bistrattavano il Farini; e lo
appellavano presuntuosa nullità. E questi,
l’eccelso, venuto con tanta prosopopea, e che viveva
da re nelle stanze di Francesco II, s'ammalò
d'itterizia, per bile.
Aveva scritto voler morire povero; ma graditogli il
vivere principesco, niuna grandezza più il contentava.
A Portici, scelse a camera da letto quella già servita a
Pio IX, mutata da Ferdinando in oratorio; i custodi
cercavano dissuaderlo; cocciuto il volle, e vi pose il
letto; ma dopo due giorni, il letto e la stanza, non si
sa per qual caso, andarono in fuoco.
Dopo la dittatura nell'Emilia, avea maritata una figlia
con pompa a un Riccardi: se lo portò segretario a
Napoli; e gli morì la notte della vigilia di Natale.
339. Avvertito, dagli strèpiti universali, che
quell'aria non gli poteva durare, si die' da fare per
agguantare il meglio, fino a che, mostrata sua solenne
incapacità, inviso ad ogni partito, fu gittato da canto;
e così, alla prova del fatto, venne meno ridicolosamente
quest'altra fatua settaria celebrità.
Vantatosi di restaurare l'ordine morale, fu sopraffatto
dalle immoralità sfrenate da esso; e cadde màcero come
canna.
Vittorio, nel consiglio del 31 dicembre a Torino, lo
cassò; e scorta l'inconvenienza d'aver insultato un
reame con un medicuzzo luogotenente, stimarono rimedio
mandarvi Eugenio di Carignano, cugino del re”.
Il
secondo luogo-tenente: Carignano,
il principe
340. “Un decreto del 7 gennaio 1861 assegnò al
Savoia-Carignano due milioni di lire annuali, a peso
dell'erario napoletano, per sole spese di
rappresentanza; sicché il reame, fuso nell'unità
italiana, restava napoletano solo per pagare a sì
sterminato prezzo quest’altro pupo.
Lo
investirono di poteri règi sino a parlamento convocato:
ma con a fianco un Costantino Nigra, figlio d'uno
spedaliero, fanciullone caro al Cavour; stato, dicevano,
mezzano de' segreti (anche di femmine) fra costui e
Napoleone III; bellimbusto inzuccherato dalla
massoneria, fatto segretario generale di stato, da stare
al di sopra dei consiglieri, della luogotenenza, e ogni
cosa.
Entrambi giunsero a mezzodì del 12 gennaio 1861 a
Napoli, ricevuti dai faziosi con grandi speranze, e col
consueto fornimento di dimostranti”.
 |
|
Costantino Nigro con Cavour sotto il
ritratto di Vittorio Emanuele II |
Fine dell’eccelso
341. “Il Farini fe' allora l'ultima comparsa; andò a
ricevere il successore, e il portò a palazzo, come a
cedergli la corona. Poi si ritirò a Portici, a smaltire
il veleno, benché avesse titolo e soldo di ministro; e
stéttesi in quella reggia sino a' 6 febbraio, quando
tornò in Piemonte, a Saluggia, dove avea comprato un
castello che, quando arrivava lui, alzava con fasto la
bandiera, vero trofeo di sue rapine.
Masaniello, due secoli prima, nelle grandezze impazzì;
similmente costui l'anno dopo uscì pazzo, e poi morì,
come il Voltaire, mangiando il suo sterco”.
Silvio Spaventa alla polizia
342. Anche col duo Carignano-Nigra, però, la situazione
rimaneva in pieno caos.
“A
Torino pensarono rimediare, con accentrare colà più le
cose, restringendo la potestà del Luogotenente, e
governando da lontano co' partigiani.
Un
decreto del 29 marzo 1861 die' ordini nuovi: alla
luogotenenza quattro dicasteri: 1°Interno e polizia; 2°
Grazia e giustizia; 3°Istruzione, agricoltura e
commercio; 4°Lavori pubblici e Finanze; tutti guidati
non più da Consiglieri, ma da Segretari generali,
ciascuno dipendente da' ministeri di Torino; ma …
scemata la dignità, restarono gli stessi i soldi.
Andò al primo Silvio Spaventa, al secondo Stanislao
Mancini, al terzo Paolo Emilio Imbriani, al quarto
Vittorio Sacchi; onde i Napolitani ripetevano in
canzone: -Lo spavento alla polizia, i sacchi alle
finanze”.
Silvio S(s)paventa
la camorra?
343. “Col Carignano incapace ed imbelle, e il Nigra
semplice spione, re vero fu lo Spaventa …
Successore e nemico di Don Liborio, temendone i seguaci,
fe’ l’opposto di lui e perseguitò i camorristi:
trovàtine vestiti da garibaldini, tenenti e capitani, li
rimandò in galera e nelle isole, eccetto chi si desse
a lui …
Usò peraltro precauzione, attese un pretesto,
un'infrazione qualunque alla disciplina stabilita.
L'aspettazione non fu lunga. Trovata l'occasione, fece
in una sola volta arrestare un centinaio di camorristi,
i più terribili, e gl'inviò alle isole”.
Contemporaneamente, abolì quella Polizia cittadina che
Don Liborio aveva farcito di camorristi, e le sostituì
una nuova Guardia di Pubblica Sicurezza già organata da
qualche tempo. Proibì, inoltre, ai componenti la Guardia
Nazionale, anch’essa inquinata, di portare la divisa
fuori dell’orario di servizio: cosa che veniva spesso
fatta, onde poter birboneggiare con legale autorità.
 |
|
Silvio Spaventa |
344. La Bella Società, che fino a quel momento era stata
alleata fedele e ben retribuita del partito liberale,
considerò gli atti di Spaventa come un vero e proprio
tradimento.
“Montate
su l'ire, quel mattino stesso, venerdì 26 aprile 1861,
tutti insieme, ufficiali e militi co' soliti
tumultuanti, corrono a' ministeri gridando: -Morte
allo Spaventa!
Gl'impiegati da' balconi chiamano soccorso, serrano le
porte; ma sforzate, lo Spaventa s'acquatta in uno stipo;
e in quella confusione viene fatto, a certi Piemontesi e
carabinieri, di trafugarlo, senza cappello, per segrete
scale, al real palazzo.
I
sediziosi, non trovato lui, si gìttano sul mobilio, che
fu rubato o guasto; si ripigliano i carcerati della
vigilia; e ingrossati fanno calca avanti la reggia.
Morte a Spaventa, a Cavour, a Cialdini, Viva Garibaldi
solo! e anche Mora Vittorio Emmanuele! si
gridò.
Poscia, per Toledo imperversando, incontrano in carrozza
Don Antonio Spinelli,
il già presidente e collega di Don Liborio, e présolo
per lo Spaventa bastonano lui e il cocchiere; e
l'ammazzavano, quando, avendolo riconosciuto, gli
chiedono scusa.
Poi, corsi a casa dello Spaventa (ch'era dello zio,
consigliere Croce, borboniano) l'assalgono, la
rovistano, vi fanno bottino, e rompono vetri e porte.
Indarno il generale Tupputi e altri metteano pace; la
folla, per plebe cresciuta a ventimila, ripresi i gessi
del Garibaldi e di Masaniello, strilla per via: Viva
chi? Rispondono:
- Garibaldi! E mora chi? Rispondono: -
Cavour, Cialdini, e talora anche Vittorio! …
Fini sull' imbrunire per istanchezza”.
Caduta dello Spaventa: troppe
virgole
345. L’integerrimo patriota Silvio Spaventa, però, …
“avendo mandato i camorristi all'isole, pure n'avea di
grossi a fianco a guardargli le spalle, ai quali ogni
eccesso, purché contro i borboniani, concedeva. Chi
voleva una vendetta, disegnava reazionario il nemico, e
se ne disfaceva”.
346. Anche il liberale Marc Monnier non può tacerlo:
“Per ultimo, i camorristi si dettero ad un mestiere anco
più immorale. Ho lungamente dubitato di quanto sto per
dire, ma fatti numerosi, eloquenti, me lo hanno provato
in tal modo, che non potrei più oltre negarlo: la setta
poneva una taglia sui borbonici, minacciando di
denunziarli alla polizia.
Quando un individuo era sospetto di tenerezza verso
l'antico regime, esso riceveva la visita di un
incognito, che gli diceva confidenzialmente: - Voi
correte grandi pericoli; il governo vigila su di voi: si
afferma che sostenete i preti e assoldate i briganti:
voi andrete in galera.
Lo sventurato, pallido dalla paura, supplicava il suo
misterioso visitatore di trarlo di impaccio. “Non havvi
che un mezzo per salvarvi” diceva l'agente della setta
“prendete un camorrista al vostro soldo, o comprate il
silenzio di quegli che vorrebbe denunziarvi”.
Allora il borbonico, che in realtà non avea corso alcun
pericolo, pagava una forte somma, credendosi liberato
dal bagno per la venalità del poliziotto, cui egli
credeva aver dato il suo danaro”.
347. “Di questi ribaldoni, Io Spaventa avea fatto un
comitato, detto Virgolatorio perché (essendo
Spaventa un letterato) chiamavano virgola la
mazza; il cui capo, un Demàta cappellaio,
minacciava, bastonava, e per pacifìche case andava
danari estorquendo, e taglie e ricatti.
Un
dì, chiese 1500 ducati a un barone; questi per salvarsi
ne pagò subito 700 e promise il resto la dimane; ma
ricorso all’autorità, ne seguì, senza saputa dello
Spaventa, l'arresto del Demàta da parte del commissario
Ferdinando Mele.
Costui, stato camorrista anch'esso, e anzi complice del
Demàta nell'uccisione che narrai dell'ispettore Perrelli,
a' 28 giugno dell'anno prima,
ora scordata la setta antica, lo agguantò.
348. Il Demàta aveva però un fratello, Salvatore,
condannato per assassinio, allora evaso di galera,
eppure fatto dallo Spaventa impiegato nelle poste,
che anche facea parte del virgolatorio comitato;
questi, stizzito del vedere il già collega carceratore
del fratello, si vendicò con una pugnalata a' 17 luglio
sull'ore quattro vespertine; ed il Mele, posto
boccheggiante in una carrozzella, come già la sua
vittima il Perrelli, Dio volle spirasse similmente pria
d'arrivare all'ospedale de' Pellegrini.
All’illustre salma si fe' il mortorio il 20 luglio 1861,
che movendo dall'ospedale onorò Pignasecca, Toledo, S.
Giacomo, Fontana Medina, Monteoliveto, e tornò dond'era
partito, con l'augusta presenza del Questore, de'
poliziotti, de' Nazionali, di molti impiegati, e di
lurida plebe. Lo Spaventa ebbe a segnare di sua mano, il
20 stesso, il decreto che alla vedova e a' tre orfani
dava 180 ducati di pensione all'anno.
349. Ma l'onta che gli cadeva addosso, per l’esistenza
di quel suo virgolatorio comitato, lo costrinse a
lasciare l'uffizio; e n'ebbe altro maggiore a Torino.
Prese quella sedia Filippo De Blasio.
Intanto la polizia, per avere nelle mani l’assassino
(Salvatore Demàta), tenuto ascoso dalla Camorra, si
chiamò i capi ch'aveano pure gradi nella Guardia
Nazionale, e minacciò li terrebbe per correi, se nol
consegnassero. Così, svelato da' suoi, fu colto a' 30
del mese in una casa al Sedile di Porto; si difese, ma
sanguinoso fu tratto al carcere. Subito confessò. Già a'
22 ottobre fu condannato a' lavori forzati”.
Caduto lo Spaventa, anche il questore Tafani fu
sostituito: e nuovo questore fu Carlo Aveta.
Il questore Carlo Aveta:
l’energico provvedimento
350. Fu Carlo Aveta, ben più di Silvio Spaventa, a
condurre una vera lotta a fondo contro la Bella Società.
E così, in data 23 settembre 1862, il Prefetto di Napoli
relazionava al Ministro dell’Interno:
“L’Eccellenza Vostra conosce appieno … come i
camorristi, stringendosi astutamente a quei partiti
politici che più sogliono concitarsi a baldanzose
pretenzioni, erano riusciti a imperversare ne’ trascorsi
giorni … con maggiori eccessi che mai.
Le entrate del governo erano sul pendio di una totale
ruina, pe’ continui contrabbandi che le incalzavano da
ogni dove; e le proprietà dei cittadini fatte segno ad
incessanti grassazioni, che minacciavano di scuotere
gravemente i più saldi ordinamenti della sicurezza
sociale.
Sicché si è dato
un energico provvedimento
che, senza transazioni, senza rilento di forme
giudiziarie, inadeguate a raggiungere i nuovi
imperversamenti di questo straordinario male sociale,
soggiogasse d’un colpo all’impèrio delle leggi la
ostinata pervicacia de’ camorristi …
Trecento dei più sfidati camorristi sono stati in pochi
giorni ridotti in carcere … e questo arresto, oltre al
plauso generale onde è stato circondato, porta dietro a
sé, quali documenti irrefragabili, i dazi triplicati, le
entrate della lotteria portate a tal cifra di cui finora
non si è avuto esempio, le aggressioni contro la
proprietà pressoché scomparse, il sentimento della
personale sicurtà pienamente rialzato dalla
prostrazione…”
Ma quale era questo
energico provvedimento,
di cui il Prefetto tace prudentemente la natura?
Nicola Jossa
351. Semplicemente, il questore Aveta aveva nominato
commissario di pubblica sicurezza tale
Nicola Jossa,
che già in precedenza si era segnalato per meriti
patriottici
ed aveva fatto parte della Guardia Nazionale.
Lo Jossa, pur vivendo di sopraffazioni, non era tuttavia
affiliato alla Bella Società Riformata: era, per così
dire, un “guappo sciolto” che, proprio per questo, aveva
con la Società antichi e continui motivi di rancore.
352. Rivestito ora di nuova autorità, non esitò a
sfidare personalmente lo stesso Capintesta
Tore ‘e Criscienzo:
si recò da solo al Ponte della Maddalena, laddove De
Crescenzo regnava indisturbato sulla dogana,
e lo sfidò ad una regolare
zumpàta:
se avesse vinto Jossa, il Ponte della Maddalena sarebbe
tornato allo Stato; se avesse vinto De Crescenzo,
sarebbe rimasto alla camorra.
Vinse Jossa “al primo sangue” (= una ferita al braccio
di De Crescenzo) e costui cavallerescamente disse: - Il
Ponte della Maddalena appartiene alla legge;
accompagnami al carcere. Da dove, sapeva, peraltro, che
avrebbe potuto continuare a regnare indisturbato sulla
Bella Società, anche facendo a meno del dazio doganale.
353. Ma, sconfitto il Capintesta, Nicola Jossa si diede
poi a scovare, ad uno ad uno, i capintrìti e tutti gli
altri più importanti esponenti della Bella Società, che
conosceva molto bene.
“Li fissava con occhi sprezzanti, li colpiva a
scudisciate sulle mani e urlava: - Avanti, vai verso il
carcere di Castelcapuano! Io ti seguo a due passi di
distanza …”
Tolti così i capi, furono presto raggiunti i 300
camorristi di cui alla relazione del Prefetto.
Una saggia proposta (inascoltata)
354. La quale relazione si concludeva con una proposta,
evidentemente suggerita dal Questore Aveta:
“Perché questi salutari benefizi non tornassero
effimeri; perché dalle prigioni medesime in cui sono
rinchiusi nel seno della città non si attentassero,
questi indomati camorristi, a qualche conato di
subbuglio e non fossero colà di subdolo incitamento ai
loro aderenti…
… sémbrami urgente partito che l’Eccellenza Vostra si
faccia a divisare, o nell’isola di Sardegna o altrove,
un
luogo separato
dove potessero sollecitamente
confinarsi
quelli tra essi che sono in fama del pubblico per più
accaniti macchinatori di camorra e che, avuto riguardo
alle varie volte in cui hanno richiamato l’attenzione
dell’autorità pubblica, è da ritenere che non potrebbero
ritornare in libertà senza darsi in balìa delle loro
inveterate ed incorreggibili tendenze.
355. Tramutati invece
sotto altro cielo
140 o 150 di questi detenuti, la coscienza pubblica
sarebbe rassicurata dal pericolo che potrebbe portar
seco la loro evasione o il loro confino in terra vicina;
un efficace esempio si offrirebbe agli occhi degli
altri; e dopo qualche tempo di permanenza
in lontane contrade,
non sarebbe vano lo sperare che i loro animi medesimi si
ritemprassero a sentimenti di obbedienza alla legge e di
soggezione alle autorità costituite; infine, non ultimo
vantaggio sarebbe quello di diradare le prigioni della
città …
Sicuro che tal proposta meriterà il suffragio della
Eccellenza Vostra, io mi aspetto al più presto le sue
istruzioni”.
Mai eccedere nello zelo
356. Il Prefetto, ed il Questore Aveta, attesero invano
le istruzioni dell’Eccellenza Ministro: della loro
proposta nulla si fece. Ed il
perché
lo conosce, a suo modo, lo stesso Marc Monnier:
“Tutti quei bravi dei mercati di Napoli, adesso non si
contentavano più di rubare pochi soldi ai sempliciotti:
erano addivenuti uomini politici.
Nelle elezioni proibivano tale o tal'altra
candidatura, confortando co' loro bastoni la
coscienza e la religione degli elettori.
Né si contentavano di inviare un deputato alla Camera,
e sorvegliarne da lungi la condotta; spiavano il suo
contegno, si facevano leggere i suoi discorsi, non
sapendo leggerli da sé medesimi. Quando non erano
contenti di lui, lo salutavano, al suo ritorno da
Torino, con un bestiale concerto di fischi e di grida,
che scoppiava la sera all'improvviso, sotto le finestre
della sua casa”.
357. In altri termini: con l’Italia unita e liberale, la
camorra era ormai diventata parte integrante dello
Stato, gli uomini politici locali e nazionali se ne
servivano e ne erano asserviti, in un rapporto di
reciproca convenienza, e pertanto non avevano alcuna
volontà né possibilità di lottare veramente contro di
essa; qualche azione dimostrativa ogni tanto, per
tranquillizzare l’opinione pubblica, era sufficiente; e
la proposta del prefetto e del questore dimostrava
pertanto uno zelo eccessivo.
I
camorristi dovevano bensì essere rinchiusi in carcere,
ma da lì poter continuare ad “esercitare”, ed uscirne
dopo non molto tempo … “In
tal guisa, persisté la camorra, sempre minacciosa”.
358. Nel caso specifico, l’unico a pagare fu proprio
Nicola Jossa che, dopo avere così ben servito lo Stato,
fu rinchiuso in una cella di segregazione, dove morì,
sembra, di tubercolosi.
Antonio Lubrano detto Totònno ‘a porta
‘e Massa
359. Un altro che fece assai brutta fine fu il
camorrista Antonio Lubrano, che abbiamo visto
spavaldamente accompagnare Vittorio Emanuele II nel suo
ingresso in Napoli.
Il Lubrano, ascritto alla Bella Società Riformata e
capintrìto della zona della Porta di Massa, si era
opposto nel 1849 alla nomina di Salvatore De Crescenzo a
capo della camorra cittadina.
Dopo di che, pur essendo a lui sottoposto secondo il
friéno, gli era sempre rimasto nemico: una sorta di
“oppositore interno”, che si rifiutava a volte persino
di fare i dovuti versamenti nella cassa comune della
Società.
Anche negli avvenimenti del 1860, siccome De Crescenzo
aveva platealmente sostenuto Garibaldi, lui volle invece
apparire vicino a Vittorio Emanuele.
360. Ma non poteva durare. Arrestato il 3 ottobre 1862,
nel carcere di Castelcapuano “tre detenuti gli si
gettarono addosso e lo scannarono”: il tribunale della
Gran Mamma, riunito nelle Caverne delle Fontanelle sotto
la presidenza di Salvatore De Crescenzo, lo aveva
condannato a morte e la sentenza era stata recapitata al
capintrìto temporaneo
di Castelcapuano, Antonio Mormino, nascosta in una cesta
d’uva che la moglie di un camorrista detenuto aveva
portato al marito in carcere.
Il capintesta (1869-1892) Francesco
(detto Ciccio) Cappuccio
361. Al ritorno dal consueto “pellegrinaggio” alla Madonna di
Montevergine, mentre stava mangiando in una trattoria
poco distante dal Santuario … “Reso euforico dal vino,
dichiarò ai suoi gregari che sarebbe stato capace di
mangiare un’intera zuppiera di baccalà. Vinse la
scommessa e centinaia di camorristi lo applaudirono. Lui
si alzò per ringraziare, balbettò qualche parola, poi si
abbatté con la testa sulla tavola imbandita, in preda a
un attacco cardiaco. Era il 5 dicembre 1892”.
Non ostante una morte così poco eroica, l’incauto
poeta Ferdinando Russo (1866-1927) se ne uscì,
quattro giorni dopo, con l’epico quanto inopportuno
lamento che segue, pubblicato su “Il Mattino” del 9
dicembre 1892, nel quale “l’eroe del baccalà” diventa
addirittura “il palatino Orlando”, difensore dei diritti
dei poveri, delle donne e dei bambini.
Canzone 'e Ciccio Cappuccio
Da ‘o Mercatiello a ‘o Bbùvero,
da Porto a lu Pennino
è corza ‘a voce sùbbeto:
«È mmuorto ‘o Signurino! »
Ciccio Cappuccio, ‘o princepo
d’ ‘e guappe ammartenate,
ha nchiuse ll’uocchie d’ àquela,
e sule nce ha lassate!
Scugnizze, cape–puòpole,
picciuòtte e cuntaiuòle,
chiagnite a ttante ‘e làcreme!
‘Ite perdute ‘o Sole!
Currite, belli fèmmene,
sciuglìteve ‘e capille,
purtàteve all’asèquie
‘e figlie piccirille!
Chi ve po’ cchiù difendere?
Senz’isso che ffacite?
A chi jate a ricorrere
si quacche tuorto avite?
Isso, sul’isso, era àbbele
a fa scuntà sti tuorte…
Mo’ chi po’ cchiù resistere?
Ciccio Cappuccio è mmuorte!
Russo, nquartato, giovane,
pareva justo Urlando
quann’ ‘o verive scennere
mmiezo San Ferdinando!
V’allicurdate ‘o sciopero?
Pare successo ajere!
Sull’isso dette ll’ordene,
e ascetteno ‘e cucchiere!
E quanno dint’ ‘e carcere
p’ ‘o fatto d’ ‘e turnise
isso avette che ddìcere
cu ‘e guappe calavrise!
–Tirate mano! Armateve!
Tenite core mpietto?
E n’abbattette dudece,
cu ‘e tavole d’ ‘o lietto!
Currite! Mo’ s’ ‘o portano!
Menatele ‘e cunfiette!
Sceppateve! Stracciateve
‘e core ‘a dinto ‘e piette!
Uommene nun ne nasceno
comm’a Cappuccio, ancora!
Ll’aute so’ buone a schiòvere,
isso vucava fora!
Va! Jàteve a fa muònece,
guappe quante nne site!
Cu Ciccio è muorto ‘o ggenio
d’ ‘e palatine ardite!
Picciuòtte e cape-puòpolo,
scugnizze e cuntaiuòle,
chiagnite a ttante ‘e lacreme,
‘ite perduto ‘o Sole!
%20Cappuccio.jpg) |
|
Francesco (detto Ciccio) Cappuccio |
Ferdinando Russo (1866-1927)
362. Ma chi era l’autore di questo esaltato elogio del
capo della camorra?
Il poeta Ferdinando Russo è, in effetti, un
caratteristico esponente della piccola borghesia
napoletana nel periodo liberale.
Figlio di un ufficiale del dazio, non portò a termine
gli studi, manifestando, da giovane, tumultuosi quanto
superficiali sentimenti repubblicani, presto sopìti.
Visse facendo il giornalista, l’autore di canzoni e di
macchiette, fino a che, su raccomandazione di Salvatore
Di Giacomo, che lo ebbe amico nonostante le divergenze
in materia letteraria, fu assunto come impiegato al
Museo Archeologico Nazionale.
 |
|
Ferdinando Russo |
363. Ebbe modo di incontrare “occasionalmente”, nel suo
celebre negozio di vrennaiuòlo a Piazza S.
Ferdinando, lo stesso Ciccio Cappuccio, che lo trattò
con simpatia e rispetto, accattivandosi la sua amicizia.
La sua conoscenza della organizzazione e delle vere
attività della Bella Società Riformata fu però alquanto
superficiale, limitandosi agli aspetti esteriori più
appariscenti, come si vede dal libro che scrisse insieme
all’altro giornalista Ernesto Serao: “La camorra -
Origini, usi, costumi e riti dell’annoràta soggietà”,
Ed. Bideri, 1907.
364. Grazie al Cappuccio, “si fece omme ‘e sciammèria
(una sorta di camorrista onorario) per potersi
introdurre indisturbato tra la gente dei fòndachi e
delle suburre, e poterla studiare al microscopio della
sua sensibilità di uomo prima che di poeta, e poterla
far rivivere … (quasi al modo di un antico
cantastorie del Molo) … trasfigurata in una nuova
èpica … di fatti di ordinaria e straordinaria
miseria … umana e dolorosa” (Luca Torre).
Non a caso, sia il romanziere verista francese
Emile Zola sia il poeta classicheggiante Giosuè
Carducci lo vollero come guida per visitare monumenti e
vicoli di Napoli.
365. Si sposò il 26 novembre 1902, a Bologna, con tale
Elisa Rosa Pennazzi, in arte Rosa Saxe, un’attricetta in
voga all’epoca, che gli era stata vicino durante una
grave malattia. I due, però, si separarono poco dopo. In
compenso, il Russo fu sempre un assiduo frequentatore
delle “case di tolleranza” cittadine.
Visse tutta la vita insieme alla madre e alla sorella,
che morirono a poca distanza di tempo l’una dall’altra,
nello stesso anno 1923. Quattro anni dopo (1927), morì
anche lui, di diabete, nella sua casa di Via Cagnazzi,
48 (Quartiere Stella).
366. Le sue opere più significative, anche per il loro
valore di ricostruzione storica, sono i poemetti ‘O
Luciano d’o rre (1910) e ‘O surdàto ‘e Gaeta
(1919) nonché gli importanti studi critici sul Cortese e
sul Velardiniello. Viene considerato l’inventore del
genere della “macchietta”. Sono sue anche alcune celebri
canzoni napoletane, come Scètate e Quanno
tramonta ‘o sole.
L’articolo de “Il Mattino”
367. A sua volta, l’allora direttore de “Il Mattino”
Edoardo Scarfoglio
(1860-1917)
aveva già pubblicato in grande evidenza sul suo
giornale, in data 6 dicembre 1892, il seguente
“sin-patico” necrologio dell’illustre defunto Ciccio
Cappuccio:
“La
notizia della sua morte ha messo, veramente, la
costernazione in quanti son napoletani che ricordano i
fasti della camorra di un tempo, i tipi più temuti e più
fieri di questi eroi del marciapiede che dànno ancora,
con la semplice loro presenza, entusiasmi così vergini e
così impetuosi ai piccoli palatini ed agli
aspiranti alla mala vita.
Ciccio Cappuccio, che da parecchi anni aveva
completamente abbandonate le comitive facinorose, che
viveva lontano da tutti i suoi compagni ed ammiratori
d’una volta, era pur sempre rispettato e temuto, e
conservava intatto il suo fatale prestigio di
capo-camorrista e di persona sprezzante di ogni
genere di pericolo.
Simpaticissimo, pieno di forme, rispettoso, ossequente,
egli s’ingegnava d’attenuare l’espressione fiera del suo
occhio grigio, con la dolcezza e la mansuetudine
dell’uomo che si sente forte e fermamente convinto che
nulla al mondo potrebbe opporsi alla sua volontà.
E
appunto questa fierezza e questa mansuetudine erano,
dirò così, la sua posa. Bastava solo una sguardo,
talvolta, per sedare una lite, per far tacere un
malcontento, per impartir un ordine.
368. Egli solo, quando i cocchieri scioperarono, bastò a
farli addivenire a più miti consigli. Lo aveva promesso
alle autorità, e si presentò il giorno appresso nelle
stalle, quando ancora gli animi erano esacerbati e
vibranti d’ira. Guagliù, mettìte sotto, e ascìte.
E queste parole, pronunziate piano, freddamente, a voce
bassa, con accento persuasivo, bastarono. Napoli riebbe
nuovamente le carrozzelle; circa 600 di esse uscirono
a ffatica’, quella mattina; lo sciopero finì.
Bisognava sentir parlare di lui e dei fatti che
contribuirono a dargli tutta l’aureola e il prestigio di
cui sempre ha goduto. Signo’, faceva cose belle! Era
‘o rre ‘e Napole! Appena compareva, tutte zitte! -
mi diceva un cocchiere, parlando di lui con le lacrime
agli occhi – Ha fatto cose, verìte, ca manco chelle
ca stanno scritte dint’ ‘e storie! E teneva core, ma ne
teneva assaie!
369. Come tutti i popolani agiati, egli si recava con la
sua donna alle festività più pompose; a Piedigrotta, a
Montevergine, alla festa (dei gigli) di Nola,
alla Madonna dell’Arco. La folla si fermava per
aspettarlo al passaggio e festeggiarlo; ed egli si
lasciava ammirare, e attraversava la via, guidando i
cavalli cammenatùre, distribuendo sorrisi a
destra e a sinistra con la sua aria bonacciona. Tutti
gli altri guidatori d’ ‘o lignàmmo gli facevano
largo e gli aprivano le fila lasciandogli sempre libera
e comoda la parte destra della strada.
E a
Nola - mi raccontavano - e dovunque, bastava che uno del
suo seguito si facesse al balcone, mentre nella piazza
illuminata echeggiavano i canti e scoppiavano le
bombe-carte, e accennasse, colla mano, chinandovi su la
testa, che Ciccio Cappuccio voleva dormire: i canti
rimanevano a mezzo, tacevano i venditori, si
sospendevano i suoni e ‘o ffuoco e la festa
finiva.
370. Sbaglia però chi crede che egli fosse un
sanguinario o un delinquente nato: di carattere
impetuoso e di ardito animo, fin da ragazzo, non si
lasciò mai sopraffare da alcuno: gli avevano inculcata
la religione d’ ‘o rispetto: l’ommo ha da
essere ommo!
Ed
egli lo dimostrò sempre, servendosi di tutti i mezzi che
credeva buoni. Il napoletano è impressionabile ed
entusiasta: ‘a guapparìa, l’atto di coraggio lo
incantano e lo esaltano: e quando Ciccio Cappuccio fu
mandato a domicilio coatto, tutti i suoi seguaci ed
ammiratori lo accompagnarono, nelle barche, rendendogli
onori, come ad un re.
E
quando, prima di questo fatto, giovanotto ancora, egli
fu condannato a sette anni di esilio per aver tagliata
la faccia al Direttore del lanificio Sava, che ebbe il
torto di trattarlo come un ragazzo, Signo’ –
continuò l’entusiasta suo amico che mi ha dato qualche
cenno sulla vita di lui – facette nu furore, ca ll’avarrìano
miso ncopp’ a nu tusello!
371. Ma quello che contribuì ad aumentargli il prestigio
di uomo coraggiosissimo, fu il combattimento - proprio
il combattimento - nelle carceri, contro dodici
camorristi calabresi. Egli solo, inerme, non volle
sopportare le imposizioni di quei compagni che il caso
gli aveva dato: si ribellò alle loro pretensioni, e
quando, meravigliati, i calabresi gli chiesero chi
fosse, ei rispose, fiero, afferrando una tavola del
letto: - So’ Ciccio Cappuccio! E li atterrò tutti
e dodici.
372. L’episodio che chiuse il periodo d’azione di
Ciccio Cappuccio, d’ ‘o signorino, come i
camorristi con gran rispetto lo chiamavano, fu quello
con tal Manlio Novi, detto Amalio ‘e Nola, che lo
aggredì, nella nota bottega di crusca e carrube a piazza
S. Ferdinando, per affari di donna: il proiettile sfiorò
i capelli al signorino.
Da
allora Ciccio Cappuccio dette un addio alla vita
avventurosa, e visse, tranquillo, nella leggenda, se
così si può dire: temuto e rispettato sempre, egli non
fece più parlare di sé; anzi era additato dalle autorità
come un esempio agl’irrequieti.
Lo
adoravano, e la sua morte, una morte quasi improvvisa,
ha fatto ai popolani di Napoli una profonda impressione.
Per oggi alle 10, gli si preparano splendide esequie”.
Gli intellettuali organici e l’immagine
della camorra
373. Da entrambi gli scritti sopra riportati, si può
agevolmente notare che, come ogni gruppo umano più o
meno organizzato, anche la Bella Società Riformata aveva
i suoi “intellettuali organici”: vi erano ovviamente i
contaiuòli che dovevano saper leggere, scrivere e
far di conto; ma vi erano anche i fiancheggiatori,
o perché co-interessati economicamente e nei reciproci
favoritismi, come il direttore de “Il Mattino” Edoardo
Scarfoglio, o per semplice vanità e moda letteraria,
come il poeta Ferdinando Russo.
In entrambi i casi, e al di là delle loro stesse intenzioni,
gli intellettuali organici provvedevano, di fatto, a
“curare l’immagine”. Che cosa fosse realmente la
Bella Società Riformata lo abbiamo sopra descritto; ma
l’immagine che essa voleva avere e
voleva dare di sé, era proprio quella che vediamo
nell’articolo de “Il Mattino” ed ancor più nella bella,
ma sciocca, canzone di Russo: una specie di fratellanza
di nobili “cavalieri palatini”, forti e coraggiosi,
impegnati a far rispettare la giustizia ed a raddrizzare
i torti subiti dalla povera gente … un’immagine
tanto falsa quanto pienamente integrata nell’ideologia
piccolo-borghese della napoletanità.
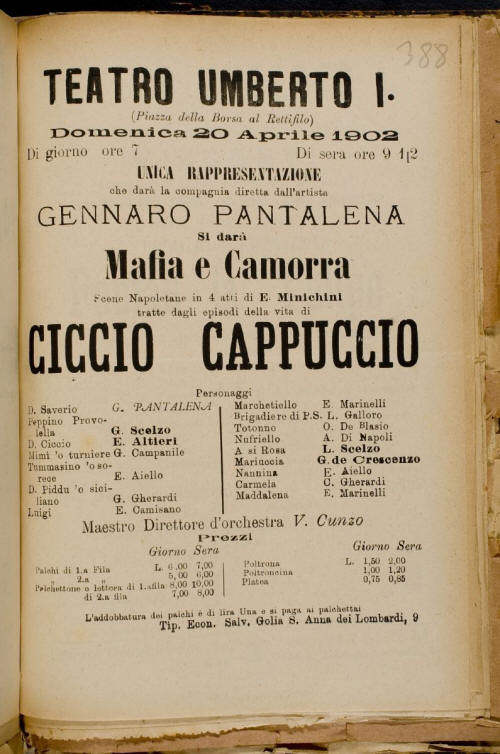 |
|
La vita di Ciccio Cappuccio 'romanzata' a
teatro nel 1902 |
La vera biografia di Ciccio
Cappuccio: le origini
374. Anche su Ciccio Cappuccio, già mentr’era ancora in vita,
cominciarono subito a circolare molte leggende
metropolitane, per cui risulta difficile, ma non
impossibile, ricostruire la sua vera biografia.
E’ certo, anzitutto, che le origini di colui che Ferdinando
Russo paragona al paladino Orlando erano tutt’altro che
nobili, provenendo egli dalla dinastia dei capi-zona
camorristi della Via dell’Imbrecciata fuori Porta
Capuana che era, per definizione, la zona del
meretricio.
 |
|
La Via dell'Imbrecciata nell'Ottocento |
375. Abbiamo, in altro luogo, accennato
alla vasta diffusione del meretricio nella Napoli del
Trecento, ed ai nobili quanto inadeguati sforzi della
Regina Sancia, seconda moglie del Re Roberto d’Angiò,
per cercare di arginare tale doloroso fenomeno; ma,
naturalmente, esso esisteva da ben prima del Trecento e
continua ad esistere ben oltre quel secolo.
Nel Settecento, a combattere contro “l’universal meretricio”
troviamo il beato Gennaro Maria Sarnelli (1702-1744),
amico personale di S. Alfonso Maria de’ Liguori nonché
“redentorista” cioè appartenente all’Ordine religioso da
questi fondato.
Don Gennaro Sarnelli, il “redentorista”
delle meretrici
376. Ordinato sacerdote l’8 luglio del 1732, Don Gennaro fu
assegnato dal Card. Pignatelli alla Direzione della
Istruzione Religiosa nella Parrocchia dei SS. Francesco
e Matteo, ai Quartieri Spagnoli.
“Sopra i Quartieri”, lui che era di origini aristocratiche,
figlio del Barone di Cioràni, e nato nel signorile
palazzo Zapàta, a poca distanza dalla Reggia, ebbe modo
di venire in contatto con la triste realtà del
meretricio sempre dilagante.
377. Ecco come ne parla lo stesso S. Alfonso nella sua
biografia del Sarnelli:
“Circa poi le donne pubbliche, è ben noto in Napoli quel che
fece questo zelante Operario per toglierle dal peccato.
Andava, ogni giorno di festa, alla parrocchia di S. Matteo a
predicare, a fine di ricondurre queste misere a
penitenza. E fu egli che indusse la Congregazione
dell’Arcivescovado a dare a questo fine, ogni anno, gli
Esercizi spirituali in quella Parrocchia.
378. Egli, poi, per aiutare queste povere donne perdute a
sostenersi, non si riserbava niente di quanto avea da
casa sua, fino ad andare tutto làcero per Napoli, come
si è detto.
Ne manteneva molte a sue spese, contribuendo a ciascuna di
loro un certo sussidio al mese, acciocché si astenessero
dal vendere l’onore e le anime loro. E non solo
procurava di aiutare quelle che gli si presentavano, ma
andava girando attorno, e spiando per Napoli, dove fosse
alcuna di loro, per salvarla dal peccato.
Di queste, sedici ne collocò in Conservatorj, molte ne collocò
in matrimonio, due specialmente le mantenne per due
anni, e poi le collocò provvedendole di letto e di
utensili di casa.
E poiché alla spesa grande, che in ciò vi bisognava, egli non
poteva arrivare col suo livello, e tra lo spazio di
pochi anni, a questa sola opera, vi spese da 500 a 600
ducati … andava perciò in cercando limosine per tutto
Napoli, non solo per gli luoghi pii, ma anche per le
case particolari, con tanta ripugnanza ch’egli poi
diceva sentirsi morire per lo rossore, avendo dovuto, in
far quest’ufficio, patire non solo incomodi immensi nel
replicare le visite, ma anche rimproveri ed ingiurie:
confidò egli ad un amico che alcuni, i quali prima lo
stimavano e gradivano, quando poi lo vedevano, lo
fuggivano o licenziavano con mali termini”.
 |
|
Don Gennaro Maria Sarnelli apostolo delle
meretrici |
Le meretrici, tutte insieme, fuori dalla
città (4 maggio 1738)
379. “Specialmente, furono indicibili le fatiche e
persecuzioni che soffrì nella grande impresa ch’egli si
addossò, a fine di ridurre ad abitare le meretrici fuori
della città di Napoli, a luoghi separati.
Considerando il nostro Don Gennaro che, stando queste donne
infami disperse ne’ quartieri della città, come in
quelli dove prima stavano, sopra Toledo, alla Duchesca,
ed altri che sono i più popolati, davano uno scandalo
immenso, così ai vicini come a coloro che passavano per
le strade, pensò che non vi era altro modo di
riparare a questo gran male che ridurle ad abitare tutte
insieme fuori della città.
Per giungere al compimento di quest’opera, sa Iddio e tutta
Napoli le gran fatiche e spese che fece, stampando più
libri a posta sotto il titolo di “Alfonso del
meretricio”.
Patì, di più, per questa intrapresa, persecuzioni e
rimproveri, così dai nemici come da amici, i quali,
stimando impossibile a lui l’ottenere la buona riuscita
di questa impresa, lo sconsigliavano o deridevano.
Ma egli, sempre forte colla confidenza in Dio, solo e senza
appoggi umani, tanto si adoperò co’ Ministri principali
del Re nostro Padrone (Carlo III di Borbone), che
finalmente arrivò ad aver la consolazione di vedere
adempito il suo desiderio.
380. Essendo uscito un Dispaccio di nove capi, spedito al
Signor Duca di Giovinazzo, Reggente allora della
Vicarìa, in vigor di esso si pubblicarono poi i Bandi,
al 4 di maggio 1738, che tutte le meretrici uscissero
dalla città ed andassero ad abitare ne’ luoghi loro
stabiliti. E l’ordine reale si eseguì con tanto rigore
che a quelle donnacce le quali resisterono a partirsi
dalle loro case, furono buttate le robe dalle finestre.
E con ciò furono discacciate dalla città di Napoli da 30 a 40
mila meretrici (!!): delle quali, parte se ne
collocarono in matrimonio, parte se ne chiusero ne’
Conservatorj, e l’altre si ritirarono ne’ luoghi
assegnati, oppure se ne fuggirono altrove.
381. Ma, per questo affare, il nostro Don Gennaro passò più
volte pericolo della vita, e d’essere ucciso dagli
Amanti di quelle infelici.
E perciò i suoi nobili parenti non desistevano di impedirlo,
per timore di qualche aggravio che venisse fatto a lui,
ed in conseguenza a tutta la loro famiglia; ma egli si
protestava che era pronto a patire ogni affronto, e che
si sarebbe ritenuto fortunato se, per questa opera di
tanta gloria di Dio, avesse perduta anche la vita …
Oltre il mentovato libro contro l’abuso del meretricio per la
città di Napoli, ne stampò un altro per tutte le Città e
Terre del Regno,
“Ragioni cattoliche, legali e politiche, in difesa delle
città rovinate dall'insolentito meretricio”,
dove dimostrò che, in queste Terre e picciole Città, era
del tutto interdetto il permettere le meretrici: e
questo libro lo mandò a tutti i Vescovi del Regno…”
Dopo il Sarnelli
382. Il Sarnelli, come si vede, intendeva promuovere una vera
e propria mobilitazione generale di tutta la società,
per chiudere definitivamente la “piaga sanguinante”
della prostituzione, fornendo alle meretrici tutti gli
aiuti, morali e materiali, necessari per abbandonare “il
mestiere”.
Purtroppo, i suoi nobili sforzi non ebbero, alla lunga,
miglior fortuna di quelli della Regina Sancia quattro
secoli prima. Venuto egli a morte nel 1744, all’età di
soli 42 anni, le pubbliche autorità insistettero solo
sul lato “coercitivo” del suo programma.
383. Un Editto del 1781 concentrò tutte le case di tolleranza
alla Via dell’Imbrecciata fuori Porta Capuana; ed in
seguito, nel 1855, venne addirittura costruito un muro
con un cancello ben sorvegliato da custodi, che
impedivano alle meretrici di uscire dall’Imbrecciata
durante il giorno e chiudevano il cancello alle 11.30 di
sera: si creò dunque un vero e proprio “ghetto delle
prostitute”.
La camorra sul meretrici
384. “E lì, nella strada più lurida e più malfamata di Napoli,
in cui la rapina, l’accoltellamento e l’omicidio erano
all’ordine del giorno, il capo-paranza della camorra
rappresentava l’unica vera autorità, rispettata da tutti
e da tutti ossequiata.
Proprietari di immobili, tenutarie di postriboli, ricottàri,
ma anche bettolieri e venditori ambulanti, gli
versavano, ogni giorno, le dovute tangenti.
In cambio, lui provvedeva al mantenimento dell’ordine e al
componimento delle liti, nonché all’intimidazione di
quei privati cittadini che, essendosi addentrati in una
casa di tolleranza”
… mostrassero pretese ritenute eccessive o volessero
addirittura sottrarsi al pagamento.
La dinastia Cappuccio
385. Il ruolo di capo-paranza dell’Imbrecciata venne svolto,
fin dall’inizio, da un Leopoldo Cappuccio, fondatore di
una vera e propria dinastia, che regnò da allora
indisturbata, e le cui vicende sono state in seguito
ricostruite, per quanto possibile, dal medico e
criminologo, di Guardia Sanframondi, Abele De Blasio
(1858-1945):
1)
Leopoldo Cappuccio (1756-1784) fu ucciso a coltellate
dal nipote Antonio, che volle prendere il suo posto dopo
che l’Editto del 1781 aveva enormemente aumentato i
guadagni;
2)
Antonio Cappuccio (1784 – 1803), dopo circa 20 anni di
regno, morì senza figli, per cui gli succedette il
primogenito del fratello;
3)
Francesco Cappuccio (1803-1805), detto “Ciccillo
Tagliarella” perché aveva il volto molteplicemente
sfregiato, finì all’ergastolo per omicidio dopo solo due
anni di regno e lasciò il posto a suo fratello;
4)
Ferdinando Cappuccio (1805-1817);
5)
Antonio Cappuccio (1817 - ?), figlio di Ferdinando,
essendosi gravemente ammalato, abdicò anch’egli a favore
di suo fratello;
6)
Gabriele Cappuccio (? - 1826), fratello del precedente,
detto ‘a signurina per i suoi modi gentili e ben
educati, fu molto probabilmente colui che partecipò,
come capo-zona dell’Imbrecciata, alla fondazione
ufficiale della Bella Società Riformata, avvenuta nel
dicembre 1820 proprio nella chiesa di S. Caterina a
Formiello, che si trova poco distante dalla zona di sua
pertinenza.
7)
Giovanni Cappuccio (1826 – 1838), figlio di ‘a
signurina, gli succedette per circa un altro
decennio;
8)
Salvatore Cappuccio (1838 – 1853), figlio del
precedente;
9)
Francesco “Ciccio” Cappuccio (1853 – 1869), figlio di
Salvatore, lasciò il posto a suo fratello nel 1869,
perché in quell’anno venne eletto Capintesta di tutta la
camorra cittadina;
10)
Antonio Cappuccio (1869 – 1880), fratello di Ciccio,
abdicò pubblicamente nel 1880, perché il posto ormai non
era più remunerativo: a partire dal 1876, infatti, in
omaggio ai nuovi princìpi liberali, venne
definitivamente abolito l’Editto di circa un secolo
prima (1781) per cui la prostituzione poté “liberamente”
esercitarsi, come un tempo, non più solo all’Imbrecciata
ma in qualsiasi parte della città.
386. Come si vede, dunque, il nostro Ciccio Cappuccio,
IX della dinastia, era “figlio d’arte” ed entrò a far
parte della Bella Società a titolo, per così dire,
“ereditario” e non per particolari gesta di coraggio o
di forza, come in seguito si favoleggiò.
E’ quasi certo, anzi, che fu lo stesso suo predecessore
come capo della Società, Salvatore De Crescenzo detto
Tore ‘e Criscienzo, fàttosi ormai anziano, a
spingere il consiglio dei capintriti, ed i capintriti
temporanei delle carceri, a riconoscerlo quale
Capintesta al suo posto, nel 1869.
%20da%20anziano.jpg) |
|
Salvatore De Crescenzo (Tore 'e
Criscienzo) da anziano |
Ciccio nel Risorgimento italiano
387. Del resto, già in precedenza, quando era ancora
soltanto il capo-zona dell’Imbrecciata, il Nostro aveva
svolto un ruolo decisivo negli avvenimenti che portarono
alla trionfale entrata di Giuseppe Garibaldi in Napoli
il 7 settembre del 1860.
Infatti, sotto comando dell’allora Capintesta Tore ‘e
Criscienzo, che gli pre-pose per l’occorrenza sua
cugina Marianna la Sangiovannara, fu Ciccio
Cappuccio che organizzò, dall’Imbrecciata, la chiorma
delle sue “protette”, prospettando loro il
liberalissimo obiettivo di abbattere quel muro che
dal 1855 le teneva del tutto recluse.
388. “Ciccio Cappuccio si mise alla testa di uno strano
corteo di indemoniate le quali, nel giro di poche ore,
non solo abbatterono il muro, ma si spinsero fin sotto
il vicino carcere di S. Francesco prendendolo d’assalto
e cercando di far evadere i detenuti”.
Rosso-vestite e sventolando bandiera tricolore,
abbatterono dunque il muro del “ghetto” ed uscirono per
le strade inneggiando a Garibaldi.
Lo abbatterono, il muro, una prima volta durante i
tumulti del 27-28 giugno 1860 ma fu subito ricostruito;
lo abbatterono una seconda volta nella notte fra il 27 e
il 28 agosto 1860, quando anche Ciccio, come altri
camorristi, era ormai entrato a far parte della Guardia
Nazionale, che aveva in pratica il controllo della
città; e con l’arrivo di Garibaldi il 7 settembre, del
muro non si parlò più, ma …
389. Ma, fatto il 21 ottobre il plebiscito per
l’annessione, il 7 novembre arrivò in Napoli il nuovo Re
d’Italia, Vittorio Emanuele II, che rispedì l’ormai
inutile Garibaldi nella sua isoletta di Caprera, ed
anche la “forza d’urto” delle meretrici durante le
manifestazioni “liberali” ormai non serviva più.
“Il 18 novembre 1860, il nuovo Eletto di sezione,
Francesco Quarto duca di Belgioioso, convocò il
capo-paranza Ciccio Cappuccio e, a nome del Governo,
minacciò di punirlo con il domicilio coatto se fosse
stato ancora impedito ai muratori di eseguire il
restauro del muro”.
390. E così, quella stessa mattina del 18 novembre, il
Nostro “ardito paladino Orlando”, per non perdere il suo
comodissimo feudo e le relative entrate di rendita,
“salì su una botte, piazzata proprio al centro
dell’Imbrecciata, e disse: - Padrone di casa, metrésse e
puttane! Vi raccomando, se vengono i fabbricatori a fare
un’altra volta il muro, di non fare rimostranze o
chiasso di qualunque specie, perché se la polizia manda
in galera qualcuno per colpa vostra, chi ha colpa dovrà
vedersela con me”.
E così pure, successivamente (30 luglio 1861), il
Cappuccio fu uno dei capintrìti che consegnarono alla
Polizia il camorrista Salvatore Demàta.
Ciccio il capintesta
391. Divenuto dunque capintesta nel 1869, lasciò
l’Imbrecciata e le meretrici a suo fratello Antonio e
andò ad abitare in un appartamento di Via Nardones; poco
distante, in piazza S. Ferdinando, proprio accanto alla
chiesa, aprì un negozio da vrennaiuòlo (=
venditore di crusca e carrube per cavalli).
Questo mestiere di copertura, in verità ereditato
anch’esso dal suo predecessore Tore ‘e Criscienzo,
era conforme a quella che divenne da allora la sua
attività principale e nella quale raggiunse il monopolio
in tutta la città: riscuotere lo sbruffo da
cocchieri e stallieri, dalla compra-vendita di cavalli,
e naturalmente dagli altri vrennaiuòli.
All’occorrenza, poteva anche prestare denaro ai suoi
“protetti”, ad un tasso di interesse che, per quanto
esoso, era tuttavia più basso di quello che praticavano
ordinariamente gli usurai; ciò spiega, in parte, la
popolarità e la fama di uomo “di cuore” di cui godeva
presso i cocchieri.
Ciccio e la donna d’altri
392. Come amante e domestica, nella sua nuova casa di Via
Nardones, si prese la moglie di un altro: si presentò un
giorno in Vico Sergente Maggiore, davanti al “basso” in
cui viveva un ladruncolo chiamato Tore ‘o
schiavuttiello e, spalleggiato da altri quattro
camorristi armati di coltello, gli intimò davanti a
tutti: - Voglio tua moglie! Messo così
eroicamente in fuga il povero schiavuttiello,
andò subito a coricarsi con la di lui moglie, dopo di
che se la portò in Via Nardones, non solo con tutti i
suoi effetti personali, ma anche con tutto ciò che, di
utile, poté trovare nel basso.
Ciccio e le pubbliche istituzioni
393. Se, con Tore ‘e Criscienzo, la Bella Società aveva
partecipato alla conquista del potere da parte
della classe borghese napoletana, con Ciccio
Cappuccio cominciò a partecipare organicamente e
stabilmente all’esercizio di tale potere,
divenendo essa stessa un’istituzione quasi ufficiale
dello Stato italiano, non solo a Napoli.
Il nostro Ciccio fu protetto e vezzeggiato da “imprenditori”,
giornalisti e politici, locali e nazionali, in quanto
procacciatore di voti, di protezione negli affari
privati, e di agevolazioni negli affari legati agli
appalti pubblici.
Mantenne rapporti permanenti con il Prefetto ed il Questore,
che chiudevano entrambi gli occhi sulle attività
estorsive della Bella Società: in cambio, questa non
infastidiva “le persone perbene” dei quartieri alti e
teneva sotto controllo la plebe, contribuendo così alla
gestione dell’ordine pubblico in città.
394. E fu, quasi certamente, su diretto consiglio della
Polizia che il Capintesta introdusse anche alcune
significative variazioni alle regole della Bella
Società.
Anzitutto: “Avvenendo divisioni di partiti fra camorristi e
camorristi, qualunque affiliato può mostrarsi neutrale,
senza lèdere alcun diritto”.
In altri termini: quando due camorristi si fossero
trovati in disaccordo, avrebbero dovuto sbrigarsela fra
di loro, senza coinvolgere altri.
Questa nuova regola chiaramente “mirava a ridurre il numero
dei dichiaramenti che ormai si svolgevano in
continuazione nelle strade di Napoli e a cui
partecipavano decine e decine di camorristi, non solo
uccidendosi a vicenda ma anche mettendo a repentaglio la
vita dei passanti”.
Inoltre, i camorristi più importanti, ancorché notoriamente
oziosi parassiti, dovevano avere, come lui, un normale e
rispettabile mestiere di copertura.
395. Queste novità, ed altre minori, generarono
comprensibilmente molte discussioni nell’àmbito del
Consiglio dei capintrìti: lui però non cedette ed anzi,
nei primi mesi del 1874, operò una sorta di colpo di
stato, sostituendo molti capintrìti, regolarmente
eletti, con altri nominati da lui. Fino a che …
L’attentato a Ciccio Cappuccio
396. Il 23 aprile 1874, un giovane uomo entrò nella bottega di
Ciccio Cappuccio e gli sparò alcuni colpi di pistola,
uno dei quali lo sfiorò tra i capelli; l’attentatore
venne poi arrestato dalla Polizia.
Abbiamo riferito
come “Il Mattino”, nel 1892, raccontò la storia
dell’attentato. Ma altri autori, sia antichi (Serao,
Consiglio, etc.) sia moderni (Di Fiore, Paliotti, etc.),
l’hanno raccontata in modi diversi.
397. Tutto ben ponderato, sembra a chi scrive che la vicenda
possa ricostruirsi come segue.
Le innovazioni apportate dal Nostro alle regole della Bella
Società, ed ancor più le “epurazioni” da lui effettuate,
provocarono certo molti risentimenti nei suoi confronti
all’interno dell’organizzazione, ed il dissenso tendeva
ad allargarsi a tutta la “politica”, da lui seguita, di
sostanziale collaborazione con le istituzioni dello
Stato. Ma chi avrebbe mai osato fare qualcosa contro
Ciccio Cappuccio?
398. I dissidenti trovarono la persona giusta, che non si
chiamava
“Manlio Novi, detto Amalio ‘e Nola”, come scrisse
poi “Il Mattino”, bensì
Manlio Nolli, il cui nome era gergalmente storpiato in
‘O malo ‘e Nola.
Non era uno qualsiasi: la famiglia Nolli era una famiglia
aristocratica. In particolare, Rodrigo Nolli
(1826-1875), barone di Tollo (Provincia di Chieti, in
Abruzzo), allora vivente, era un ex funzionario
borbonico poi transitato, come tanti altri, nel nuovo
regime liberale, anche perché amico e co-regionale di
Silvio Spaventa. Era stato deputato al parlamento
italiano con la Destra liberale, dal 1861 al 1863, e poi
anche Sindaco di Napoli (dal settembre 1865 al novembre
1866). Nel 1870, risulta essere fra i governatori del
Pio Monte della Misericordia.
399. Il “giovin signore” Nolli, dunque, nelle sue giovanili
bisbocce, fra gioco, scommesse, alcool, cavalli, donnine
allegre e gozzoviglie varie, era venuto in contatto con
camorristi, soprattutto del quartiere Montecalvario.
A quanto pare, inoltre, si era addirittura urtato con Ciccio
Cappuccio “per affari di donna”: si sa che il Nostro non
andava tanto per il sottile sull’argomento,
ma il ricco e ben imparentato Nolli, da parte sua, non
era certo così remissivo come il povero Tore ‘o
schiavuttiello.
Lui, il Nolli, aspettava dunque l’occasione giusta per
vendicarsi, e loro, i dissidenti, fecero in modo (cosa
altrimenti impensabile) che potesse trovarsi, da solo e
con una pistola in tasca, a tu per tu con Ciccio … “nella
nota bottega di crusca e carrube a piazza S.
Ferdinando”.
Dopo l’attentato
400. Manlio Nolli, dopo aver niente di meno che attentato alla
vita del Capintesta della Bella Società Riformata, non
subì alcuna ritorsione: “a norma di regola”, per un
fatto del genere, si veniva prontamente ammazzati.
Evidentemente, i nobili parenti, dopo l’arresto, provvidero a
mettere il giovanotto al sicuro, sia dai rigori della
legge sia da quelli della camorra. D’altronde, lo stesso
Ciccio comprese probabilmente di non aver alcun
interesse a mettersi contro persone così autorevoli.
401. In ogni caso, certamente non è vero che, dopo
l’attentato, il Cappuccio “dette
un addio alla vita avventurosa, e visse tranquillo …
abbandonando le compagnie facinorose” come scrisse poi
“Il Mattino”; al contrario, l’episodio avvenne, come
detto, nel 1874 cioè dopo solo 5 anni dalla sua elezione
a Capintesta nel 1869: era dunque appena all’inizio
della sua attività in quel ruolo; e l’attentato
contribuì anzi, indirettamente, a consolidare la sua
posizione al vertice della Società.
Infatti, pochi giorni dopo, il Nostro organizzò un
pellegrinaggio straordinario di ringraziamento, di tutta
la Bella Società, alla Madonna di Montevergine; e
davanti al Santuario, nonostante la leggera balbuzie,
fece anche lui il suo plebiscito: - Chiedo a tutti i qui
presenti, indipendentemente dal loro grado: mi volete
come vostro capintesta, sì o no? E proprio
come all’altro più celebre plebiscito, tutti risposero,
ad una voce, di sì.
402. Da quel momento, furono abolite le votazioni interne alla
Bella Società e lui ne divenne il sovrano assoluto, con
la sola collaborazione di due suoi luogotenenti, che si
chiamavano Ettore Longo e Gaetano Buongiorno.
Prudentemente, comunque, da allora indossò sempre,
“sotto gli indumenti, una speciale maglia di acciaio,
fabbricata appositamente per lui da un armaiolo di Via
Santa Brigida”
…
Ciccio: “cane da guardia” della classe
dominante
403. “Ignoti ladri penetrarono, al Ponte di Chiaia,
nell’appartamento di Giovanni Nicotera, allora Ministro
dell’interno, ed asportarono un artistico orologio
d’oro. Risultate vane le indagini della Pubblica
Sicurezza, la moglie del Ministro, marchesa
Nicotera-Ricci, non esitò a rivolgersi a Ciccio
Cappuccio: l’oggetto le fu restituito la sera stessa”.
“L’esempio della gentildonna venne seguito dal
Procuratore del Re Michele Pironti, il quale,
alleggerito di una tabacchiera d’oro nell’aula delle
udienze, preferì chiedere direttamente l’aiuto di Ciccio
Cappuccio, con esito naturalmente positivo”.
Questi episodi, fin d’allora assai celebri, sono come
delle “illustrazioni per aneddoti” della “linea di
governo” della Bella Società seguita costantemente, ed
ancor più dopo l’attentato, da Ciccio Cappuccio.
Ma
ancor più significativo, al riguardo, è l’episodio
riguardante il camorrista Luigi Soreca detto Pasquino.
Ciccio, Pasquino e … una “Molto
Importante Personalità”
404. “Giovane, alto, snello, biondo, Luigi Sòreca, detto
Pasquino, aveva conquistato, col suo sguardo
trasognato, il cuore di moltissime donne, e perfino di
alcune dame dei salotti borghesi perbene. Inflessibile
nell’esigere le tangenti per conto della Bella Società
Riformata, Pasquino si comportava invece da
perfetto gentiluomo con signore e signorine. Talvolta,
di domenica, sulla passeggiata di Via Caracciolo,
interveniva per difendere le ragazze della borghesia da
corteggiatori troppo molesti, e finiva per diventare a
sua volta oggetto delle loro attenzioni … Nel 1884,
aveva fatto innamorare perdutamente di sé Matilde
Farranche, una bellissima chanteuse che, nel
passato, aveva tenuto ai suoi piedi principi e
milionari”.
405. Purtroppo per lui, però, si spinse troppo in alto nelle
sue avventure galanti, cominciando ad intrattenere una
relazione con una certa Elvira, detta la Francese,
bellissima vedova di un ricco avvocato.
Dopo la prematura morte del coniuge, “la donna viveva, tutta
sola, in un elegante appartamento alla Riviera di Chiaia
ed era ufficialmente la mantenuta di un commerciante
granaio di Gragnano, un certo Tartarone”.
Ma diceva la vox populi che forse Tartarone era
soltanto l’uomo di copertura di qualche altro
personaggio, vero amante della donna, che era
un’importante personalità della politica e che viveva
fra Napoli e Roma.
406. Sta di fatto che, la mattina del 29 settembre 1885,
mentre Luigi Soreca si trovava in una sala da biliardo
in Via Foria, venne affrontato da un altro camorrista,
tale Alfonso Viscardi, che ostentatamente lo derise e lo
sfidò ad una zumpàta.
Recàtisi insieme in carrozzella al Corso Vittorio Emanuele,
nei pressi del ristorante “Pastafina”, il Viscardi colpì
a tradimento Pasquino con una sbarra di ferro in
testa, ed immediatamente sopraggiunsero altre due
persone, poi identificate come certi Ferrucci e
Affaitati, che lo finirono a colpi di rivoltella: venne
rinvenuto poco dopo, da una pattuglia della Polizia, su
un marciapiede del Corso Vittorio Emanuele.
Le indagini della Polizia accertarono quasi subito i nomi
degli esecutori materiali del delitto, da noi sopra
riferiti, ma non pervennero mai ad identificare gli
eventuali mandanti.
407. L’ipotesi più plausibile è che “quell’importante
personalità della politica, vero amante della donna”,
offeso ed infastidito dalla relazione che Pasquino aveva
cominciato ad intrattenere con lei, si sia rivolto a
Ciccio Cappuccio, capo assoluto della Bella Società, per
avere soddisfazione; e che il Nostro abbia prontamente
ordinato l’uccisione di Pasquino, incaricando
all’uopo, come era consuetudine, proprio un importante
camorrista notoriamente amico di Pasquino, e cioè
Giovanni Rapi, detto ‘o maestro perché
come mestiere di copertura insegnava nella scuola
elementare “San Francesco” di Porta Capuana; e che
questi, a sua volta, abbia affidato l’esecuzione
materiale del delitto ai tre picciotti onorati
Viscardi, Ferrucci ed Affaitati.
Comunque, subito dopo l’omicidio, il maestro Giovanni Rapi
fuggì in Francia e della bella vedova Elvira si persero
completamente le tracce: nessuno dei due figurò nel
rapporto consegnato il 23 aprile del 1886 dal Questore
Pennino alla Magistratura.
Il maestro Rapi ritornò poi a Napoli nel 1902, espulso dalla
Francia con l’imputazione di aver organizzato una casa
da gioco clandestina.
Ciccio e lo sciopero
408. Il Nostro, invece, continuò fino alla fine nel suo
servizio di “cane da guardia” per conto delle
Istituzioni e della classe liberale borghese,
“mantenendo al suo posto” la marmaglia perché non
infastidisse troppo i signori.
L’episodio più importante, a conferma di ciò, è il ruolo
da lui svolto in occasione dello sciopero dei cocchieri:
proprio
mentre la plebe napoletana, soprattutto grazie al
diffondersi delle nuove idee repubblicane, anarchiche,
socialiste, etc. cominciava appena ad assumere
una coscienza di classe e ad organizzarsi per richiedere
migliori condizioni di lavoro e di vita per tutti, la
Bella Società Riformata interveniva, come braccio forte
dello Stato “liberale” borghese, per reprimere e
stroncare sul nascere queste “pericolose” novità.
continua
Giuseppe Bandi -
"I mille da Genova a Capua", Ed. Salani,
Firenze, 1903.


.jpg)


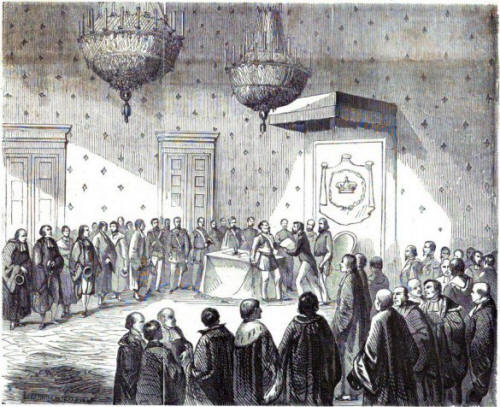
%20primo%20luogo-tenente%20generale%20dei%20territori%20napoletani.jpg)


%20Cappuccio.jpg)

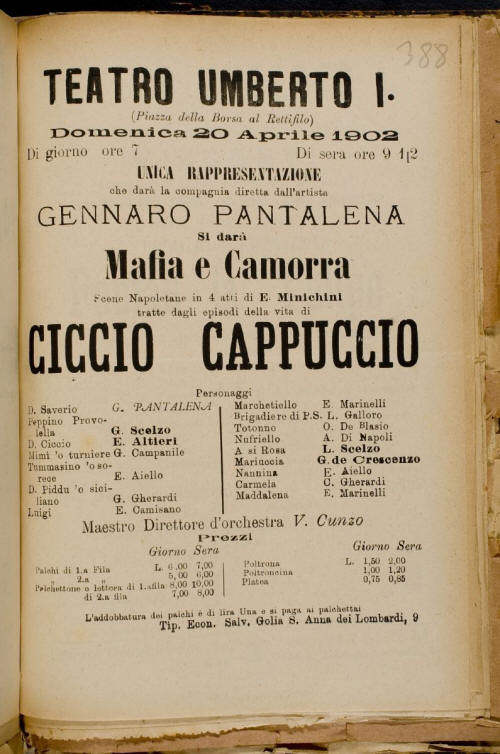


%20da%20anziano.jpg)