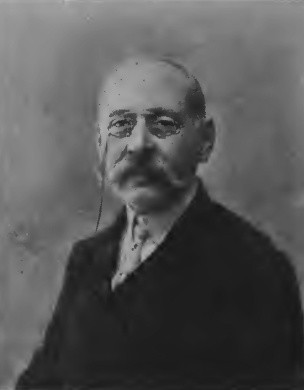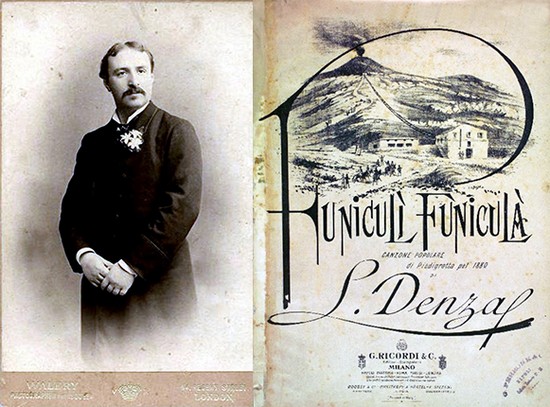vai alla pagina precedente
La “napoletanità” come
ideologia
273. E proprio così, toccando
la duplice nota “sensibile ed universale” dell’amore
e della natura, gli intellettuali organici della
piccola borghesia napoletana inventarono la cosiddetta
“napoletanità” come vera e propria “ideologia” del ceto
medio borghese dopo l’unità d’Italia, attraverso la
quale esso realizzò la sua “egemonia culturale” sulla
plebe.
L’ideologia della “napoletanità”,
da una parte, era un nostalgico e vacuo surrogato
della perduta indipendenza politica, economica e
culturale; dall’altra parte, era un formidabile
collante inter-classista che “annebbiava” le menti e
rendeva ancor più difficile una lucida presa di
coscienza, da parte della plebe, della sua autonoma
collocazione storico-sociale e quindi la rivendicazione,
in forma organizzata, di migliori condizioni di vita.
274. Gli “intellettuali
organici” della piccola borghesia napoletana, gli
inventori inconsci dell’ideologia della “napoletanità”,
furono scrittori che hanno il loro posto in qualsiasi
storia della letteratura, come Matilde Serao, Salvatore
Di Giacomo, Ferdinando Russo e il commediografo Roberto
Bracco.
|
 |
Salvatore Di Giacomo con sua moglie Elisa Avigliano |
La squadra dei parolieri:
album di famiglia
275. Ma furono soprattutto
parolieri come:
1)
il giornalista Peppino Turco, autore, come si è
detto (vedi sopra, n°252), di Funiculì
funiculà (1880);
2)
il cautamente socialista, e studiosamente carducciano,
Giovanni Capurro (1859-1920), autore della
celeberrima ‘O sole mio (1898), con musica
composta dal “posteggiatore” Eduardo Di Capua mentre si
trovava in tournée a Odessa, in una grigissima
Ucraina; ma anche di ‘E tre chiuove (1894); ‘O
pizzaiuolo nuovo (1896); Quanno màmmeta nun ce
sta (1904); Lilì Kangy (1905); Fili d’oro
(1915); Tatònno ‘e Quagliarella (1919);
|
 |
Gli autori di 'O sole mio (1898) |
3)
il maestro elementare Pasquale Cinquegrana
(1850-1939) che scrisse ‘E bersagliere
(1889); la celebre Furturella (1894);
l’originalissima ‘Ndringhetendrà (1895); le
allegre ‘A cura ‘e mammà (1900) e Rosa Rusella
(1903); e tantissime altre canzoni, alcune delle quali
furono eseguite anche nella Festa dei Gigli di Barra
(vedi oltre, n°343);
|
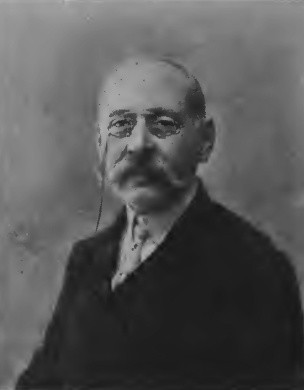 |
Pasquale Cinquegrana |
4)
il pittore-decoratore (vedi sopra, n°266) Gian
Battista De Curtis (1860–1926) che, oltre
all’immortale Torna a Surriento
[93], è anche autore di versi e musica di
Duorme Carme’ (1892); dei versi di Ninuccia, la
rosa di Toledo (1894), con musica di Vincenzo
Valente; e di Lucia Lucì (1911), insieme al
fratello musicista Ernesto De Curtis (1875-1937),
il quale nel frattempo, come pianista del grande tenore
Beniamino Gigli, portava la canzone napoletana in giro
per il mondo, e scriveva la musica di canzoni come
Voce ‘e notte (1904, Nicolardi) e Tu ca nun
chiagne (1915, Bovio);
|
 |
Gian Battista De Curtis |
5)
il poverissimo e sventuratissimo ciabattino Vincenzo
Russo (1876-1904)che imparò a scrivere frequentando
la scuola serale per lavoratori e, prima di morire di
tisi a soli 28 anni, consegnò alla musica di Eduardo Di
Capua (lo stesso di ‘O sole mio) e alla
immortalità nel tempo a venire, i versi di Maria
Mari’ e ‘A serenata d’‘e rose (1899); Io
te vurrìa vasa’ e Torna maggio (1900);
Canzone bella e L’ùrdema canzone mia (1904);
|
 |
Vincenzo Russo |
6)
l’altro “sorrentino”, e viveur poi pentito,
Aniello Califano (1870-1919)che ci ha lasciato
canzoni come Girulà (1895); Madama
Chichierchia (1903); Serenata a Surriento
(1907); Ninì Tirabusciò (1911); la canzone dei
soldati della Prima guerra mondiale ‘O surdàto
nnammurato (1915); ed infine, sempre durante la
Grande guerra, la canzone nostalgica della belle
èpoque ormai al tramonto, Tiempe belle ‘e na vota
(1916);
7)
il cameriere del “Caffè Turco”, poi “Caffè Tripoli”, in
Piazza Plebiscito, Giuseppe Capaldo (1874-1919),
il quale, scartato in un primo momento dalla ricca casa
editrice tedesca “Poliphon”, si prese poi la
soddisfazione di respingere la loro successiva offerta,
e si aggregò ai giovani napoletani della casa editrice
“La Canzonetta” con la quale pubblicò alcune delle sue
briose canzoni rimaste celebri: Comme facètte màmmeta
(1906); Ll’arte d’‘o sole (1908); ‘A tazza
‘e cafè (1918); ‘E llampadine (1919);
8)
il mitico Libero Bovio (1883-1942), figlio
chiattòne ed alquanto indolente del deputato,
professore universitario, patriota mazziniano di stretta
osservanza ed illustre Massone Giovanni Bovio
(1837-1903); con scarsa propensione sia al lavoro
sia allo studio, alla morte del padre ottenne, per
debita raccomandazione, un posto di scrivano al Museo
Nazionale, dal quale poté dedicarsi alla sua vera
vocazione di autore di canzoni; lasciata clamorosamente
la casa editrice musicale tedesca “Poliphon” nel clima
delle manifestazioni “interventiste” contro la Germania
e contro l’Impero austro-ungarico che precedettero la
Prima guerra mondiale, fu direttore de “La Canzonetta”
fino al 1923, passò poi alla “Santa Lucia” fino al 1934,
ed infine diede vita alla “Bottega dei quattro” insieme
ai musicisti Nicola Valente, Ernesto Tagliaferri e
Gaetano Lama; gli anni della sua vita sono scandìti da
canzoni famose, che distillano la quintessenza della “napoletanità”:
Surdàte (1909); ‘A serenata ‘e Pulecenella
(1911); ‘A canzone ‘e Napule (1912);
Tarantella luciana, Sona chitarra e Amor
di pastorello (1913); Guapparìa (1914); Tu
ca nun chiagne e Napule canta (1915);
Reginella (1917); Cara piccina (1918);
Napule e Maria (1921); Silenzio cantatore e
Brìnneso (1922); Chiove e L’addio
(1923); ‘O paese d’ ‘o sole (1925); Lacreme
napulitane (1925); Signorinella (1931);
Passione (1935); e tante altre …
9)
Eduardo Nicolardi (1878-1954),
figlio del direttore amministrativo del giornale “Il
Mattino” e, a sua volta, direttore amministrativo per
circa 40 anni (1910-1950) dell’ospedale “Loreto Mare”;
autore della celebre Voce ‘e notte (1904),
dedicata alla sua futura moglie Anna Rossi e musicata da
Ernesto De Curtis; ma anche di Sciuldèzza bella
(1905), Mmiez’‘o grano (1909), ed infine
di Tammurriata nera (1944), con musica di E.A.
Mario, che gli fu ispirata proprio dalle nascite dei
primi “criatùri niri”, figli di donne napoletane e di
soldati dell’esercito americano di occupazione, che
avvenivano nell’ospedale da lui diretto;
|
 |
Edoardo Nicolardi |
10)
il primo “cantautore”, anche in italiano, Armando
Gill (pseudonimo di Michele Testa, 1878-1945) della
cui copiosa produzione ricordiamo qui: Rispetti
all’antica (1915); Come pioveva e ‘E
quatto ‘e maggio (1918); Bella ca bella si’
(1919); ‘O zampugnaro ‘nnammurato (1924); E
allora? (1927); …
11)
l’altro paroliere e musicista insieme, E.A. Mario
(pseudonimo di Giovanni Gaeta, 1884-1961): autore dei
versi di Comme se canta a Napule (1911);
Funtana all’ombra e Maggio si’ tu (1912);
Io, ‘na chitarra e ‘a luna (1913); La leggenda
del Piave, la mitica canzone patriottica del giugno
1918; seguita dalla altrettanto mitica canzone degli
emigranti Santa Lucia luntana (1919); le tre
canzoni che fecero la fortuna della “chanteuse
sensuale” Anna Fougez e cioè Ladra (1916),
Vipera e Le rose rosse (1919), alle quali
farà poi quasi da contrappunto la celebre Balocchi e
profumi (1928); Canzone appassiunata e
Mandulinata a Surriento (1922); ed autore della
musica di Core furastiero (1928), con parole di
Alfredo Melina; Dduie paravìse (1928), su parole
di Ciro Parente; e della già citata Tammurriata nera
(1944), sui versi di Eduardo Nicolardi, che era suo
con-suocero.
L’opposto di Francesco Mastriani: Ernesto Mùrolo
276. E per ultimo il più
“scervellato” di tutti, e cioè Ernesto Murolo
(1876-1939) quello che potrebbe essere considerato,
per superficialità intellettuale ed irresponsabilità
morale, l’esatto opposto di Francesco Mastriani (vedi
sopra, n°117 e segg.).
Per lui Napoli era veramente
solo il panorama che vedeva dalla sua casa al Vomero ed
i napoletani veramente persone che vivevano
felici, senza alcun bisogno di lavorare, godendosi ’e
belle figliòle, ‘o sole, ‘o mare, ‘e stelle, e ‘a
luna quanno spònta.
Difatti, lui visse
parassitariamente di rendita per tutta la vita, “senza
fare nulla e tuttavia in continua agitazione” (cfr 2Ts
3, 10-12).
|
 |
Ernesto Mùrolo |
277. Ufficialmente, era figlio
di Vincenzo Murolo e di Maria Palumbo, ma tutti sapevano
(e mai come in questo caso: vox populi, vox Dei)
che era figlio, in realtà, dell’ineffabile Edoardo
Scarpetta (vedi sopra, nn°227-228) il quale, per
liberarsi vantaggiosamente dal peso di questo ennesimo
figlio occasionale ed indesiderato, l’aveva ceduto, a
prezzo forse nemmeno eccessivo, al buon Don Vincenzo e
alla moglie, che non potevano avere figli propri e che
lo adottarono legittimandolo.
Il padre adottivo era un ricco
commerciante ed Ernestino visse nella bambagia fin da
piccolo, da “figlio di papà”, senza impegnarsi né a
lavorare né a studiare, e alla morte di Vincenzo, dopo
aver vinto la causa mossa contro di lui da altri
parenti, si ritrovò nel 1908 (a 32 anni) unico erede di
un vasto patrimonio.
278. Da quel momento, si dedicò
con scrupolosa incoscienza a scialacquare i soldi che il
defunto aveva accumulato con accorta parsimonia. Si
diede una rispettabilità borghese sposando Lia Cavalli,
figlia venticinquenne di un pittore livornese, dalla
quale (?) ebbe 7 figli; ma questo ovviamente non gli
impedì di “innamorarsi” di molte altre donne,
frequentate con varia intensità e per periodi più o meno
lunghi, sempre all’insegna, beato lui, di romantiche
passeggiate ed abbondanti libagioni …
279. Nel 1917 era in pieno
svolgimento la Prima guerra mondiale, milioni di uomini
di tutte le nazionalità stavano letteralmente
crepando nelle trincee e lui, dal suo salotto del
Vomero, si rivolgeva al “popolo” con una canzone
intitolata appunto Popolo po’ il cui ritornello
dice:
Napule, bella città,
ride, ce veve 'a coppa e campa assaje, ca ll'aria 'o ddà.
Stasera cu 'a figliola ca ce attòcca,
popolo, pò,
a musso a musso, azzìcco azzìcco, oje vocca,
tu che ne vuò?
Sia incoscienza sia semplice
superficialità, fa il paio con il ritornello di un’altra
canzone, del 1924, intitolata Qui fu Napoli,
nella quale, fra il mare, la luna, le stelle, e i
pescatori che preparano da mangiare a lui e alla bella
figliola di turno, conclude:
E io canto: - Qui fu Napoli.
Nisciùno è meglio ‘e me.
Dimàne penzo e riébbete,
stasera so’ nu rre.
280. Diceva di non occuparsi di
politica, ma nel 1925 fu comunque tra i firmatari
(insieme, è pur vero, a Salvatore Di Giacomo, Luigi
Pirandello, Gabriele D’Annunzio, Curzio Malaparte …) del
“Manifesto degli intellettuali fascisti” scritto da
Giovanni Gentile.
281. Quando, una decina di anni
dopo, ormai vecchio, gli finirono i soldi, per
sopravvivere si mise a scrivere “sceneggiate”: “sciolto
da ogni velleità artistica e da ogni intendimento
poetico, Murolo riscosse, con le sceneggiate da lui
allestite, il consenso di un pubblico pronto a cadere
nel trabocchetto di ogni più elementare macchina
teatrale”[94].
Ebbe pure l’ultima fortuna di
morire prima che iniziasse la seconda guerra mondiale.
Sulla sua tomba, starebbe opportuno l’epitaffio:
“Avrebbe potuto fare del bene a molti, ma pensò solo a
se stesso”.
282. Rimane il fascino
indiscutibile delle sue canzoni, per lo più musicate da
Ernesto Tagliaferri: Pusilleco addirùso (1904);
Tarantelluccia (1907); L’ammore che fa fa’(1911);
Te si scurdàta ‘e Napule (1912); Popolo po’
(1917); Napule ca se ne va (1920);
Mandulinata a Napule (1921); Qui fu Napoli
(1924); Piscatore ‘e Pusilleco (1925);
Tarantella internazionale (1926); Quann’ammore
vo’ fila’ (1929); Nun me sceta’ (1930); ‘A
canzone d’‘a felicità (1930); Adduòrmete cu’ me
(1931); ‘O cunto ‘e Mariarosa(1932).
L’album di famiglia dei musicisti
283. Altrettanto se non più
importanti, come “intellettuali organici della
napoletanità”, furono i musicisti, a partire dai
due illustri e coetanei capo-stipiti:
1)
l’abruzzese Francesco Paolo Tosti (1846-1916),
che fu insegnante di musica della regina Margherita e
poi alla Corte della regina Vittoria in Inghilterra, e
compose fra l’altro i super-classici: A Marechiare
(1886), su versi di Salvatore Di Giacomo e ‘A
vucchèlla (1904), su versi di Gabriele D’Annunzio;
|
 |
Gabriele D'Annunzio 'A vucchella |
2)
Luigi Denza (1846-1922),
già citato (vedi sopra, n°252) come autore della musica
di Funiculì funiculà, allievo di Francesco
Saverio Mercadante e poi maestro di canto al
Conservatorio di S. Pietro a Maiella, che nel 1879 si
trasferì a Londra dove insegnò alla Real Accademia di
Musica, e tornava solo per le vacanze termali al suo
paese natìo Castellammare di Stabia.
|
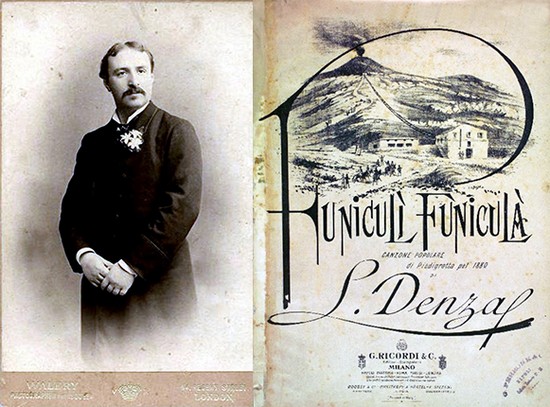 |
Il maestro Luigi Denza |
E poi:
1)
il raffinato Mario Costa (1858-1933), per il
quale impazzivano le più belle dame dell’aristocrazia
napoletana, e fu il primo musicista di Salvatore Di
Giacomo: Nannì (1882); le tre canzoni del 1885,
per la ripresa di Piedigrotta dopo il colera del 1884, e
cioè Carulì, Oilì oilà e Era de maggio;
Luna nova (1887), che divenne la canzone
preferita del Papa Leone XIII; ‘A ritirata,
scritta sempre nel 1887 in occasione della “disfatta di
Dògali”; Lariulà (1890); Catarì (1892);
Serenata napulitana (1896);
2)
il languido e dannunziano Enrico De Leva (1867-1955),
rimasto celebre per la musica di ‘E spìngule frangése
firmata da Di Giacomo nel 1888.
E poi ancora:
1)
il geniale musicista popolare autodidatta Salvatore
Gambardella (1871-1913), vero “Mozart napoletano”:
figlio di un portinaio, iniziò a lavorare da ragazzo
come garzone nella bottega di ferramenta del musicista
Vincenzo Di Chiara, che fu il primo ad intuire ed
assecondare il suo innato talento musicale; nel 1893,
senza saper scrivere le note, “inventò” la musica di
‘O marenariello; il
successo di quella canzone attirò su di lui l’attenzione
dell’editore Bideri, che gli “affiancò” il maestro
Achille Longo, allora insegnante nel conservatorio di S.
Pietro a Majella, con il compito di “trascrivere” in
buona e dovuta forma le melodie che Gambardella
improvvisava “ad orecchio”; nacquero così piccoli ma
geniali brani di ogni genere musicale, composti per
tutti i più importanti parolieri: ‘E trezze ‘e
Caruline e Don Carluccio (Di Giacomo);
Quanno tramonta ‘o sole (Ferdinando Russo);
Quanno màmmeta nun ce sta e Lilì Kangy
(Capurro); Comme facette màmmeta e L’arte d’o
sole (Capaldo); Furturèlla (Cinquegrana),
della cui musica lo stesso Giacomo Puccini disse: “La
canzone ha una progressione musicale discendente degna
del più grande musicista classico”;
Pusilleco addirùso
(Murolo); Serenata a Surriento e Ninì
Tirabusciò (Califano) e tanti altri;
Salvatore Gambardella morì a soli 42 anni, povero quasi
com’era alla nascita: l’unico che ci si arricchì fu
l’editore Bideri;
|
 |
Il musicista autodidatta Salvatore Gambardella |
2)
Eduardo Di Capua (1865–1917),
il musicista di ‘O sole mio e delle grandi
canzoni di Vincenzo Russo, che lui conobbe perché era un
accanito quanto sfortunato giocatore al lotto e
Vincenzino Russo aveva fama di “assistito”;
3)
Rodolfo Falvo (1873–1937),
detto “mascagnino”, compagno di Bovio nella rottura
“patriottica” con la “Poliphon” (vedi sopra, n°275) e
poi a “La canzonetta”, autore di Uocchie
c’arraggiunate (1904, versi di Alfredo Falcone
Fieni); Guapparìa (1914, versi di Libero Bovio);
Dicitencélle vuje (1930, versi di Enzo Fusco);
ironia della sorte: sia l’avvocato Falcone Fieni (nel
19??) sia Enzo Fusco (nel 1951) morirono suicidi,
lanciandosi da un balcone del Vecchio Policlinico di
Napoli;
|
 |
Il maestro Rodolfo Falvo 'mascagnino' |
4)
il calabrese Vincenzo Valente (1855-1921), detto
‘o scuòrfano (vedi la foto!) per la sua
bruttezza, ma autore di musiche belle come quella di
Tiempe belle ‘e na vota;
|
 |
Il maestro Vincenzo Valente 'o scuòrfano |
5)
Vincenzo Di Chiara (1864–1937),
al quale abbiamo già accennato come “scopritore” di
Gambardella, e rimasto poi famoso soprattutto per il
testo (in italiano) e la musica di La spagnola
(1906);
6)
Francesco Buongiovanni (1872-1940), il musicista di Totonno ‘e
Quagliarella (1919, Capurro) e di Làcreme
napulitane (1925, Bovio); ma soprattutto di
Palomma ‘e notte (1907): i versi di questa canzone
sono giustamente attribuiti a Salvatore Di Giacomo,
anche se Don Salvatore tradusse e adattò, in napoletano
e secondo il suo personale genio poetico, una
pre-esistente poesia in dialetto veneto della scrittrice
di origini armène Vittoria Aganoor Pompilj
(1855-1910) intitolata appunto “La pavègia”;
|
 |
Il musicista Francesco Buongiovanni |
7)
Giuseppe De Gregorio (1866-1933),
che tenne per molti anni una apprezzata scuola di canto,
ed autore della musica di parecchi testi di Pasquale
Cinquegrana, fra i quali Ntringhetendrà (1895) e
Napule bello (1898);
8)
Enrico Cannio (1875-1949),
amico ed accompagnatore musicale di Raffaele Viviani
come di Enrico Caruso, autore delle felicissime musiche
di ‘A serenata ‘e Pulecenella (1911, Bovio) e
Tarantella luciana (1913, Bovio); ‘O surdàto
‘nnammurato (1915, Califano); Rusella ‘e maggio
(1939, versi di Arturo Trusiano);
|
 |
Il musicista Enrico Cannio |
9)
Giuseppe Capolongo (1877-1928),
autore di Nuttata ‘e sentimento (1908), anche lui
musicista autodidatta come Gambardella, di mestiere
faceva l’impiegato in un Banco Lotto di Via Tribunali;
insieme all’amico Francesco Feola fondò nel 1905 la
importante Casa editrice musicale “La canzonetta”; e per
“La canzonetta” lavorò anche Alessandro Cassese
(1876-1916), nativo di Castellammare di Stabia e
autore dei versi di Nuttata ‘e sentimento, che di
mestiere faceva invece la guida turistica (conosceva
bene la storia dell’arte e parlava correntemente il
francese, l’inglese e il tedesco) e morì in
combattimento durante la Prima guerra mondiale,
lasciando (ahi, loro!) la moglie e sei figlioli.
 |
|
 |
Il musicista Giuseppe Capolongo |
|
Il poeta Alessandro Cassese |
10)
il foggiano Evèmero Nardella (1878-1950):
Suspirànno (Murolo) e Mmiez’‘o grano
(Nicolardi), entrambe del 1909; Surdàte
(1910, Bovio) e Chiove (1923, Bovio);
11)
Emanuele Nutile (1862-1932):
Mamma mia che vo’ sape’ (1909, Ferdinando Russo);
Amor di pastorello (1913, Bovio); Anema e core
(1933, Pacifico Vento);
 |
Il maestro Emanuele Nutile |
12)
Ed infine la triade: Nicola Valente (1881-1946),
figlio di Vincenzo ‘o scuòrfano; Ernesto
Tagliaferri (1889-1937) figlio invece di un barbiere
del Borgo S. Antonio Abate e diplomato in violino al
Conservatorio di S. Pietro a Majella; Gaetano Lama
(1886-1950), musicista elegante per “periodiche”;
tutti e tre, insieme a Libero Bovio, fondarono negli
anni Trenta la “Bottega dei quattro”, che ebbe però vita
alquanto breve e poco fortunata.
La città “messa a mollo”
284. Parolieri e musicisti,
ogni anno, in particolare in occasione della Festa di
Piedigrotta, riversarono nelle strade, piazze e larghi,
vicoli e vicoletti, fòndaci, suppòrtici, spiagge e
marine, veri e propri torrenti di versi e di note, che i
pianini dei vicoli, le “posteggie” dei ristoranti, i
concertini del varietà, le sciantòse del Salone
Margherita e le signorine da marito nelle festicciole
periodiche dei salotti borghesi, ripetevano senza mai
stancarsi.
Tutta la città, e quindi
soprattutto la ingente mole della plebe urbana, venne
letteralmente “messa a mollo” in un infuso
sentimental-piccolo borghese di voci silenziose e
silenzi parlanti, occhi dolci e manélle delicate,
cuori ingrati e làcreme napulitàne, guappi
innamorati ed emigranti lontani dal mare e dalla luna di
Posillipo e di Marechiaro: un infuso dolcissimo, dal
quale traboccavano le parole “cuore” e “amore” (la rima
“più antica e più difficile del mondo”, secondo Umberto
Saba), la parola “mamma”, la parola “casa”, la parola
“rosa”, allegria e malinconia …
285. Come resistere a questa
Sirena ammaliatrice? L’immagine che la piccola borghesia
napoletana voleva avere di sé e della sua
città, per quanto ben lontana dal vero, venne
efficacemente trasmessa alla plebe, agli emigranti e ai
forestieri.
Tanto efficacemente che, ancora
nel 1947 (!), si poteva dipingere questo assai poco
realistico “Acquarello napoletano” (musica di Lino
Benedetto e parole di Enzo Bonagura, che non a caso era
stato segretario del Partito fascista a S. Giuseppe
Vesuviano negli anni Venti e Trenta):
Ué, ué … Madonna Notte ci
convita!
Venite, mùsici e poeti!
Da questa tavola imbandita,
brinderemo all’incantesimo
lunar!
Settimana di sette feste:
questa è Napoli, punto e basta!
La fascia di seta
profumata sulle piaghe ulcerate
286. Ma fin dall’inizio questa
immagine “acquerellata” non era che un tenue e
leggerissimo velo che copriva le antiche piaghe
irrisolte della pre-esistente miseria che andava adesso
aggravandosi nel nuovo sistema liberale borghese.
Questa immagine, come aveva già
scritto Francesco Mastriani (vedi sopra, n°189), non era
che “una
fascia d’oro o di seta” impregnata delle “essenze più
prelibate e odorose” e “gittata sulla cangrèna” delle
annose piaghe:
la mancanza di un
lavoro dignitoso e di una casa decente, di cure mediche
non troppo costose, di acqua pulita e di un vero sistema
fognario, di una istruzione adeguata e di un minimo di
servizi pubblici efficienti; mentre la città rimaneva in
balìa di capitali del nord o forestieri, di banchieri
intrallazzatori e di un ceto dirigente locale incapace
e/o corrotto.
287. Nel 1884 c’era stato il
colera ed il successivo “Risanamento” si era risolto in
una grande operazione speculativa che ben pochi vantaggi
aveva apportato al popolo minuto
[95].
Di lì a poco, nel 1901,
l’inchiesta Sarédo “scoperchierà” ufficialmente quella
pentola dalla quale traboccava il dolcissimo infuso di
cuore-amore, e la pentola mostrerà tutto il suo vero e
ripugnante contenuto: ma servirà?
Comm’a ‘nu suonno de marenàre,
tu duorme, Napule, viata a te!
Duorme ma, ’nzuonno, làcreme amàre
tu chiagne, Nàpule: scétate, scé!
Puozze ‘na vota resuscità!
Scétate,
scé, Napule, Na’!
[96]
La festa dei gigli a
Barra nell’Ottocento: le origini (1822-23)
288. E’ merito di Romano Marino l’aver recuperato e
pubblicato i pochi documenti sulla festa dei gigli di
Barra nell’Ottocento giunti fino a noi.
289. Delibera di Giunta Municipale n°68 del 1°luglio
1822: “… non si autorizza la processione di un
castelletto di legno, detto giglio, in occasione della
festività della Patrona di questo Comune lungo la strada
principale … poiché si è nell’attesa, dopo comunicazione
scritta inviata alla Règia Intendenza, di autorizzazione
per ordine pubblico …”
Delibera di Giunta Municipale n°56 del 30 giugno 1823:
“… il Sindaco … avùtone l’autorizzazione e predisposto
adeguato servizio d’ordine con Guardia nazionale,
municipale e campestre … autorizza che sia
trasportata per la strada Parrocchia una macchina
lignea, detta giglio, similare a Nola …”
290. Come sappiamo, il 9 luglio
1822, essendo papa Pio VII (1800-1823), arcivescovo di
Napoli il card. Luigi Ruffo Scilla (1802-1832) e parroco
don Gaetano Ascione (1806-1825), venne emessa la
apposita Bolla pontificia con la quale S. Anna veniva
proclamata ufficialmente quale “patrona” di tutto il
Comune della Barra
[98].
Da quell’anno, poté dunque effettuarsi ufficialmente, il
26 luglio, anche la processione di S. Anna “lungo la
strada principale”, che allora però non si chiamava
ancora Corso Sirena, ma portava nomi diversi nei suoi
diversi tratti ovvero, nell’ordine, a scendere da
Monteleone: Strada detta Sciùlia, Strade di Sopra e di
Sotto (le Torri), Strada Parrocchia, Strada S.
Antonio, e poi Crocella, Serino e S. Anna
[99].
291. In quella solenne circostanza, un gruppo di
Barresi, la maggior parte facchini che lavoravano al
porto e alla dogàna (cosiddetti “sangiovannàri”), ebbe
l’idea di trasportare “una macchina lignea, detta
giglio, similare a Nola” per “la strada Parrocchia”
ovvero di aggregarsi con il giglio alla processione
della Santa nel tratto fra la Parrocchia e la chiesa di
S. Antonio.
Nel 1822, però, come abbiamo visto, “si è nell’attesa,
dopo comunicazione scritta inviata alla Règia
Intendenza, di autorizzazione per ordine pubblico” e
pertanto quel primo ed unico giglio barrese rimase fermo
laddove era stato costruito, presumibilmente in Largo
Parrocchia, di fronte all’ingresso di Palazzo Magliano.
292. Solo nel successivo anno
1823, “avùtone l’autorizzazione”, il giglio si poté
accodare alla processione di S. Anna, nel previsto
tratto fra la chiesa di S. Anna e quella di S. Antonio …
e passando davanti alla “Casa comunale” di Barra che,
per tutto il periodo borbonico successivo al Decennio
francese (1815-1860), era il palazzetto, poco distante
dalla Parrocchia e designato attualmente Corso Sirena
n°290, sul cui portone si vede ancor oggi lo stemma
municipale della Sirena bi-cauda con il motto
UNIVERSITAS
[100].
Si ricordi anche che, a quel tempo, non c’era ancora la
Piazza e l’ex-convento francescano aveva solo due piani
ed era adibito a carcere
[101].
Come era fatto il giglio
del 1822-23
293. Ma come era fatto questo “castelletto di legno”,
questa “macchina lignea, detto giglio, similare a Nola”
che, rimasto fermo nel 1822, poté poi seguire per un
breve tratto la processione della Santa Patrona di Barra
nel 1823?
Nella prima metà dell’Ottocento, la forma del giglio, a
Barra come a Nola, era all’incirca quella di una torre
quadrata a quattro facce, più bassa dei gigli attuali,
ma fatta comunque di più piani sovrapposti, e che veniva
semplicemente “portata in processione” a spalla, al
suono (senza canzoni) di una “strepitosa marcetta”, come
testimonia Karl August Mayer (1808-1894) nel suo
diario di viaggio pubblicato nel 1840:
“Mi sia permesso di dire una parola su una festa, San
Paolino, che si celebra a Nola, a quattro ore da Napoli,
il 22 giugno.
Questa festa è caratteristica in quanto che in essa sono
portati in processione per le strade, a passo
accelerato, da uomini che camminano nascosti sotto
tappeti, palchi di cinque piani, di venti piedi di
altezza, riccamente dipinti e dorati, e ornati di fiori
e bandiere.
Nel piano più basso, si vede una banda di musicisti che,
tra il giubilo generale e lo scoppio di mortaretti e
colpi di cannone, lanciano la loro strepitosa marcia.
I piani superiori sono fregiati di angeli e di santi,
che sono in parte pupazzi di legno, in parte graziosi
bambini, riccamente addobbati”
[102].
I gigli nella seconda
metà dell’Ottocento
294. Sarà solo nella seconda metà dell’Ottocento
che i gigli assumeranno la forma slanciata che vediamo
tuttora e cresceranno gradualmente in altezza fino agli
attuali 25 metri, come attesta un altro illustre
viaggiatore, Ferdinand Gregorovius (1821-1891),
che venne in Italia la prima volta nel 1852 e vi
soggiornò poi, per lunghi periodi, prima e dopo
l’unificazione politica della penisola nel 1860:
“Mi si era parlato, a Napoli, della festa di San Paolino
a Nola e mi si era anche assicurato che meritava di
essere veduta.
Ero appena entrato a Nola che mi colpì la vista una
strana cosa, della quale non avevo ombra d’idea e che mi
fece dubitare di trovarmi piuttosto nelle Indie, od al
Giappone, che in Italia, nella Campania.
Vidi una specie di torre, alta, sottile, tutta
ornata di carta rossa, di dorature, di fregi d’argento,
portata sulle spalle da uomini. Era divisa in cinque
ordini, a piani, a colonne, decorata di frontespizi, di
archi, di cornici, di nicchie, di figure e coperta ai
due lati di numerose bandiere ...
Giunta poi ogni torre davanti alla cattedrale,
incominciava uno strano spettacolo, imperocché ognuna di
quelle moli grandiose si dava a ballare a suon di
musica.
Precedeva i portatori un uomo con un bastone, il quale
batteva il tempo, e le torri seguivano quello. Il
colosso oscillava e sembrava ad ogni istante che volesse
perdere l'equilibrio e cadere; tutte le figure si
muovevano, le bandiere sventolavano; era un colpo
d'occhio fantastico”[103].
I sangiovannàri
295. Riguardo invece ai cosiddetti “sangiovannàri”
(vedi sopra, n°291) ed al loro rapporto con la festa dei
gigli, il già citato Karl August Mayer scrive:
“San Giovanni il battezzatore, la cui festa è
notoriamente celebrata il 24 giugno, è il patrono dei
facchini napoletani, che abitano per lo più nel vicino
villaggio di San Giovanni (chiamato così dal nome del
Santo) che è sulla strada per Portici”.
296. Ma, soprattutto, abbiamo il celebre de Bourcard
(prima edizione del secondo volume: anno 1858) il quale
dettagliatamente dòcet:
“Lazzarone— nome generico dell'infimo ordine del nostro
popolo.
Facchino — lazzarone che ha deposto in gran parte la
rozzezza originaria, utilissimo anzi necessario alla
società, industrioso, intelligente, onesto, sempre
occupato, attivo, solerte, e d'ordinario, come vedremo,
assai onorato e stimato.
I facchini, addetti esclusivamente ai trasporti, ciò
fanno in diversi modi. Alcuni lèvano i pesi interamente
sul capo. Altri, ponendosi una specie di berretto lungo
di lana bigia che ricade attortigliato sul collo, e
detto perciò sacco, caricano del peso il collo medesimo:
e questo chiamano, con propria frase, auzàre ‘ncuollo
(alzare in collo).
Altri, infine, trasportano i pesi affidandoli ad una
spranga, che appoggiano sopra una sola spalla, e questi
ultimi sono quasi tutti di San Giovanni a Teduccio,
grazioso ed industre villaggio ne’ dintorni di Napoli,
detti perciò comunemente i sangiovannàri”.
 |
I sangiovannàri |
I sangiovannàri e
la festa dei gigli a Nola
297. “Al nominare i sangiovannàri, molti dei
nostri lettori saran corsi per avventura col pensiero
alla bella festa popolare così detta de’ gigli, che da
costoro rècansi in ispalla nel giorno 22 giugno, in cui
la città di Nola celebra la festa del suo vescovo e
protettore S. Paolino …
298. Queste piramidi o gigli, avanzando di tempo in
tempo, sono arrivati oggidì (1858) ad una tanto
considerevole mole e smisurata altezza che soprastano i
tetti de’ più alti edifizi della città.
Ciascun lato di essi gigli è adorno di fiori, nastri,
bende, festoni, statuette di carta pesta e simiglianti
cose.
La macchina è divisa in più ordini, nel primo dei quali
è collocata l’orchestra, ed accompagnati dal suono di
questa, i facchini (che sono appunto i sangiovannàri)
ballano a tempo di musica con quello smisurato peso
sulle spalle.
Gli altri ordini sono occupati da popolani, ne’ loro
abiti da festa e le donne si rivestono de’ migliori
ornamenti che posseggono.
Questi gigli sono costruiti a cura delle diverse
corporazioni di arti e mestieri, che ricordano le
antiche fratrìe. I principali sono quelli de’
sartori, de’ calzolai, de’ fabbricatori e degli
ortolani.
Ciascun giglio è sostenuto da 16 facchini, ma il più
grandioso è quello degli ortolani, trasportato da 36 di
essi.
Spari di mortaretti, campane a disteso, fuochi
d’artifizio, luminarie e quant’altro possa esservi di
più clamoroso in una festa popolare, rendono pomposa e
magnifica la processione de’ gigli, i quali,
accompagnati da numeroso clero, vengono portati innanzi
al Vescovado dove ricevono la benedizione del
Santissimo”.
I diversi tipi di
facchini
299. “Per tornare ora al nostro proposito, i facchini,
come dianzi dicemmo, sono industriosi ed intelligenti ma
formano le principali loro doti l’onestà e
l’onoratezza. Déggiono queste, anzi, dirsi
condizioni assolutamente inerenti all'esercizio di un
mestiere che ridùcesi, in sostanza, ad un contratto di
buona fede.
Hànnovi diverse specie di facchini.
300. Alcuni sono destinati a Règie Amministrazioni come
al Banco, al Monte de’ pegni, alla Zecca etc. e la
fiducia che in costoro ripone lo stesso Governo, come di
leggieri è a credere, è piena ed illimitata, sì che
eglino hanno ingresso libero in qualsivoglia di coteste
officine e senza riserba di sorta.
Eguale, anzi maggiore, è la fiducia che ispirano quelli
addetti alla Gran Dogana, e di cui or ora
c’intratterremo più distesamente.
301. Altri stanno al servizio delle strade ferrate, per
comodo de’ viaggiatori affin di trasportare i loro
effetti, come baùli, casse, sacche da viaggio, etc.
302. Altri trasportano in ispalla le bare, distribuiti
alle quattro aste dello strato mortuario, e sono
propriamente i becchini. Costoro appartengono per
Io più al quartiere Mercato.
303. Hànnovi quelli impiegati pel trasporto del carbone
fossile su i bastimenti a vapore, règi o mercantili, e
questi sono d’ordinario al servigio di partitari o
appaltatori.
304. Hànnovi quelli esclusivamente addetti al trasporto
di strumenti musicali, come pianoforti, arpe e simili, e
costoro formano una specialità, per la cura,
l’attenzione e l’espertezza che si richiéggono nel
maneggio degli strumenti medesimi. Essi risiedono
principalmente alla salita Magnocavallo.
305. I seggettiéri vanno anche nel numero dei
facchini, e sono quelli destinati al trasporto delle
seggètte o bùssole, le quali son poggiate a due aste di
legno che eglino règgono con ambe le mani, e
raccomandate inoltre ad una grossa coreggia che pende
loro dal collo. Le donne di teatro principalmente fanno
uso di tal mezzo quando si trasferiscono al loro
officio, sia pe’ concerti sia per le rappresentazioni.
Queste seggette accolgono il mondo femminile di cantanti
e di corifee di primo secondo e terz’ordine, assolute e
non assolute, di alto o basso cartello, senza
distinzione di sorta, dall’ugola preziosa della Malibran
all’ultima corista, da’ piedi alati della Essler alla
più oscura tra le corifee.
 |
I seggettieri |
306. Eravi una volta un’altra specie, non saprei dire se
di facchini o di lazzaroni, così detti passa-lave,
che a piedi scalzi e co’ calzoni rimboccati fino al
ginocchio, toglievano sulle spalle i passeggieri ne’
giorni molto piovosi e li traghettavano da un lato
all’altro delle grosse lave. Vero è che, tal fiata, o
non essendo abbastanza forti da reggere il soprastante
fardello, o per disquilibrio della persona, o per altra
causa, procacciavano un bagno freddo alle loro innocenti
vittime, d’altra parte troppo inaspettato ed
intempestivo, ciò che ha dato origine a molte grottesche
caricature che véggonsi anche oggidì ne’ disegni de’
costumi napolitani. Nondimeno è giustizia avvertire come
ciò avvenisse molto di rado. Di presente (1858),
non véggonsi più di cotesti passa-lave essendone
quasi che affatto cessato il bisogno.
307. Hànnovi finalmente facchini i quali non esercitano
propriamente alcuna specialità di mestiere, ma stanno lì
a disposizione di qualunque voglia avvalersi
della loro opera. E questo è il facchino come
ordinariamente vien delineato ne’ quadri de’ nostri
costumi. Sdraiato nella sua sporta (grossa cesta)
nella quale mangia beve e dorme, tra i nembi di fumo che
partono dalla pipa, indivisibile sua compagna, egli si
dà pochissimo pensiero del domani, bastandogli quanto
provveder possa ai bisogni della giornata. Nulla
ingordo, quando ha di che accender la pipa, di che
comprare i suoi deliziosi maccheroni e di che
provvedersi d’un sorso di vino, si reputa il più felice
di questa terra. Chiamato dall'avventore, lo segue e
lucra così la sua giornata.
308. I facchini napolitani sono dotati, in generale,
d’una forza non comune; ciò che possiamo di leggieri
argomentare dagli smodati pesi che talvolta uno solo di
essi sostiene sul capo e trasporta con ammirabile
disinvoltura”.
I facchini ‘o quatto
‘e Maggio
309. “L’aver poi eglino una grandissima attività e
perizia è cosa che può osservarsi di continuo, in
ispecie nella tumultuosa e tradizionale giornata del
quattro maggio. Ivi campeggia, ivi regna, ivi domina il
facchino.
Ed eccoli affaccendarsi, correre giù e su, scendere e
salir per le altrui scale, pieni di polvere, trafelàti,
affannosi, grondànti sudore a goccioloni. E taluni
trasportano Ie masserizie sul capo; tali altri sulla
schiena; tali altri le caricano su carretti, in guisa
tale architettandole che non pure vi sia pericolo di
perdita e caduta di oggetti, ma anche vi si ammiri
l'arte e la ragionata disposizione; e tali ancora si
sobbarcano eglino stessi a’ loro carretti a modo di
giumenti.
Questi facchini si compongono in parànze,
ciascuna delle quali ha il suo capo-parànza da
cui dipendono, e che è responsabile direttamente verso i
suoi clienti della roba la quale gli viene affidata.
 |
O quatto 'e maggio |
310. Né altro aggiugneremo sul quattro Maggio, avendone
già tenuto proposito nel primo volume di quest’opera, e
passeremo a qualche maggiore specialità sul facchino di
San Giovanni a Teduccio, ovvero sangiovannàro,
onde sopra toccammo”.
Il sangiovannàro
come cipresso fra i viburni
311. “Il sangiovannàro può dirsi veramente il
facchino-tipo, perocché primeggia sugli altri, secondo
la frase del Mantovano (Virgilio):
Quantum lenta sòlent inter viburna cupressi
Quanto i cipressi si innalzano fra i viburni
Se l’onestà e l’onoratezza (ripetiamo) è la condizione
indispensabile del facchino in generale, lo è poi in un
modo eminente del sangiovannàro.
Non solo i privati, ma ancora il governo, affida a
costoro tesori preziosissimi, e quelli e questo sono
troppo sicuri della illibatezza de’ depositari, come
alla lor volta i facchini vàlutano compiutamente
l’importanza di conservarla.
In altri mestieri è forse possibile riparare ad una
frode, ad una infedeltà, ma qual risorsa rimarrebbe al
sangiovannàro che avesse, anche una sola volta e
per poco, maculàto il suo onore? Niuno più al certo se
ne avvarrebbe, nè resterèbbegli che campar la vita
accattando.
Quei versi del Boileau :
L’honneur est comme une ile escarpée et sans bords:
on n’y peut plus rentrer dès qu’on est dehors.
L’onore è come un’isola scoscesa e senza spiagge:
non vi si può più rientrare quando si è usciti.
sono per avventura più che mai applicabili a questa
specie di facchini”.
I sangiovannàri facchini di
dogana: parànze e
caporali
312. “Sangiovannàri sono i facchini della dogana,
e di quest’ordine troppo importante sarà utile
intrattenerci un poco più diffusamente.
A far ciò con la maggiore esattezza possibile,
trasceglieremo, riportandole per summa càpita,
dalla Esposizione della Legge del 19 giugno 1826 sulle
dogane, pubblicata per le stampe a cura di Raffaele
Mastriani (vedi sopra, n°134), quelle notizie che alla
bisogna ci paiono meglio confacenti, rinviando alla
citata opera i bramosi di più minuti e diffusi
ragguagli.
313. Il numero de’ facchini addetti al servizio della
Gran Dogana è stabilito a 360. Di costoro debbono i
commercianti esclusivamente avvalersi, per l'interno
della Gran Dogana, negli scaricamenti e caricamenti in
porto, nel trasporto delle macchine di peso alla dogana,
e nelle estrazioni dalla medesima (Art. 1).
314. L'operazione dell'alzare una balla o merce dal lido
di mare e portarla al magazzino chiàmasi collàta.
Questi facchini sono distribuiti in parànze o
compagnie, e ciascuna paranza o compagnia dipende da
un capo e due sottocapi (Art. 2 e 3).
La paranza si compone di 8 a 12 facchini ed i
capi, che con voce propria diconsi caporali o
capi-paranza, vengono nominati dai negozianti. Non è
però a dire quanta e quale fiducia questi ultimi debbano
riporre ne’ loro capi-paranza come depositari di
fortissimi capitali e spesso dell’intera loro sostanza.
L’è questa una ragione per la quale li prediligono, gli
amano, sono larghi verso loro di premi e retribuzioni,
allorquando se ne rendono degni; sì che non pochi
capi-paranza si sono arricchiti, grazie alla
benevolenza de’ negozianti cui servirono, e taluni,
divenuti proprietari, godono nella terra nativa
pacificamente gli onorati frutti de’ loro sudori ed il
guiderdòne a giusto titolo dovuto alla loro onestà”.
Marìtemo è facchino de
Duàna
315. “Laonde non è a maravigliare se il nome del
sangiovannàro sia molto stimato, e se la donna del
popolo (secondo quanto scrive il nostro vecchio ed
erudito Bidera nella sua “Passeggiata per Napoli”) vada
giustamente altiéra di associare i suoi giorni a quelli
di lui e di esclamare con nobile orgoglio: - Marìtemo
è facchino de Duana (= Mio marito è facchino della
Dogana).
316. I negozianti non possono dirigersi che ai capi
delle compagnie, ed in assenza a’ sottocapi, i quali
rimangono responsabili della esattezza de’ loro
dipendenti (Art. 4), al quale oggetto debbono prestare
una cauzione non minore di ducati mille (Art. 8).
I facchini addetti al servizio della Dogana vengono
contraddistinti da una medaglia che portano sospesa al
petto, la quale pe’ capi e sottocapi è di ottone, e pe’
facchini di rame, secondo apposito modello (Art. 6).
Alla legge doganale va annessa una tariffa che determina
i prezzi da pagarsi ai facchini, i quali (come dicemmo)
esclusivamente, e non altri, esser debbono impiegati al
servizio delle dogane, e laddove si denegassero a
prestarlo al prezzo nelle tariffe fissato, vengono
congedati e cancellati dai ruoli (Art. 10, 11 e 12).
Della morte o dimissione d’un facchino, il capo o
sottocapo è obbligato dar parte a’ suoi superiori fra lo
spazio di otto giorni, restituendone la patente e la
medaglia, sotto pena, in caso d’inadempienza, di essere
cancellato da’ ruoli (Art. 13).
317. Prova della smisurata, e direi quasi favolosa,
forza onde sono dotati i sangiovannàri è la
processione de’ gigli, per noi sopra descritta, ma ancor
meglio e co’ propri occhi può assicurarsene chiunque
voglia trasferirsi un momento alla Gran Dogana ed
osservare gli enormi pesi che trasportano
quotidianamente, e sempre sovra una sola spalla; ed io
sono stato assicurato, da persone del luogo molto degne
di fede, siccome un solo di cotesti facchini giunga
talvolta a sollevare (avvegnaché a poca distanza) non
meno di quattro cantàia (il cantàio o cantàro
corrisponde a circa 90 Kg).
318. Il numero de’ facchini napolitani, secondo il
risultamento statistico compreso nella Guida, non molti
anni addietro compilata per gli scienziati, col titolo
“Napoli e luoghi celebri delle sue vicinanze”, si fa
montare alla cifra di 4198. Ciò dimostra come questa
indùstre ed utilissima classe sia abbastanza
considerevole …”
Nel 1824, i gigli
diventano due
319. Così stando dunque le cose, non fa meraviglia che
un gruppo di Barresi, “sangiovannàri” di mestiere, abbia
potuto pensare di fare anche a Barra, e per S. Anna,
quello che da tempo si faceva a Nola per S. Paolino.
L’idea ebbe subito un certo successo, tanto è vero che …
320. Lettera del Sindaco alla Règia Intendenza del 20
giugno 1824: “… costruzione, come già in altro luogo di
Barra, di una macchina di legno, obelisco o similare,
detta giglio, da costruirsi nello slargo della strada di
Sopra …”
Delibera di Giunta Municipale n°47 del 28 giugno 1824:
“… approvazione di costi per ducati 58 per la
riparazione di un tratto della strada Parrocchia, per
l’imminenza della processione della Patrona e per il
transito di due castelletti di legno denominati gigli …”
Delibera di Giunta Municipale del 20 luglio 1824: “… nel
tratto della strada Parrocchia e strada di Sotto … lo
stesso dalla strada di Sopra alla tenuta dei Principi
Spinelli … togliere quattro fanali nell’eseguire
processione della Santa Patrona con al seguito
castelletti di legno denominati gigli. La Giunta
delibera affidare l’incarico all’inserviente comunale
Benito Ascione a cui verranno rilasciate grana 86 …”
321. Già nel 1824, dunque, i gigli diventano due, perché
un secondo giglio viene costruito “nello slargo della
strada di Sopra” e si aggrega alla processione di S.
Anna per il tratto “dalla strada di Sopra alla tenuta
dei Principi Spinelli”.
Lo “slargo” era quello posto fra la Villa Pignatelli di
Monteleone ed il Convento dei Padri Domenicani; e il
“tratto” era quello che andava dallo “slargo” suddetto
fino al Palazzo Spinelli.
Il giubileo del 1825: un
terzo giglio?
322. Sappiamo che nel 1825 “avemmo il giubileo dell’anno
santo”,
che vide Barra al
centro di tutta la zona ad oriente di Napoli: infatti …
“le chiese che si dovettero visitare (per ottenere le
indulgenze) furono: la parrocchia di S. Giorgio, la
parrocchia della Barra, S. Domenico e S. Antonio
parimenti della Barra...”[104].
In quell’anno 1825 si ebbe quindi a Barra un notevole
afflusso di persone provenienti dai Comuni vicini e
questo certo non mancò di avere positive conseguenze
anche sulla piccola economia locale, aumentando la
disponibilità dei Barresi a spendere per le loro feste.
323. Si può perciò ipotizzare che già nel 1825 i gigli,
sia pure solo occasionalmente, divennero tre,
aggiungendosi ai due pre-esistenti un giglio costruito
abbàscio Serìno.
In questo modo, tutta la strada principale del paese
risultava suddivisa in tre parti, in ognuna delle quali
vi era un giglio che accompagnava la processione di S.
Anna e poi ritornava al suo ‘mpuosto.
Di questo terzo giglio non si hanno però documentazioni
certe, ed ancora nel 1829 i gigli sembrano essere
soltanto due, perché due sono i capi-paranza convocati
dalle autorità (vedi oltre, n°326).
Probabilmente, quindi, i gigli divennero stabilmente
tre solo a partire da quell’anno 1840, di cui diremo fra
breve.
L’opposizione dei parroci
di S. Anna
324. Fin dall’inizio, l’intervento di queste “macchine
lignee, dette gigli, similari a Nola” nella processione
della Santa patrona non riuscì gradito ai Parroci di S.
Anna dell’epoca e cioè prima Don Gaetano Ascione
(1806-1825), poi Don Alessandro Russo (1825-1837)
e, dopo la morte di quest’ultimo nell’epidemia di
colera, Don Giuseppe Minichino (1838-1848).
325. Come mai questa opposizione? Varie ragioni possono
ipotizzarsi.
I parroci, come è comprensibile, temevano forse che la
“strepitosa marcetta” del giglio potesse disturbare il
clima di raccoglimento e di preghiera opportuno per la
processione.
Ad essa, peraltro, già partecipavano le storiche
confraternite post-tridentine Barresi
[105], ben organizzate e disciplinate, le
quali probabilmente, dal canto loro, non vedevano alcuna
necessità di importare tradizioni religiose “straniere”
come quella di S. Paolino da Nola.
A Barra, inoltre, non sembra essere mai esistita, come
invece a Nola, una organizzazione su base corporativa,
nemmeno nelle confraternite
[106] e quindi verosimilmente alcuni,
soprattutto all’inizio, videro il giglio solo come un
sistema attraverso il quale i facchini-sangiovannàri
intendevano auto-esaltarsi, mettendo in evidenza,
anche a scopo “pubblicitario”, le “qualità” della
categoria (vedi sopra, n°295 e segg.).
Né può trascurarsi il fatto che la raccolta di soldi fra
la gente del paese per costruire i gigli veniva, di
fatto, a trovarsi in concorrenza con la questua e le
offerte per la processione di S. Anna … e le altre che
allora si facevano in Barra (almeno altre 5 processioni,
secondo gli Atti di Santa Visita del 1837).
Per una popolazione di circa 6000 abitanti
[107], pur volendoli considerare tutti
relativamente benestanti, pii e generosi, era comunque
un po’ troppo …
326. Sembra quindi che i parroci si siano rivolti alla
Curia e, tramite questa, alle superiori autorità civili,
“per far cessare il seguire con castelletti di
legno di più metri la processione della Patrona del
Comune, Sant’Anna”.
Non sappiamo con precisione come siano andate le cose.
Sta di fatto, però, che il 10 ottobre 1829, il Sindaco
di Barra scrive una lettera al Règio Intendente (=
l’equivalente del Prefetto nel periodo borbonico), per
informarlo di aver ufficialmente “richiamato” i
capi-parànza:
“Signore, rispondo alla sua del 4 andante. Sono stati
chiamati, alla mia presenza e quella del Delegato della
Guardia Nazionale, i Capi-parànza Russo Cristofaro e
Raffaele Perna, in data 8 ottobre, per far cessare,
come voluto dalle Superiori Autorità, il seguire con
castelletti di legno di più metri la processione della
Patrona del Comune Sant’Anna. Resto in attesa di sue
disposizioni dopo quanto il Delegato le dirà a voce. Con
ossequi”.
La transizione: 1830-1840
327. Anche in questo frangente, data l’assenza di
documenti, non sappiamo che cosa sia esattamente
accaduto alla festa barrese, subito dopo quel divieto
delle “Superiori Autorità” ed in tutto il successivo
decennio 1830-1840.
328. Nel 1836-37 vi fu la micidiale epidemia di colera
della quale abbiamo diffusamente parlato
[108] dopo la quale si ebbe però una rapida
ripresa demografica ed economica, introducendosi fra
l’altro in Barra, su larga scala, l’arte della seta
[109] ed è di quel periodo anche la prima
fioritura industriale in tutta la zona costiera ad
oriente di Napoli
[110].
329. Nel 1839, secondo le parole del Settembrini (vedi
sopra, n°246), vi furono in Napoli tre cose belle: la
ferrovia, l’illuminazione a gas e Te voglio bene
assaje.
Tutte e tre queste cose, ciascuna a suo modo,
riguardarono ovviamente anche Barra, tanto più che nel
1840 venne anche fondato l’opificio di Pietrarsa, che
era la più grande industria metalmeccanica della
penisola,
con più lavoratori che in
qualsiasi altro simile stabilimento nell’Italia
pre-unitaria.
Non meraviglia perciò che, in questo contesto di
relativo benessere e di maggiore serenità, la festa
barrese abbia potuto avere un nuovo, e più solido,
inizio.
Il cruciale 1840: i gigli
“di S. Antonio”, a settembre
330. Di certo, negli “Avvenimenti del Convento dei Frati
minori” dell’anno 1840, troviamo scritto: “… è anche
la prima volta che è effettuata la processione della
statua di Sant’Antonio di Padova nel mese di
settembre, oltre quella di giugno, per le vie di
Barra, per benedire i Gigli di Sant’Antonio …
previa autorizzazione (richiesta)
all’Archidiocesi di Napoli …”
331. Sembra quindi che i “giglianti” barresi, respinti
da S. Anna nel 1830, siano stati accolti da S. Antonio
di Padova nel 1840 …
I Frati del convento barrese, previa autorizzazione
della Curia Arcivescovile di Napoli, e presumibilmente a
fronte di una modesta elemosina per l’occasione,
organizzarono addirittura una nuova processione
con la statua del Santo, oltre quella che già
normalmente si svolgeva il 13 giugno, con lo scopo
preciso di “benedire” i gigli, da allora definiti “gigli
di S. Antonio”.
332. Sempre a partire da allora, la festa si svolse
nell’ultima domenica di settembre.
Varie ragioni si possono addurre per questo cambio di
data: da una parte, visti i precedenti, bisognava
ovviamente abbandonare la data del 26 luglio (S. Anna);
d’altra parte, la maggior parte della popolazione, da
maggio a settembre, era impegnata nella lavorazione
della seta (vedi sopra, n°328) e risultava naturale
porre la festa a conclusione del periodo di lavoro più
intenso; infine, ma non per ultimo, siccome la struttura
lignea ed il rivestimento in cartapesta del giglio
provenivano da Nola, “fare la festa in settembre era
molto più agevole per i costruttori nolani … finita la
festa a Nola (il 22 giugno) essi dovevano infatti
smontare i loro gigli ed iniziare il trasporto per
l’allestimento a Barra: per il solo trasporto dei
materiali, che avveniva con carri trainati da buoi,
occorrevano circa 15 giorni, e quasi una settimana per
la costruzione …”
[111].
Cenni riassuntivi sulla
festa nel periodo borbonico
333. Con il 1840, siamo dunque di fronte ad un “nuovo
inizio” della festa barrese, che manterrà poi la sua
forma standard per tutto il restante periodo
borbonico 1840-1860:
-
tre gigli (Abbàscio Serìno, Mmiez’a’parrocchia,
‘Ncopp’a’Barra), uno per ogni tratto della
strada, principale ed unica, dell’abitato;
-
costruiti con materiali, e gran parte di mano d’opera,
nolani;
-
che vanno man mano slanciando ed innalzando la loro
forma;
-
e con una banda musicale, collocata sulla prima “cassa”
del giglio, ad accompagnare, senza canzoni né cantanti,
la semplice marcia dei portatori.
334. Di specificamente barrese, troviamo il fatto che
ogni giglio ha due “caporali”
[112], uno davanti e l’altro indietro, che
coordinano i movimenti della paranza, soprattutto nei
due momenti cruciali dell’aìza! e del posa!
nei quali il giglio viene, lentamente, alzato e posato
da/a terra.
Dalla biografia di Don Raffaele Verolino, scritta dal
Parroco Guida, veniamo inoltre a sapere che nel 1842
venne fondata a Barra la Banda musicale del Comune,
e questo, ovviamente, aumentò la quantità e la qualità
dei “suonatori” barresi.
335. Fin dall’inizio, si possono quindi evidenziare
alcune caratteristiche specifiche che
distinguono/identificano la festa di Barra nel contesto
delle feste sorelle, come scrive Francesco Manganelli,
opportunamente citato da Romano Marino
[113]:
“A Baiano, il maio (giglio) è naturalmente cresciuto,
cioè il solo albero; a Nola, è manufatto cioè
costruito; a Barra, è importato.
A Baiano, è nudo; a Nola, è adornato ed
occultato; a Barra, è funzionale vale a dire
animato dai portatori.
A Baiano, è uno per tutti, cioè uno solo per
tutta la cittadinanza; a Nola, è uno per ciascuna
delle 8 corporazioni; a Barra, uno per ogni
comitato.
Intorno al maio, a Baiano abbiamo quindi coesione;
a Nola, coesione nella processione; a Barra,
rivalità.
A Baiano, vi è il maio ritto e fermo; a Nola, è
in processione; a Barra, c’è la ballata dei
gigli.
A Baiano, è dedicato a S. Stefano; a Nola, a
S. Paolino; a Barra, il giglio è la festa”.
I gigli a Barra dopo
l’unità d’Italia (1860-1900): da tre a cinque
336. Dal punto di vista puramente istituzionale, il
Comune liberale e sabàudo continuò sostanzialmente a
fare ciò che già faceva il Comune borbonico e cioè
pagare gli straordinari: alle guardie municipali e
campestri, per il mantenimento dell’ordine pubblico; ed
agli “accenditori”, per togliere e poi rimettere i
fanali che potevano ostacolare il percorso dei gigli.
Tuttavia, dopo il 1860, si rilevano nella festa alcune
modificazioni più o meno significative.
337. La prima, riguarda il numero dei gigli, che da tre
tende ad aumentare a quattro ed a cinque.
Un quarto giglio sembra sostanzialmente stabilizzarsi
già a partire dal 1863, ed è quello della commissione
Mmiez’a’‘rucella, di cui si ricorda, come uno dei
caporali, un tal Pasquale Borriello ‘o baccalaiuòlo,
il che quanto meno evidenzia che ormai la festa si era
sganciata dall’originario legame con la sola categoria
dei facchini, per divenire più largamente popolare.
I gigli divennero occasionalmente 5 in alcuni anni, ma
restarono sostanzialmente 4 fino al 1885, quando si
aggiunse stabilmente, come quinto giglio, quello
costruito For’‘o vico (di S. Lucia, attuale Via
Gian Battista Vela) ovvero sul Corso Sirena più o meno
all’altezza dell’attuale Traversa Spinelli, che allora
però non c’era
[114].
I gigli a Barra dopo
l’unità d’Italia (1860-1900): il Corso … e il percorso
338. Come abbiamo già altrove
scritto
[115], nel 1875 venne attribuito il nome unico di
“Corso Sirena” alla strada principale, che prima di allora si era
chiamata in modo diverso nei suoi diversi tratti, dopo
aver provveduto alla sua nuova sistemazione con il
tipico “basolato” in pietra vesuviana ed al totale
rifacimento del fondo stradale da Monteleone a Piazza
Serino, “profondandosi anche per la costruzione del
blocco di fogna stradale”.
Questo evento urbanistico del 1875
segnò necessariamente anche la festa, almeno nel senso
di facilitarne e stabilizzarne il percorso, che fino a
quel momento era stato anch’esso a tratti variabili:
adesso, ogni giglio, ovunque fosse stato
costruito, doveva obbligatoriamente percorrere tutto
il Corso, prima di ritornare al suo posto iniziale,
ponendo mente a lasciar passare, negli slarghi
del Corso stesso, il giglio che proveniva in senso
inverso.
Ogni “commissione”, accompagnata dalla banda musicale,
percorreva inoltre tutto il Corso per
“annunciare” che, nel settembre successivo, avrebbe
“fatto il giglio”; ed il sabato della festa, allo stesso
modo, ogni commissione andava lungo il Corso a
salutare ed augurare buona festa alle altre.
I gigli a Barra dopo
l’unità d’Italia (1860-1900): canzoni e cantanti
339. Un’altra modifica significativa: non c’è più solo
la banda musicale che suona marcette (vedi sopra, n°293)
ma cominciano ad esserci canzoni e cantanti.
Se l’anno del bing-bang (vedi sopra, n°256) della
canzone d’autore napoletana è il 1880, quello della
canzone d’autore barrese è solo di poco posteriore.
Risalgono infatti al 1882 le prime canzoni di cui si
abbia notizia:
-
‘A festa
(versi di Gennaro Punzo; musica di Eduardo Petrone)
presentata dalla commissione “Parrocchia”;
-
‘O giglio chiù bello
(versi di Salvatore Busiello; musica di Gaetano Testa)
presentata dalla commissione “Abbàscio Serìno”.
340. Riportiamo di seguito il testo integrale di ‘A
festa:
Stace tutta ‘ncannaccàta stammatìna,
me pare na pupàta ‘e seta fine,
te si vestùta allicchètto e saccio lo perché:
sapive ca j’ venevo a piglia’ a tte,
pecché ogge te porto nzieme a me,
scennìmmo miezz’’a gente j’ e tte.
M’aggio miso lu cappiello, saje pecché:
stu juorno tutt’’e dduje hamma cumpare’.
Nannì,
vien’ cu’ mico,
te porto a verè ‘a festa for’’o vico,
sta festa st’anno m’hadda cunzula’.
‘A vera festa d’’e giglie è chesta ccà!
Vedìmmo sti bellìzze po’ paese,
pittàte cu’ e culùre cchiù sbrennènte.
‘E cummissiòne n’hanno baràto a spese.
Stamme a senti’ Nannì … meh, bieneténne.
‘Uarda quant’allerìa e c’armunìa:
no giglio saglie e n’ato scenne ‘a llà.
Azzìccate vicino mmiez’ a’ folla,
accuòstate cchiù a me ‘nto votta votta;
e si me daje nu vaso mpont’’o musso
so j’ ca po’ me faccio russo russo.
Ma sti gigli t’hanno frasturnàta
e nun me faje manco na ‘uardata.
Nannì, Nannì,
si ‘a meglia figliòla
e ‘o core mio è sperzo pe st’ammore.
Nannì,
saje che te dico: si tu vuo’ bene a me,
l’anno che vène faccio nu giglio pe tte!
Me strigne ‘a mano, si felice oj ne’!
D’’e giglie so patùto e saje pecché:
‘a meglia ‘a meglia fémmena
tenco vicino a mme!
Napoletani e Barresi
341. Del successivo anno 1883 è una “copiella” recante
la canzone “Vien’alla parrocchia” (versi di L.
Veneruso; musica di P. Borriello), presentata appunto
dalla commissione “Parrocchia”, il cui responsabile in
quell’anno risulta essere Geremia Gargiulo detto ‘o
vuttàro (evidentemente, un costruttore/venditori di
botti).
342. A partire dunque dagli anni Ottanta, si
intrecciano, nella festa, canzoni e cantanti napoletani
e canzoni e cantanti barresi, fino a che, nel nuovo
secolo, questi ultimi diverranno nettamente prevalenti.
 |
Il nuovo secolo |
343. Gli autori napoletani sono fra i più illustri, come
i parolieri Pasquale Cinquegrana e Aniello Califano
(vedi sopra, n°275) ed i musicisti Salvatore Gambardella
e Vincenzo Valente (vedi sopra, n°283):
Del 1895, è I’ voglio bene a tte! (versi di
Pasquale Cinquegrana; musica di Salvatore Gambardella),
presentata dalla commissione “Rione aristocratico” (‘Ncopp’
a’ Barra).
Del 1898, ‘A tarantella d’’e pacchianiélle (versi
di Aniello Califano; musica di Gaetano Taranto),
presentata dalla commissione “Abbàscio S. Anna”.
Del 1899, Seh! Seh! (versi di Pasquale
Cinquegrana; musica di Vincenzo Valente), presentata
dalla commissione “Abbàscio Serìno”.
344. Ma si apriva ormai, non solo per la festa, il nuovo
secolo, il XX, il secolo “del progresso, della scienza e
della tecnica” … e di due guerre mondiali.
[93] Vedi
n°41 in “Il periodo liberale dal 1887 al 1896”.
[95] Vedi
nn°164-169 in “Il periodo liberale dal 1876 al
1887”.
[96] Luna
nova (1887): versi di Salvatore Di Giacomo,
musica di Mario Costa.
[97]
Romano Marino – “Tradizionale festa dei gigli di
Barra”, Vol. I (1800-1954) e Vol. II
(1955-2000), Tip. La Laurenziana, Barra, 2004.
[98] Vedi
n°353 in “Il periodo borbonico dal 1790 al
1860”.
[99] Vedi
n°197 in “Il periodo liberale dal 1860 al 1876”.
[100]
Vedi n°189 in “Il periodo liberale dal 1860 al
1876”.
[101]
Vedi nn°190-192 ibidem.
[102]
Karl August Mayer – “Vita popolare a Napoli
nell’età romantica”, 1840.
[103]
Ferdinand Gregorovius - “Pellegrinaggi in
Italia”, 5 Volumi, pubblicati dal 1856 al 1877).
[104]
Vedi nn°356-358 in “Il periodo borbonico dal
1790 al 1860”.
[105]
Vedi nn°117 e segg. e nn°194-198 in “Il periodo
del Viceregno spagnolo nel 1500”; nn°130 e segg.
in “il periodo del Viceregno spagnolo nel 1600”.
[106]
Vedi n°131 in “Il periodo del Viceregno spagnolo
nel 1500”.
[107]
Vedi n°429 in “Il periodo borbonico dal 1790 al
1860”.
[108]
Vedi n°360 e segg. ibidem.
[109]
Vedi n°401 e segg. ibidem.
[110]
Vedi n°414 e segg. ibidem.
[114]
Vedi n°54 in “Il periodo liberale dal 1887 al
1896”.
[115]
Vedi nn°195-197 in “Il periodo liberale dal 1860
al 1876”.