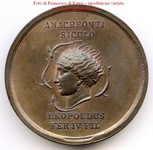|
“Sta
Minsogna Saracina
cu sta
giubba mala misa
trova cui
pri concubina
l’accarizza,
adorna e spisa.
E
cridennulla di sangu,
Come
vanta, anticu e puru,
d’introdurla in ogni rangu
si fa
pregio non oscuru”
Con questi
versi
Giovanni Meli
, poeta siciliano
(1740-1815) commenta un episodio a lui contemporaneo che da molti
storici è stato dimenticato o talvolta ricordato solo per puro
divertimento, tralasciandone l’enorme valenza “politica”. Il “fatto”
ebbe luogo sul finire del settecento e in concomitanza con la presunta
congiura giacobina del giovane avvocato Di Blasi
che, sulla spinta
delle nuove idee riformiste, sperava di rinnovare gli ordinamenti del
Regno, e porre termine alle usurpazioni e agli arbitri dell'aristocrazia
isolana.
Un episodio,
come vedremo, che è assai più di una semplice impostura a scopo di lucro
ma qualcosa che avrebbe potuto influire sullo stato giuridico del Regno
di Sicilia.
La storia, si
svolge tra il 1782 e il 1795, ed ha come sfondo una Sicilia percorsa da
fremiti illuministici. L’isola, e Palermo in particolare, assieme a
Napoli e Milano, fu
tra le prime in Europa a conoscere e recepire le nuove idee che
provenivano dalla Francia. Sia per merito dei viaggiatori del Gran
Tour, sia per la presenza di numerosi precettori francesi, quasi un
obbligo per le famiglie aristocratiche o solamente ricche. I salotti
palermitani erano frequentati da intellettuali che avevano assidue
corrispondenze con gli intellettuali napoletani e d’oltralpe e libri e
giornali circolavano facilmente grazie anche alla rete di trasporti via
mare che in quel periodo si sviluppava ed affermava in tutto il regno.
La nostra
storia si svolge in massima parte mentre era Vicerè il
Caracciolo, illuminista e riformatore, nemico giurato della nobiltà
feudale siciliana di cui voleva abolire i privilegi, e che per ovvi
motivi lo ricambiava con pari inimicizia e antipatia.
L’arabica
impostura si deve al “genio” di un oscuro ma intraprendente frate,
Giuseppe Vella, originario di Malta dove, dopo aver seguito studi
teologici e di varia umanità, entra nell’ordine Gerosolimitano e diventa
sacerdote. Vella arriva a Palermo nel 1780 dove usufruisce di un legato
perpetuo di messe quotidiane ereditato da una zia suora e non fa certo
una bella vita costretto come è a sbarcare il lunario “vendendo” numeri
del lotto ai concittadini dei quartieri poveri.
Uno storico
dell’epoca, Domenico Scinà, lo dipinge come un perfetto ignorante che
«con accento maltese pronunziava un bastardume di linguaggio arabo, anzi
una lingua tutta propria di lui»
; in realtà che il
Vella ignorasse totalmente l’arabo, come sostiene Scinà, e altri suoi
detrattori, è improbabile. Certamente, come ritiene il Lagumina
«qualche cosa dovea
saperne, e quel che sapea, non potea apprenderla qui da noi» ma a
Malta dove era in uso una specie di dialetto arabo-maghrebino scritto in
caratteri latini, per cui quasi certamente l’abate capiva e parlava
l’arabo ma non sapeva leggerlo e scriverlo. E’ utile ricordare a questo
punto della storia che nessuno o quasi, a Palermo, conosceva l’arabo né
molto si sapeva di quel periodo storico in cui la Sicilia faceva parte
dell’enclave musulmano. La conquista normanna per conto del papato e la
forzata riconversione al cristianesimo avevano cancellato la memoria
storica di quello che indubbiamente fu uno dei più opulenti periodi
della storia dell’isola.
|
 |
San Martino delle Scale. Complesso abbaziale
benedettino fondato da Papa Gregorio Magno nel VI secolo,
distrutto nell'837 dagli Arabi, riedificato nel 1347 dal
benedettino Angelo Sinisio e dedicato a San Martino, vescovo
di Tours |
Ma ad un
certo punto il nostro frate viene baciato dalla fortuna. Questa si
presenta sotto le vesti di un ambasciatore marocchino che, dopo un
naufragio, il 17 dicembre 1782, è costretto a sbarcare sulla costa
palermitana e a trascorrere in città il tempo necessario a organizzare
la ripresa del suo viaggio. L’ambasciatore non parla italiano e l’unico
che può fargli da interprete è Giuseppe Vella che, intuendo che quella
può essere l’occasione della sua vita, accetta l’incarico
L’intraprendente frate, col suo maltese e forse un po’ di arabo, gli fa
da interprete e lo accompagna nei salotti importanti e nei circoli
culturali e politici di Palermo, dove si conquista grazie alla sua
millantata conoscenza dell’arabo, la stima di Monsignor Airoldi,
appassionato orientalista, e in vari luoghi d’arte e cultura della
città, tra i quali il monastero cassinese di S. Martino delle Scale,
dove sono custoditi vari codici arabi.
Il frate,
resosi conto che nessuno nella Palermo che allora contava conosceva
l’arabo e che le parole dell’ambasciatore restavano per tutti
incomprensibili, dà spiegazioni arbitrarie di quel che il dignitario
marocchino dice circa i manoscritti conservati nell’abbazia, lasciando
credere che si tratti di importanti documenti e si impegna a tradurre
egli stesso i codici non appena ne avrà il tempo.
Dopo la
partenza dell’ambasciatore marocchino, “rivela” che uno dei manoscritti
arabi conservato a San Martino e che in realtà contiene una vita di
Maometto, sia un fondamentale testo storico-politico: “Il consiglio
di Sicilia”, una sorta di registro della cancelleria araba in
Sicilia, dunque un preziosissimo documento della dominazione musulmana
sull’isola, allora molto povera di testimonianze storiche scritte.
Inizia così
la “grande impostura” dell’abate Vella: dapprima con un lavoro minuzioso
di modifica dei caratteri del codice, inventandosi una lingua del tutto
nuova: i caratteri mauro-siculi, con i quali corrompe il testo
originario e poi con la “sua” traduzione in italiano, inventata di sana
pianta.
Dal nulla o
quasi, Vella crea l'«intera storia dei musulmani di Sicilia». Colma i
vuoti lasciati dalle poche notizie degli storici. Ma quello che è più
importante è che la sua narrazione rende illegittimi i tentativi di
riforma dei vicerè Caracciolo che mirava ad assimilare il diritto
pubblico siciliano al diritto continentale, contro i privilegi dei
feudatari siciliani fondati su diritti patrimoniali quasi sempre nati
dall'usurpazione e la falsità. Una prova storica della inammissibilità
delle “caracciolate” come sdegnosamente i nobili siciliani chiamavano i
tentativi di ammodernamento del regno e la limitazione dello strapotere
baronale.
Realizza
quindi un’opera di traduzione di pura invenzione e la sottopone a vari
uomini colti, tra cui il regio storiografo Giovanni Evangelista di Blasi
e monsignor Alfonso Airoldi, giudice dell’apostolica legazia e suo
mecenate. Il contenuto del codice documenta secondo il Vella le imprese,
l’amministrazione, il diritto pubblico degli arabi in Sicilia.
L’argomento entusiasma gli interlocutori, anche per evidenti motivi
politici infatti «entrambi trovavano nel codice “tradotto” dal Vella
argomenti decisivi contro la tesi napoletana che “riguardava a’ soli
tempi normanni come a principio di pace, di libertà di legislazione”
e mirava ad assimilare
il diritto pubblico siciliano al diritto continentale. Dal codice
tradotto dal Vella si evinceva che non erano stati i Normanni a fondare
la storia moderna della Sicilia ma gli Arabi. Da qui l’uso politico del
“codice” che avrebbe potuto sottrarre all’influenza di Napoli i nobili
siciliani. Analizzando questo aspetto dell’impostura riesce difficile
credere che il Vella abbia architettato tutto da solo. E’ facile invece
presumere che l’aristocrazia siciliana, nelle persone che allora
contavano, tenesse corda all’intraprendente abate. Il Vella pensa a
questo punto di aver trovato la sua gallina dalle uova d’oro e infatti
comincia a ricevere benefici, viene promosso abate e per lui viene
creata una cattedra di Arabo all’Università e nel 1792 il suo Codice
diplomatico di Sicilia sotto il governo degli Arabi viene pubblicato
dalle stamperie reali. Di li a poco il Codice è tradotto in
tedesco e se ne comincia a parlare in tutta Europa.
Non contento
di ciò, o forse cosciente che il Consiglio di Sicilia avrebbe
potuto inimicargli la corona, sulla scia del “cerchiobottismo” ancora
oggi seguita dai nostri politici e non solo, letteralmente fabbrica un
nuovo codice, che dice di aver successivamente trovato, che chiama
“Il Consiglio d’Egitto”, sempre scritto in quella sua particolare
lingua che avrebbe dovuto essere arabo e anche di questo fornisce la
traduzione. In questo codice si tratta della corrispondenza epistolare
tra Roberto il Guiscardo, il
Conte Ruggero,
Re Ruggero e i sultani d’Egitto.
Questa
seconda impostura, come abbiamo detto, ha lo scopo di attirare
l’attenzione e la benevolenza della Corona e dimostra al Re che la
nobiltà detiene un potere che non le è dovuto e che il Sovrano è il solo
ad aver diritto a quei privilegi che i nobili e la Chiesa di Sicilia
hanno sempre considerato loro appannaggio.
Ma ha passato
il limite, l’abate. Tra i Siciliani comincia a serpeggiare il dubbio,
soprattutto da parte dello storiografo regio Rosario Gregorio, o meglio
comincia ad emergere ciò che già si sapeva, che l’Abate Vella abbia
ingannato sia i nobili che il Sovrano, che non conosca l’arabo e che sia
autore di una truffa colossale, tanto che il Gregorio intraprende lo
studio dell’arabo, per meglio rendersi conto della autenticità o falsità
dei Codici.
Ma la
pubblicità attorno ai codici è stata troppa e i dubbi sulla loro
autenticità si moltiplicano. Giuseppe Hager, docente di arabo a Vienna,
di passaggio a Palermo nel 1794, chiede di vedere il famoso codice
martiniano, ma riceve un ambiguo anche se netto rifiuto. Ne parla col
Gregorio e ne informa il Caramanico, che nel frattempo era subentrato al
Caracciolo, che a sua volta avvisa a Napoli il ministro Acton; le voci
che i codici siano una invenzione si rafforzano e l’avallo fornito da
Hager mette in allarme la corte di Napoli; per evitare che il
prevedibile scandalo sia fatto esplodere dall’estero, con evidenti
ricadute negative per l’immagine del governo napoletano, l’Acton rimanda
lo Hager a Palermo, questa volta per un’inchiesta ufficiale
sull’autenticità dei codici. Hager a questo punto richiede ufficialmente
i codici per poterli esaminare, ma il Vella, ormai alle strette, finge
un furto e denuncia la scomparsa di tutti i manoscritti. Nessuno poteva
credere ad un così provvidenziale furto e questo diede a molti la
certezza della truffa. Il Vella a questo punto si finge malato, poi,
miracolosamente guarito, supplica di poter andare in Marocco per
recuperare i documenti autentici rubati ma ormai nessuno gli crede più.
Viene arrestato e il suo segretario, minacciato di tortura, svela
l’inganno; nonostante un maldestro tentativo dei suoi amici di salvare
l’autenticità almeno del Consiglio di Sicilia, la perizia
dello Hager e le prove della contraffazione
, accertate durante il
processo, portano il Vella ad una condanna a 15 anni, poi commutata in
arresti domiciliari nel suo casino di campagna di Mezzomorreale, dove
muore nel maggio del 1815.
Le modalità
dell’«arabica impostura» sono ben illustrate nella perizia di Hager e in
quella di monsignor Adami, arcivescovo di Aleppo esperto conoscitore di
Arabo chiamato come perito dal Re.
|
 |
San Martino delle Scale |
Il codice
martiniano, scrive l’Hager, «è talmente falsificato mediante
caratteri nuovi soprapposti, inchiostro recente, ed innumerabili lineole,
e punti oziosi insertivi, che dà a vedere ad ogni conoscitore lo sforzo
malizioso di voler renderlo inintelligibile per così velare più
facilmentemle sue fallacie […] la sua cura maggiore sembra essere stata
quella di artifiziosamente corrompere, anzi di perfettamente cancellare
ciò che prima conteneano […] e dalla carta, e dallo stile italiano, e
dagli errori e di lingua e di ortografia, e dalle idee europee, che
niente annunziano di orientale, e dalle parole aggiunte ne mostra chiara
la falsità». (Hager, Notizia riguardante una singolare impostura)
E l’Adami: «1.
Consta ad evidenza non essere stato il Codice detto Martiniano in
caratteri Cufici o Maoritani, ma elegantemente in caratteri Arabi
Orientali, come sono in uso fino al presente appresso i Muslimani, ed in
una frase, e sintassi proprie della pura lingua Araba. 2. Si rileva
evidentemente esser questo Codice interpolato e corrotto maliziosamente
con linee, e punti sopraposti da mano recente ed estera specialmente
nella prima pagina, e col cassare totalmente le chiamate solite delle
pagine per renderlo quasi illeggibile, e così coprire la impostura della
pretesa traduzione […] si conosce evidentemente essere questo Codice una
collezione di vari Autori Muslimani continente la nascita del loro
profeta Maometto e la storia dei suoi ascendenti, discendenti, famiglia,
schiavi, viaggi, carteggio, guerre, vittorie, discepoli, seguaci,
profezie, morte del medesimo falso Profeta […] contenere questo Codice
tutt’altro, che la pretesa storia di Sicilia […] l’altro codice detto
Normanno […] essere questo una traduzione dalla lingua italiana, una
lingua
araba
corrottissima; ad essere più gli errori grammaticali, che le medesime
parole, non essendovi alcuna concordanza di casi di generi, di tempi e
di persone […] Si vede inoltre una conformità e total consonanza nei
termini, nella frase, costruzione dei periodi; finalmente negli stessi
errori di grammatica, e di ortografia del carteggio, che si finge essere
passato tra i Principi Roberto e Roggero, e gli Califi dell’Egitto,
quasi che fosse la stesso persona che scriveva dall’Egitto, e rispondea
in Sicilia, e viceversa».
(Lagumina, Il falso Codice)
Analizzando
oggi questa magistrale truffa certamente siamo portati a pensare che non
poté essere solo farina del sacco dell’abate Vella. La falsificazione de
“Il Consiglio di Sicilia” fu forse idea originale del Vella e servì ad
aprirgli le porte dei salotti bene dell’epoca, ma il successivo
“Consiglio d’Egitto” nacque quasi certamente con l’appoggio dei
riformisti caracciolani. Aveva infatti lo scopo di correggere il tiro,
di colpire la feudalità siciliana e rafforzare l’autorità della corona
in linea con il vento di riformismo moderato propugnato dal Caracciolo e
dagli illuministi di casa nostra, siciliani e napoletani.
Ma come ben
sappiamo ebbe la meglio poi il vento di restaurazione nelle vesti
dell’arcivescovo di Palermo e Monreale,
Filippo Lopez y Rojo, che alla morte del vicerè Caramanico, subentrò
in qualità di amministratore unico. Sono anni cupi, di arresti e di
processi contro persone che fino a qualche mese prima avevano
collaborato con Caracciolo prima e
Caramanico dopo. In concomitanza
con il processo e la condanna di Vella si svolge anche il processo e la
condanna esemplare, per decapitazione, di Francesco Paolo Di Blasi,
collaboratore, come abbiamo già detto, di Caracciolo e Caramanico.
L’arabica
impostura non fu comunque senza conseguenze perché, se non altro, aprì
la strada agli studi dell’arabo e della storia dei musulmani di Sicilia.
Il Gregorio iniziò lo studio dell’arabo e della storia islamica per
smascherare il Vella ma trasmise la passione per questi studi ai suoi
allievi fino ad arrivare all’Amari e alla creazione dell’Università
degli Studi l'Orientale che è ancora oggi vanto di Napoli.
Fara Misuraca
novembre 2007
Bibliografia
-
Giuseppe
Giarrizzo Cultura ed Economia nella Sicilia del Settecento,
Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1992
-
-
Paolo
Preta, Storie di falsi e di falsari, rivista di Storia
mediterranea, edizione internet
-
Leonardo
Sciascia, Il Consiglio d’Egitto, Einaudi, Torino 1963
Note
Giovanni Meli, Gazetta problematica relativa all’impostura di
lu codici arabu di l’abbati Vella, citata in Bartolomeo
Lagumina, Il falso
codice arabo-siculo,
«Archivio storico siciliano» n.s., V (1880), pp. 232-314: 251 ,
riportato da Paolo Preta in Storia di Falsi e di falsari.
Giovanni Meli (Palermo, 1740-1815) nasce da famiglia modesta.
Studia per alcuni anni grammatica, retorica, metafisica dai
padri gesuiti. Nel 1760 è ammesso nell'Accademia
del buon gusto, comincia a comporre versi, prima in
italiano, poi in siciliano. In seguito intraprende lo studio
della chimica e della medicina e diviene medico a Cinisi, presso
Palermo come dipendente dell'abbazia benedettina di S. Martino
delle Scale . Nel 1772 si trasferisce a Palermo, dove nel 1787
gli viene affidata la cattedra di Chimica all'università; qui
raccoglie e pubblica, in cinque volumi, le sue
Poesie siciliane.
Nel 1798, quando la Corte si trasferisce da Napoli a Palermo,
l'abate Meli è già famoso scrittore. E’ ben voluto
dall’aristocrazia che lo accoglie nei suoi salotti e dal re che
gli assegna una pensione. (Tratto da Liber Liber, a cura
di Ruggero Volpes e Elio Franco Svettini).
Francesco Paolo Di Blasi (1753 – 1795). Intellettuale
palermitano, fu collaboratore dei
vicerè Caracciolo e Caramanico ma poi, nel 1795, fu
processato e decapitato in quanto promotore di una congiura
giacobina. Sotto tortura non fece il nome di alcun complice.
Aveva conosciuto nel 1773, il giovane Filangieri che si trovava
a Palermo in visita allo zio Serafino Filangieri, vescovo di
Palermo, che era
tanucciano e si muoveva
nel solco del riformismo risalente a
Carlo III.
Filangieri trova a Palermo un ambiente molto fervido intorno al
“Giornale dei letterati”, di cui faceva parte anche Francesco
Paolo Blasi.
Domenico Scinà, Prospetto della storia letteraria di Sicilia
nel secolo XVIII, Palermo,1827
Riportato in Fabio Pallavicini, Intorno ad alcuni passi del
codice arabo-siculo fatto pubblicare da msg. Airoldi,
Accademia delle scienze di Torino. Memorie.
|