|
Recentemente in una vendita del Web,
attraverso un noto sito di commercio on-line che dedica una sezione
specifica alla Numismatica, sono apparsi all’asta numerosi lotti costituiti
di conii fasulli per l’imitazione di svariate monete antiche o medioevali.
L’inquietante assortimento comprendeva coppie di conii di dritto e rovescio
per monete puniche siciliane, monete siracusane di periodo greco, monete
medioevali normanne, sveve ed aragonesi, etc.. Di questo contesto
tanto vasto quanto preoccupante considererò, in tal sede, solamente le
matrici atte alla fabbricazione dei falsi normanni proposti, nello specifico
più tipi di tarì di Ruggero I d’Altavilla (regnabat 1060 ca.-1101),
Conte di Calabria e Sicilia.
Il lotto sub judice (Fig. 1)
conteneva in particolare sette conii, in taluni casi con accoppiamenti per
dritto e per rovescio, finalizzati ad imitare certamente alcuni tarì aurei
siciliani di Ruggero I (in numero pari a cinque, secondo uno schema
Dritto-Rovescio, Dritto-Rovescio, Dritto-?, possibile un riutilizzo di uno
degli altri conii di rovescio – le ragioni saranno note a breve) ed un non
ben identificato tarì con accoppiamento Dritto-Rovescio (essendo l’immagine
di bassa risoluzione, non è ben chiara la coppia a quale tipo monetale si
riferisca, probabilmente trattasi di una imitazione rifacente alle tipologie
di tarì di Ruggero II, Re di Sicilia, battute tra il 1130 ed il 1140 nelle
zecche di Palermo e Messina e recante su di un lato la croce potente
cantonata da IC-XC-NI-KA). I tipi che si
riescono ad individuare attraverso le matrici, anche senza far riferimento
ad una impronta, sono rispettivamente Spahr p. 143 n. 27 (per certo almeno
il dritto), un tipo molto simile a Spahr p. 142 n. 14, ma relativamente
similare anche alla tipologia Spahr p. 142 n. 12 (per certo almeno il
dritto), infine il tarì classificato da Spahr a p. 141 n. 12, che per alcuni
aspetti ricorda anche il tipo di p. 143 n. 23 (ma con globetto in alto). In
Fig. 1, per facilitarne la visione, sono stati evidenziati i dritti
principali (D/) riconosciuti. Tutti questi tarì presentano al dritto il
tipico “Tau”, più o meno decorato ed attorniato da punti disposti in
maniera variegata, secondo schemi già noti e precedentemente indicati. In
questa breve nota sto considerando il lato della moneta recante la croce
come dritto, adeguandomi alla prassi cui si riferisce Lucia Travaini,
opposta a quella utilizzata in Grierson-Travaini, che solo in alcune
classificazioni discorda rispetto all’uso di Spahr. Bisogna essenzialmente
ricordare che il formalismo dell’identificazione del dritto, in questi casi,
risulta poco utile e di difficile attuazione, in quanto coesistono in questi
nummi entrambi i criteri di classificazione del lato (come dritto), sia
secondo la consuetudine in uso presso gli studi islamisti che presso quelli
filo-latini o filo-greci. Provo ad essere più chiaro: negli studi
numismatici islamisti il dritto è considerato solitamente quale lato della
moneta recante la Professione di Fede dell’Islam, invece la nostra
convenzione è quella di considerare come dritto il lato recante una
indicazione dell’autorità emittente. Ebbene nel caso delle serie monetali
che si stanno considerando, sono presenti diversi scenari che complicano la
classificazione, infatti se su un lato campeggia la croce e l’indicazione
del nome del sovrano (i.e. Ruggero I in cufico), mentre sull’altro lato vi è
la legenda costituita dalla Professione di Fede in cufico, altri tipi con la
croce invece risultano essere anonimi o non ben leggibili, presentando
comunque il Credo islamico sull’altro lato, oppure addirittura esistono
esemplari che da un lato recano la croce nel campo, dall’altro legenda
grande cufica nel campo a nome del sovrano. Ne consegue una concreta
difficoltà di scelta di un modello unico da seguire secondo i criteri
tradizionali.
Passiamo adesso alla descrizione
dettagliata dei tipi monetali riconosciuti dalle immagini dei conii. La
croce a forma di “Tau” assume fattezze diverse per ogni tipo
considerato, alcune volte molto sottile ed altre volte con spessore più
ampio, inoltre ai lati vengono rappresentati dei globetti, mentre in
posizione superiore rispetto all’elemento orizzontale della croce
campeggiano, secondo i casi, uno (Sp. nn. 12, 14) o tre punti (Sp. n. 27).
Intorno alla croce vi è disposta una legenda circolare cufica indicante il
nome del sovrano ed il titolo, anche se è da sottolineare che nella maggior
parte dei casi tale legenda è sfigurata o illeggibile perché fuori dal
tondello. Al rovescio invece vi è la legenda cufica disposta su tre righe
(ecco perché il riutilizzo del lato) che invoca Shahadah, ossia la
Professione di Fede islamica (“se non Allah … non c’è dio”) e la
Missione Profetica di Maometto (“Muhammad è l’inviato di dio”)
(Fig. 2). Il giro dei rovesci è sempre occupato da una legenda in caratteri
cufici recante, se leggibile, indicazione di zecca e data. In particolare la
produzione originale di tali tipi monetali che i conii intendono
contraffare, è da collocarsi nel periodo 1085/87-1101, ed attribuibile con
certezza alle zecche di Palermo ed Agrigento (secondo i tipi, i.e. cfr.
Travaini), possibilmente però anche quella di Messina.
Codeste emissioni di cui si tenta la
falsificazione, non risultano essere particolarmente rare, ma ciò non
significa che tali conii siano da sottovalutare. Il problema, o per meglio
dire la pericolosità principale, risiede nel fatto che l’eventuale
acquirente dei falsi possa scontrarsi con la non facile lettura delle parti
scritte a grafia cufica, solitamente ai più ostiche da interpretare rispetto
a monetazioni con alfabeti prossimi al nostro. Allora assume particolare
importanza ed utilità la possibilità di analisi dei dettagli della moneta
fasulla, che si sta ipotizzando possa essere stata prodotta a partire da una
delle coppie dei conii descritti. Anzitutto potrebbero essere decisive
all’identificazione del falso in oggetto, le forme dei caratteri arabi su
tre linee, visibili in negativo dalle immagini dei conii di rovescio, le
quali si presentano estremamente approssimative, quasi abbozzate,
rozzissime. Tutto ciò stride con la realtà e la tipicità delle emissioni
autentiche, che pressoché sempre, per ciò che concerne la Professione di
Fede islamica e la Missione Profetica, sono caratterizzate da una notevole
cura e precisione, ancor più se poi si fa riferimento alle incomplete e
sfigurate legende circolari apposte sui dritti e sui rovesci. Altro criterio
da tenere bene a mente è la possibilità di carpire se una eventuale
evanescenza dei caratteri del nummo sia dovuta al fatto che esso è sciupato
e logoro (il caso originale), oppure se la fenomenologia è da collegarsi ad
una azione artificiale umana (levigatura, ritocco con l’intento di
“simulazione dell’antico” con bulino oppure utensile o corpo dotato di
superficie abrasiva, che lasciano segni difficilmente colmabili a
perfezione) oppure ad una imprecisione di produzione (caratteri o parti
salienti mancanti, inesattezze di raffigurazioni, residui e scorie di
fabbricazione moderna). Inoltre un’altra spia della non genuinità della
moneta può essere la compattezza, la forma di aggregazione del supporto
metallico, che potrebbe tradire un’origine diversa da quella autentica.
A prima vista i conii sembrerebbero
essere stati realizzati in acciaio ed ottenuti probabilmente per fusione.
Quindi le monete false prodotte attraverso una coppia di queste matrici,
risulterebbero essere ottenute per coniazione con conii che a loro volta
sarebbero stati ottenuti appunto per fusione dagli originali. In tal caso
avremmo contorni sfumati e caratteri non netti rispetto agli originali.
L’evidenza di una risaputa produzione di
falsi per coniazione e non per fusione o presso-fusione, si conferma essere
un dato preoccupante. Più allarmante ancora è la competizione malsana
generata per accaparrarsi i lotti contenenti questi conii falsi!
Il venditore ha pubblicamente dichiarato
che i conii risalgono a circa venti anni fa, ma non posseggo mezzi per
poterlo stabilire con certezza. Quindi non è possibile escludere (anzi è
presumibile) che contraffazioni ottenute da almeno una delle coppie di conii
in esame, siano già state immesse nel mercato prima della vendita nel web.
Concludo la nota ricordando che i falsi
vanno anzitutto combattuti attraverso la conoscenza e la diffusione di tutti
gli strumenti informativi necessari alla loro identificazione. Questi
aspetti da soli però non bastano. Essi possono soltanto coadiuvare un
basilare ed intenso impegno personale nello studio dei dettagli utili
all’operazione di riconoscimento. Insomma è compito dello studioso
coscienzioso una convinta applicazione accompagnata, se possibile,
dall’acquisizione delle esperienze altrui, realizzando così una sorta di
sforzo collettivo ed istruendo le altre persone interessate (che magari
possono essere all’oscuro su temi di comune interesse). Quanto appena
scritto rappresenta la ragione per cui non ho inserito, nella presente nota,
alcuna immagine dei tipi monetali autentici che sarebbero oggetto di
falsificazione con i conii illustrati. Spero di stimolare il desiderio della
ricerca e della comparazione nel lettore, che dispone con la visione di
questo articolo, di qualche valido mezzo contro gli specifici falsi
ottenibili dai conii esaminati.
Comunque il più grande auspicio che la
comunità numismatica può esprimere sulla questione, è che vi sia
l’acquisizione dei conii seguita dalla distruzione immediata di essi.
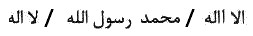 |
|
Fig. 2:
legenda araba del rovescio, ossia Shahadah (“se non Allah / Muhammad è
l’inviato di dio / non c’è dio”) |
Abbreviazioni presenti nel testo
-
Grierson P., Travaini L.,
Medieval European Coinage Vol. 14, Italy (III), South Italy, Sicily,
Sardinia, Cambridge, 1998.
-
Spahr R., Le monete
siciliane dai Bizantini a Carlo I d’Angiò (582-1282), Graz, 1976.
-
Travaini L., La monetazione
nell’Italia normanna, Roma, 1995.
Pubblicazione cartacea originale:
"Monete Antiche", 50 (2010), pp. 39-41
Pubblicazione on-line a cura del
Portale del Sud, settembre 2010 |


