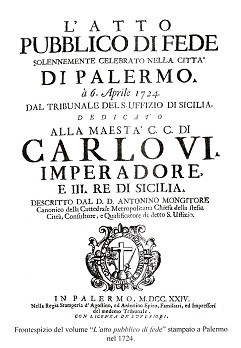|
Il 6 novembre del 1700 salì al
trono di Spagna Filippo V di Borbone, nipote di Luigi XIV di
Francia, come da disposizioni testamentarie del defunto re Carlo II
d'Asburgo. La successione fu però impugnata da Austria e
Inghilterra, che il 7 settembre 1701 costituirono all’Aia la Grande
Alleanza, proclamando re di Spagna Carlo d'Asburgo, secondogenito
dell'imperatore Leopoldo. Nella coalizione antifrancese entrò quindi
la Prussia di Federico I Hohenzollern. L’intento degli alleati era
quello di impedire un ulteriore rafforzamento del “Re Sole”. Ebbe
così inizio quella che sarebbe passata alla storia come la Guerra di
Successione Spagnola. Dopo alcuni iniziali successi francesi, la
guerra proseguì con alterne fortune. Nel 1703 anche il Portogallo
aderì alla Grande Alleanza ed il duca di Savoia Vittorio Amedeo II,
che fino ad allora era stato alleato della Francia, passò dalla
parte degli Austriaci.
Nel 1704 l’esercito francese fu
sconfitto a Hochstadt-Blenheim. Nello stesso anno la flotta inglese
occupò la rocca di Gibilterra e, l’anno successivo, Barcellona. Nel
1706 le truppe inglesi vinsero a Ramillies e occuparono le Fiandre
spagnole. I Francesi furono sconfitti a Torino e la stessa Madrid
venne occupata dagli alleati.
L’assedio di Torino del 1706
[1]
|
“Sebbene molti
ricordino l'episodio di Pietro Micca, che si sacrificò
per impedire l'ingresso del nemico francese all'interno
del perimetro cittadino, non altrettanto si può dire per
il contesto storico in cui avvenne il suo gesto eroico.
Eppure l'assedio di Torino dei franco-spagnoli
nell'estate del 1706 e la battaglia che vi pose fine il
7 settembre furono un evento non solo cruciale della
guerra di successione spagnola - scoppiata per impedire,
da parte di Austria, Inghilterra e Olanda, l'egemonia di
Luigi XIV sull'Europa - ma produssero effetti
fondamentali di grande portata nello sviluppo politico e
sociale di tutta la Penisola.
L'assedio della
città, che aveva già dovuto subire l'anno precedente un
analogo e inconcludente attacco delle forze di Luigi XIV,
era la conseguenza dell'ardito cambio di schieramento
attuato da Vittorio Amedeo II [1666 - 1732], il duca
artefice del rinnovamento politico, in senso
assolutistico-illuminato, ed economico dello Stato
sabaudo, che nel 1703 decise di contrapporsi al più
potente sovrano del continente. L'esercito transalpino,
sui vari fronti europei, raggiungeva all'epoca oltre
300.000 uomini, quello sabaudo era dieci volte
inferiore. Il rovesciamento di alleanze era una
scommessa rischiosa, ma il duca capiva di non avere
alternative se voleva svincolarsi da un ruolo di
vassallaggio nei confronti della Francia. Il duca, che
aveva l’ambizione di ingrandire i suoi domini e di
ottenere il sospirato titolo di “re”, aveva ben compreso
che non sarebbe mai riuscito a realizzare i suoi sogni
senza liberarsi prima dall’egemonia francese. Il piccolo
esercito del duca, che già dal 1690 al '96 si era
scontrato con i francesi, aveva subito dure sconfitte,
ma ne era uscito più efficace, numeroso, meglio armato e
organizzato e il duca aveva imparato a essere un
comandate esperto di logistica e tattica, che conosceva
ogni aspetto dell'amministrazione militare.
Quando si affiancherà
agli austriaci il Savoia dimostrerà, nei tre anni
successivi, la sua abilità strategica, guidando prima
una lunga campagna difensiva e attaccando poi
apertamente al momento giusto: nella battaglia decisiva
di cui oggi Torino celebra con giustificato orgoglio i
300 anni.
Occorre ricordare che
la città subì due assedi: storici e tradizioni popolari
hanno sempre concentrato l'attenzione sul secondo, ma
già nel 1705 il borioso duca di La Feuillade aveva visto
fallire il suo tentativo di conquista, mentre ferveva
sotto la città lo scavo di quel geniale dedalo di
gallerie e contro-mine che risulteranno fondamentali
nella vittoriosa difesa prima della battaglia decisiva
dell'anno successivo.
Cominciato l'assedio
fu introdotto in città del bestiame come scorta di carne
fresca e il fieno per nutrirlo; 10.000 uomini, con 130
cannoni e 24 mortai erano pronti a resistere a 40.000
soldati francesi e spagnoli, che apprestavano le linee
di assedio esterno, costantemente bersaglio di scorrerie
degli assediati. Dentro le mura tutta la popolazione
partecipò al consolidamento delle fortificazioni mentre
la famiglia del duca, portando con sé la Sindone,
abbandonava ai primi di giugno la città, poco prima che
venisse totalmente accerchiata. Il 17 il duca stesso -
dopo aver lasciato il comando al maresciallo austriaco
Daun - lascia la città con un distaccamento di
cavalleggeri, organizzando una sorta di guerriglia,
vanamente inseguito da La Feuillade, che spera di
guadagnarsi la gloria catturandolo.
L'obiettivo di
Vittorio Amedeo è di togliere energie agli assedianti -
che martellano costantemente la città con le artiglierie
- poiché sa che l'armata austriaca, guidata dal cugino
Eugenio di Savoia, sta arrivando dal Veneto in soccorso,
procedendo dalla sponda a sud del Po.
Quella di Eugenio è
una lotta contro il tempo che lo vede, a nell'arco di
due mesi, impadronirsi delle roccaforti nemiche,
eludendo al tempo stesso i tentativi francesi di
intercettarlo. Il 28 agosto Eugenio e Vittorio si
incontrano a Carmagnola. Nei tre giorni successivi gli
assedianti si sfibrano in vani assalti, sia attraverso
le gallerie che in attacchi alle mura, al punto che il
1° di settembre i francesi rinunciano a nuovi attacchi.
Il giorno dopo, sulla collina di Superga, il Duca e il
cugino studiano le linee francesi e preparano l'attacco,
decidendo di colpire nel punto più debole tra i fiumi
Dora e a Stura.
Giunge così l'alba
del 7 settembre. Le forze in campo ora si equivalgono,
coinvolgendo complessivamente oltre 80.000 soldati, ma i
francesi distolgono molti uomini per continuare il
bombardamento su Torino. Inizialmente gli attaccanti non
riescono a penetrare le trincee francesi, lo scontro è
il cruentissimo, finalmente cinque reggimenti del
Wurttemberg uniti ai prussiani riescono a irrompere
nelle linee francesi, mentre Vittorio Amedeo guida
un'epica carica di cavalleria che spezza il fianco
nemico vicino allo Stura. Le truppe francesi si
sfaldano, mentre piombano su di loro la guarnigione
della città e la milizia, che sfogano tutta la rabbia
vendicativa di quattro mesi di estenuante assedio. La
maggior parte dei franco-spagnoli sopravvissuti -
perderanno circa 6000 uomini - scappa verso Pinerolo,
altri fuggono a est, finendo annegati nel tentativo di
attraversare il Po. Oltre all'ingente bottino (tra cui
l'argenteria del fuggiasco La Feuillade ) numerosissimi
sono i prigionieri.
Poco dopo mezzogiorno
i primi liberatori entrano a Torino. A metà pomeriggio
il duca e il principe Eugenio assistono al Te Deum nella
cattedrale, partecipando poi a un banchetto con Daun e
lo stato maggiore, I soldati feriti o morenti vengono
ricoverati in affollatissimi conventi e ospedali, i
caduti risulteranno circa duemila, Il loro sacrificio e
quello di tutta la popolazione torinese aveva permesso
una clamorosa vittoria. L'indipendenza dello Stato
sabaudo è assicurata, il tentativo francese di dominare
l'Italia del nord sconfitto.
Ma il trionfo di
settembre fu molto di più. Fece della casa d'Asburgo la
potenza dominante della Penisola, con ambizioni
diametralmente opposte a quelle dei Savoia. Dopo la
battaglia crebbe l'appoggio diplomatico inglese al "fidatissimo
duca di Savoia", il cui coraggio in battaglia aveva
destato grande ammirazione, Alla fine tale sostegno
portò, dopo la pace di Utrecht, all'acquisizione del
titolo di Re di Sicilia”. |
La
controffensiva francese
 |
|
Luigi XIV |
Nel 1707 tutta l'Italia era in
mani austriache, ma i Francesi si ripresero sconfiggendo gli alleati
a Tolone e nella battaglia di Al Mansa in Spagna. Filippo V
riconquistò Madrid. L’anno successivo, però, i Francesi uscirono
sconfitti a Oudenarde e la flotta inglese si impadronì della
Sardegna, allora ancora possedimento spagnolo. Nel 1709 le truppe
franco-spagnole furono nuovamente sconfitte a Malplaquet e, l'anno
successivo, a Almenara in Spagna. Nonostante queste rovesci, Filippo
V il 10 dicembre 1710 riuscì a battere Carlo d’Asburgo nella
battaglia di Villaviciosa.
Il trattato di
Utrecht e la pace di Rastadt
Nel 1711 morì, l'imperatore
d’Austria Giuseppe I, e gli succedette lo stesso Carlo d'Asburgo
(Carlo VI). La Grande Alleanza vacillò, in quanto le motivazioni di
alcune potenze per appoggiare Carlo alla successione del trono
spagnolo si erano completamente ribaltate. L’Austria, se avesse
preso possesso anche della Spagna e delle sue colonie, sarebbe
tornata ad essere la potenza dei tempi di Carlo V, con conseguenze
devastanti sul piano dell'equilibrio internazionale. Nel 1712
vennero pertanto intavolati negoziati di pace nella città olandese
di Utrecht, conclusisi il 13 luglio del 1713. Il 6 marzo 1714, a
Rastadt venne concluso il trattato definitivo tra Francia ed Austria
e l’impero spagnolo subisce una drastica ripartizione, senza come è
d’uso tener conto delle persone che lo abitano. Intanto Filippo V,
aveva rinunciato ad ogni futura pretesa sulla corona di Francia. Con
il trattato di pace, venne riconosciuto re di Spagna. La Spagna a
sua volta cedeva all'Austria Le Fiandre, il regno di Napoli, di
Sicilia e la Sardegna, nonché il Ducato di Milano e lo Stato dei
Presidi in Toscana. La Spagna cedeva anche all'Inghilterra
Gibilterra e Maiorca. Con buona pace l’Italia, dopo Utrecht e Rastadt,
passa dalla dipendenza spagnola a quella austriaca, tranne la
Sicilia che finisce nelle mani, o meglio sulla testa del duca
Vittorio Amedeo di Savoia.
Il duca Vittorio Amedeo II di
Savoia non solo ottenne la Sicilia con il relativo titolo regio, ma
anche Casale e tutto il Monferrato, parte della Lomellina e l'Alta
Valle di Susa con Chisone e Varaita (in seguito otterranno anche la
Valsesia).
La Sicilia
sabauda
 |
|
Vittorio Amedeo II di Savoia |
Nel trattato di Utrecht, il Regno
di Sicilia veniva formalmente concesso dalla Spagna in feudo ai
Savoia, che pertanto non potevano scambiarlo o cederlo.
All’estinguersi del ramo maschile dei Savoia, esso sarebbe tornato
alla Spagna.
Il 3 ottobre 1713 il nuovo re
salpò da Nizza alla volta di Palermo, dove venne solennemente
incoronato re la notte di Natale nella Cattedrale di Palermo. In un
suo discorso al parlamento siciliano, il nuovo re dichiarò: «I
nostri pensieri non sono rivolti ad altro che a cercare di
avvantaggiare questo Regno per rimetterlo, secondo la Grazia di Dio,
al progresso dei tempi, riportarlo al suo antico lustro e a quello
stato cui dovrebbe aspirare per la fecondità del suolo, per la
felicità del clima, per la qualità degli abitanti e per l'importanza
della sua situazione.»
Vennero infatti presi
provvedimenti per contrastare il brigantaggio, dare fiato alle
attività mercantili, risanare le finanze e riorganizzare l'esercito.
Vittorio Amedeo cercò di fare del suo meglio: pur essendo un fautore
convinto dell’assolutismo non mise mai in discussione il (pur
discutibile) parlamento siciliano, introdusse nell’isola sistemi di
gestione finanziaria e politica diversi da quelli spagnoli,
eliminando le frodi doganali e rendendo efficaci le leggi di
pubblica sicurezza che responsabilizzavano i baroni per i delitti
commessi nelle loro terre, e obbligando i baroni a pagare i debiti.
Ma quando si tratta di pagare si viene considerati “necessariamente”
cattivi ed il “povero” Savoia passò alla storia come fosse stato una
sanguisuga. In realtà il sabaudo si mostrava più vicino alla Francia
illuminista che alla Spagna o all’Austria. Ma rimase troppo poco
tempo e in questo tempo fu costretto ad affrontare, o meglio
continuare, una guerra con la Santa Sede. Una guerra “ridicola”,
perché non scoppiata per “grandi temi” ma semplicemente per una
tassa da pagare su un pugno di ceci! (La
controversia liparitana).
Lo sconquasso determinato dalla
diatriba su un pugno di ceci fu enorme e comportò scomuniche e
controscomuniche per l’isola (ricordo che una scomunica allora
equivaleva ad un embargo, con tutte le relative conseguenze).
La permanenza del re in Sicilia
durò fino al 7 settembre 1714, quando ripartì carico di beni e
soprattutto accompagnato da uomini di cultura, come l'architetto
Filippo Juvara e i giureconsulti Francesco D’Aguirre e Niccolò
Pensabene. Lasciò come viceré il conte Annibale Maffei (seguito in
tale incarico nel 1718 da Giovanni Francesco di Bette marchese di
Lede e nel 1719 da Niccolò Pignatelli duca di Monteleone).
Francia, Olanda, Inghilterra e
Austria avevano intanto dato vita alla Quadruplice Alleanza, e
Vittorio Amedeo II fu invitato segretamente – era feudatario della
Spagna! - a prenderne parte dal cardinale Giulio Alberoni (1664 -
1752), statista al servizio di Filippo V.
 | |
Giulio Alberoni |
La Spagna, non fidandosi del
Savoia, giocò d’anticipo ed invase la Sicilia con un esercito di
30.000 soldati. Quando l’Austria propose a Vittorio Amedeo II la
Sardegna in cambio della cessione della Sicilia, il Savoia accettò
ed entrò nella Quadruplice. Nel 1718 venne incoronato Re di
Sardegna, confermandosi così astuto uomo politico. Era riuscito a
ottenere e mantenere per il suo casato la sospirata corona regale e
si era dimostrato ampiamente valoroso e audace soldato. Non poteva
però definirsi uomo di parola.
Gli Austriaci
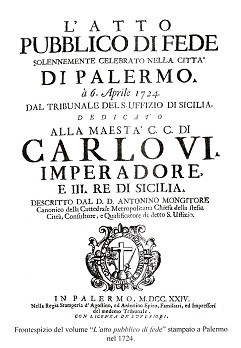 |
|
Mongitore, L’atto pubblico di fede
solennemente celebrato dal Tribunale del S. Uffizio di Sicilia a
6 aprile 1724 (frontespizio) |
Il passaggio della Sicilia dal
possesso sabaudo a quello austriaco, nonostante l’accordo sulla carta
tra le parti interessate, non fu facile. Tra il 1718 e il
1720 infuriò la guerra tra Austriaci e Spagnoli per la conquista
della Sicilia. La guerra fu sanguinosa e fu la prima in territorio
siciliano dopo il tempo dei
Martini. Il conflitto si concluse con il
trattato dell'AIA del 1720: Carlo VI d'Austria, già re di Napoli,
diventava anche il nuovo re di Sicilia, con il numerale "3°"
[3]. Il duca di Monteleone fu
confermato viceré.
Il dominio austriaco durò 14
anni. Carlo VI si limitò ad una semplice gestione amministrativa ma
per non inimicarsi la Spagna, alla cui corona aspirava, mantenne
l’Inquisizione (cosa che del resto aveva fatto anche il sabaudo!
Quando c’è da guadagnare non si guarda in faccia nessuno!) e non
solo ma istituì anche una Inquisizione generale a Vienna con
autorità solo sulla Sicilia! Istituzione che ben si è distinta dando
via libera al braccio secolare per le esecuzioni che da tempo erano
in sospeso
[2].
La congiura di
Macchia
Cosa era intanto successo nel
regno di Napoli? Alla morte di Carlo II di Spagna, nel 1701 alcuni nobili
napoletani, con a capo il principe di Macchia, si misero in contatto
con l'Austria sperando di potersi finalmente liberare della
dominazione spagnola, ma la congiura fallì ed il viceré proclamò
nuovo re di Napoli Filippo V di Spagna (IV di Napoli). A seguito del
trionfo delle armi austriache del 1707, l’esercito imperiale occupò
Napoli, dove fu insediato un viceré austriaco. Carlo VI d'Austria fu
quindi anche re di Napoli (il sesto re di Napoli con questo nome).
Il dominio austriaco terminò col viceré conte delle Pieve Giulio
Visconti nel 1734, come conseguenza della guerra per la successione di
Polonia.
 |
|
Carlo di Borbone
|
Dopo il breve dominio austriaco,
per i regni di Sicilia e di Napoli inizia un periodo di
indipendenza, in mano ad un re “italiano” (si fa per dire). Infatti
Carlo di Borbone, duca di Parma e figlio di Filippo V di Spagna
e di Elisabetta Farnese, profittando della guerra di successione
polacca, che impegnava militarmente l’Austria, riconquista, con il
sostegno spagnolo, i due regni.
Il ritorno apparente ad un regno
di Sicilia di tipo normanno o federiciano è pura nostalgia. Ormai
esistono due regni di Sicilia, entrambi strenui difensori della loro
autonomia e sempre l’un contro l’altro armati fino
all’autodistruzione!
Fara Misuraca
Alfonso Grasso
settembre 2006
Bibliografia
-
Gleijeses Vittorio, La guida storica artistica
monumentale turistica della città di Napoli e dei suoi dintorni,
Società Editrice Napoletana S.r.l., 1979
-
Gleijeses Vittorio, La Storia di Napoli, Società
Editrice Napoletana, 1977
-
Symcox Geoffrey, articolo “Torino, dall'assedio
alla gloria”, Il Secolo XIX,
7
settembre 2006, (traduzione di Gianluca Trivero)
-
Cuoco Vincenzo
Saggio storico sulla rivoluzione
napoletana del 1799
-
Giarrizzo Giuseppe, La Sicilia dal Cinquecento
all’unità d’Italia in Storia della Sicilia, VII
-
Renda Francesco, Storia della Sicilia dalle
origini ai giorni nostri, Sellerio editore Palermo 2003
-
Scarcella Gaspare, L’Inquisizione in Sicilia, Antares Editrice, Palermo, 2001
|