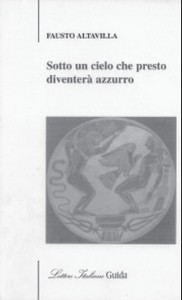|
Dalla
prefazione di Domenico De Masi
La lettura
del bel libro di Fausto Altavilla è per me inquietante. Prima di tutto
perché è pervaso di religiosità. Io, invece, sono profondamente laico:
credo che non sia stato Dio a creare l’uomo, ma siamo stati noi uomini a
inventarci Dio e il suo paradiso per dare corpo alle nostre umane
illusioni, per sperare in qualcosa di immortale, essendo noi mortali; a
qualcosa di giusto, essendo ingiusto il mondo da noi costruito; a
qualcosa di bello, essendo spesso bruttissimo tutto ciò che ci circonda.
La seconda
cosa che mi differenzia dalle tesi di Altavilla è il suo rimpianto per
il mondo contadino, che io invece reputo felicemente e definitivamente
accantonato. Semplicità, bontà, saggezza, felicità, tutti valori che
vengono generalmente attribuiti alla comunità rurale, a me paiono assai
più presenti nella società postindustriale. La vita contadina era
brutale, spietata, bigotta, onnivora. Schiava della tradizione, della
scarsità, dell’emotività, dell’ignoranza. Non che l’attuale vita
cittadina sia il migliore dei mondi possibili, ma certamente è il
migliore dei mondi esistiti finora.
Ciò che
invece mi accomuna alle idee di Altavilla è l’attenzione per il nostro
Mezzogiorno e l’incapacità di spiegarne i paradossi. La nostra terra è
al centro del pianeta: nel crocevia tra il nord e il sud, tra l’est e
l’ovest. Ha un clima invidiabile. Ha un patrimonio storico e artistico
tra i più densi del mondo. Eppure il suo reddito pro-capite è la metà di
quello piemontese o lombardo. Perché? Non lo sappiamo.
Nitti ha dato
la sua spiegazione politica, Salvemini la sua spiegazione geografica,
Gramsci la sua spiegazione classista, De Martino la sua spiegazione
antropologica. Ma, tutte insieme, queste spiegazioni non riescono a
rendere conto dell’autolesionismo, della bellicosità, della fatuità
meridionali: di questa nostra incapacità ad elevarci sopra tutto ciò che
è effimero, mediocre, caotico.
Secondo
Pasquale Turiello (Governo e governati in Italia del 1882), il nostro
sottosviluppo economico e civile dipende dalla “scioltezza eccessiva
degli individui (...) radice unica di più disordini che appariscono in
forme e colori diversi”. E il termine “scioltezza” significa mancanza di
legami, di leggi, di nomos tra i cittadini; equivale cioè proprio a quel
concetto di anomìa che ha fatto la fortuna di Durkheim. Ne consegue che
“individui così naturalmente e socialmente disciolti pregiano più le
virtù solitarie che le civili e, tra queste, più quelle in cui si
patiscono cose forti che quelle in cui si operi fortemente”.
Una nazione
di individualisti vive nel vuoto anarcoide di tutte le istituzioni,
tranne una: la famiglia. Ed ecco anticipata, così, l'altra famosa tesi –
quella di Banfield – secondo cui ciascuno, nel profondo Sud, agisce in
vista del bene immediato e materiale proprio e del proprio ristretto
nucleo familiare dando per scontato che anche gli altri facciano
altrettanto. “Dalla lotta viva tra gli individui così mobili ed
esuberanti – scrive Turiello – fuori della famiglia nasce la diffidenza,
in ogni convegno, in ogni società pubblica. L'ordine singolare che li fa
egregi negli scontri di uomo contro uomo, come è rilevato da chiunque li
conosca, cessa nel Napoletano quando gli bisogni procedere associato
(...) Onde è che, fuori della famiglia, non trovi quasi altri legami
morali”.
Come dargli
torto?
L’altra tesi,
quella sostenuta da Pasquale Villari, vuole dimostrare che il carattere
dei cittadini non è che l'occasione prossima dei mali meridionali
perché, a loro volta, essi discendono da cause storiche e strutturali, e
perché esiste un continuo rapporto di causa-effetto tra la struttura e
la cultura di un sistema sociale. “Al prof. Turiello – scrive Villari –
sembra che la camorra sia conseguenza come in parte anche il
brigantaggio, della ‘scioltezza’ e ‘indisciplina dell'individuo
italiano’ che è ancor più sciolto e indisciplinato nel Napoletano. Noi
cercammo invece di provare che la causa principalissima della camorra è
la grande miseria, il grande avvilimento di una parte della plebe
napoletana”.
Come dargli
torto?
Discuteremo
per sempre se è nato prima l’uovo del carattere e dell’antropologia
meridionale o la gallina della sua condizione strutturale. Resta il
fatto che entrambi cospirano contro lo sviluppo e il progresso,
levantinamente lenti nel Sud.
In un suo
studio insuperabile su Napoli e la questione meridionale, Nitti
individua (siamo nel 1903) quattro punti dolenti, che restano tuttora
cruciali: la depressione economica, per cui il PIL della città è
decisamente inferiore a quello di Roma o di Milano; la debolezza
finanziaria per cui le banche e la borsa di Napoli sono ridotte a una
funzione gregaria rispetto a quelle di altre piazze; la patologia dei
rapporti sociali, per cui la solidarietà e la vivacità descritte da
Goethe sono ormai degenerate in diffidenza, malumore ed aggressività; la
vita pubblica avvelenata dal disimpegno politico, dalla rissosità
amministrativa, dalla carenza di progettualità, da ritardi operativi,
dall’asservimento della sfera pubblica da parte dei politici
faccendieri, degli speculatori economici, della criminalità associata.
Il libro
inizia così: “Napoli, la grande città che era ancora qualche secolo fa
la seconda in Europa per popolazione, che nel 1860 soverchiava per
importanza tutte le città italiane; Napoli, la città che Sella chiamava
‘cospicua’ e che aveva almeno fino a poco tempo fa alcune apparenze di
ricchezza, Napoli muore lentamente sulle sponde del Tirreno. Tra tanto
cielo e tanto mare, tutto un grande dramma umano si svolge”. E così
finisce: “Quando a Napoli io vedo questi volti di operai che la povertà
ha reso anemici, questa immensa turba che vorrebbe lavorare e non può,
io sento che l’anima mi dice di osare: di osare contro l’ignoranza che
avvelena e contro il pregiudizio che uccide”.
A
ripercorrere le vicende del secolo che ci separa dal libro di Francesco
Saverio Nitti, si ha l’impressione che, pur nel progresso generale,
Napoli abbia ulteriormente perso terreno rispetto a Milano e Roma e che,
se non si ridesta, rischia di perdere il treno postindustriale così
come, all’epoca di Nitti, perse quello industriale. Forse allora vi
erano gli uomini necessari ma le circostanze erano avverse; oggi le
circostanze sono favorevoli però mancano gli uomini capaci di coglierle:
non solo in campo politico ma anche in campo economico.
Perché, a mio
avviso, le attuali circostanze generali sarebbero favorevoli allo
sviluppo del Mezzogiorno? Perché, dopo aver perso per ben tre volte il
treno dell’industrializzazione, un nuovo treno epocale passa accanto a
Napoli e al Sud: il treno della società postindustriale. E il Sud
rischia di non accorgersene, tanto più che, questa volta, non c’è un
‘Nitti del Duemila’ capace di pungolare il Governo centrale e quello
locale con un’analisi altrettanto inoppugnabile di quella elaborata dal
‘Nitti del Novecento’.
Ma cosa è
questa società postindustriale? Non è soltanto una nuova struttura
economica, né soltanto un nuovo ordinamento sociale o una cultura
inedita, o un nuovo complesso di miti e di valori, o un'economia basata
su nuovi fondamentali, o una forma di neo-capitalismo, o una nuova
antropologia, o una nuova inclinazione psicologica delle masse. È tutte
queste cose messe assieme, ed altro ancora.
Dopo soli due
secoli dall’avvento della società industriale, e con un'irruenza assai
più tumultuosa, nella seconda metà del Novecento è arrivata una nuova
ondata di novità tecnologiche, politiche, culturali. Con la nascente
società, che per comodità chiamo “postindustriale”, si sono diffuse una
nuova struttura e una nuova cultura, poco decifrabili in un primo
momento ma poi via via sempre più chiare ed egemoni.
Alcuni tratti
di questa nuova società sono ormai ben noti: nella società
postindustriale la produzione di servizi prevale sulla produzione di
beni materiali; la classe professionale e tecnica prevale su quella
esecutiva; la conoscenza teorica precede l'esperienza empirica; le
“tecnologie intellettuali” di tipo digitale prevalgono su quelle
tradizionali di tipo analogico.
Nella società
postindustriale una serie di fenomeni, che vanno dall'informatizzazione
alla robotizzazione, dalla manipolazione genetica alla prevalenza
dell'invenzione sulla scoperta, investono l’individuo, la famiglia, il
lavoro; ristrutturano il tempo e lo spazio, demassificano la cultura;
rimodellano il rapporto tra individuo, gruppi, movimenti, istituzioni,
collettività. La posta in gioco non consiste più nell’appropriazione del
plusvalore economico ma nella capacità di programmare il futuro e
imporre la propria programmazione a tutti gli altri.
Il mercato
internazionale del lavoro va assumendo un nuovo assetto basato sulla
divisione dei Paesi in tre blocchi: da una parte le nazioni che
coltivano, attirano, monopolizzano le intelligenze per produrre brevetti
tramite la ricerca scientifica e per produrre arte tramite la ricerca
estetica. Dall'altra le nazioni costrette a tradurre i brevetti in beni
e servizi tramite le fabbriche manifatturiere che ormai rendono poco
economicamente e inquinano molto ecologicamente. Infine, i Paesi
condannati a fornire sottocosto le braccia, le materie prime, le basi
militari e la subordinazione politica in cambio della sopravvivenza e,
nel migliore dei casi, in cambio di una lentissima espansione dei propri
consumi.
Nella società
industriale la leadership toccava ai paesi in possesso delle materie
prime e dei mezzi di produzione; nella società postindustriale la
leadership tocca ai paesi in possesso della materia grigia, dei
laboratori scientifici, delle banche-dati, dei provider, dei centri di
produzione cinematografica e televisiva. Insomma, della creatività ben
coltivata.
All’inizio
del Novecento Nitti rimproverava Napoli per essersi ridotta a consumare
acciaio e macchine comprate altrove senza produrle, incapace di cogliere
l’occasione epocale della nascente industria. All’inizio del Duemila è
possibile rimproverare Napoli e il Mezzogiorno di essersi ridotti a
consumare non solo merci, ma anche saperi, linguaggi, informazioni,
valori, simboli, estetiche importate dall’esterno, incapaci di produrne
autonomamente sfruttando l’occasione epocale dell’avvento
postindustriale. Per produrre nella Napoli di cento anni fa i beni
materiali occorreva l’Ilva; per produrre nella Napoli attuale i beni
immateriali occorrono università, laboratori di ricerca, atelier,
business school, centri di creatività scientifica ed estetica, parchi
tecnologici, strutture per il tempo libero, per il turismo, per il
benessere globale. Agli inizi del Novecento, eccetto le poche industrie
pubbliche, c’era qualche concia di pelle, qualche piccola fabbrica
chimica e poche altre imprese del genere. Agli inizi del Duemila,
eccetto i laboratori universitari quasi sempre obsoleti, le imprese di
Pistorio, di Perna e di Ercolino, ci sono pochissimi altri nuclei di
ricerca scientifica, gastronomica, estetica.
Da alcuni
decenni, in tutti i paesi avanzati, si assiste a uno spostamento sempre
più accelerato del baricentro del mercato del lavoro. Gli esuberi
dell’agricoltura, dove i contadini furono sostituiti dai trattori
automatici e dai concimi chimici, si spostarono nell’industria. Poi gli
esuberi dell’industria, dove gli operai e buona parte degli impiegati
furono sostituiti dall’automazione e dall’elettronica, si spostarono nel
commercio e nei servizi tradizionali. Poi gli esuberi dei servizi, dove
i commessi, gli impiegati e i piccoli esercizi furono sostituiti dai
distributori automatici (si pensi al bancomat) e dai supermercati (ogni
shopping center, per un posto di lavoro che crea, sette ne distrugge),
si spostarono nei call center, nella manutenzione e nella gestione delle
ICT. Da ultimo gli esuberi delle ICT, dove l’automazione, il telelavoro,
la concorrenza dell’India e di altri paesi emergenti sono riusciti a
svuotare persino la Cisco nella Silicon Valley e la Kodak a Boston,
tentano di riconvertirsi all’industria del benessere globale: cliniche,
palestre, turismo, festival, cultura, sport, intrattenimento, formazione
permanente, moda, design, architettura d’interni e di giardini,
arredamento, eno-gastronomia, estetica e manutenzione del corpo,
arricchimento dello spirito.
Se
l’industria ridisegnò la geografia economica svuotando i paesi di
montagna, installando stabilimenti siderurgici in paradisi naturali come
Bagnoli, tracciando ferrovie e autostrade, mettendo in secondo piano
l’estetica, la soggettività, l’emotività rispetto alla pratica,
all’organizzazione, alla razionalità; la società postindustriale sta
disegnando una nuova mappa del pianeta in cui le capitali del lavoro –
da Detroit a Torino – cedono il passo alle capitali della cultura,
dell’intrattenimento, del sapere, della bellezza, del gioco, dell’ozio
creativo dove i talenti inclinano a trasferirsi e dove sono meglio
coltivate l’accoglienza, la tolleranza, la sensualità, l’allegria,
l’interclassismo, la creatività, la flessibilità, l’estroversione, la
socievolezza, la donazione di senso, la tranquillità, la convivialità,
il rispetto della privacy.
Per ben tre
volte Napoli e il Mezzogiorno hanno tentato, senza riuscirci, di
diventare un grande polo industriale. Ci sono oggettive possibilità che
essi diventino oggi un grande polo postindustriale?
Ai tempi di
Nitti le condizioni erano talmente diverse da quelle attuali che mai il
grande sociologo lucano avrebbe potuto pensare al benessere come
prodotto da creare e da vendere. In quegli anni il futuro era
l’industria. Ma oggi siamo in tutt’altra situazione e Nitti, se dovesse
riscrivere Napoli e la questione meridionale, certo non punterebbe più
sull’industria pesante ma prenderebbe in più seria considerazione,
accanto a tutte le attività intangibili, anche quelle che riguardano la
qualità della vita, non escluso il turismo.
Infatti, un
fantasma si aggira per il mondo: il fantasma del tempo libero. Mentre un
numero sempre più esiguo di forzati della fatica, soprattutto manager,
si chiude in difesa delle proprie dieci ore di lavoro al giorno, e se le
tiene strette, senza cederne ai disoccupati neppure una briciola; mentre
questi forzati della fatica coltivano con tenace sollecitudine il mito
del lavoratore indefesso, tutto ufficio e azienda, sul cui vessillo è
scritto a caratteri d'oro il motto "lavoro, guadagno, pago, pretendo";
mentre questi forzati della fatica puntano tutto sulla competitività,
sulla lotta per il potere, sull'incremento di valore della propria
azienda, cioè sull'arricchimento dei loro padroni; una massa crescente
di beneinformati ha preso coscienza che la vita nei paesi ricchi è
sempre più fondata sul tempo libero, sullo svago, sull'ozio, sulla
valorizzazione delle vacanze proprie molto più che sulla pianificazione
delle vendite e degli investimenti altrui.
Siamo alle
soglie di una società oziosa, il cui solo pensiero manda in bestia i
forzati della fatica, i masochisti del dovere operoso, nevroticamente
dediti alle loro riunioni di lavoro, alle loro trasferte di lavoro, alle
loro colazioni di lavoro.
Ma oggi, se
andiamo al sodo, che cosa fa girare l'economia? quale settore tiene il
primato nella determinazione della ricchezza nazionale? quale ramo
assicura agli azionisti il giro d'affari più redditizio? Forse
l'industria siderurgica? o quella bellica? o quella automobilistica? o
quella elettronica? o i servizi finanziari? Nossignori: ormai il banco è
tenuto dall'industria del cosiddetto "entertainment": lo svago,
l'intrattenimento, il tempo libero, l'ozio!
Se ormai la
maggior parte della nostra vita, a dispetto dei forzati del lavoro, è
fatta di tempo libero, occorre prepararsi a capitalizzare l'ozio, ora
che la civiltà di riferimento non è più la Seattle di Bill Gates, dove
la corsa al successo produce una società squilibrata e infelice, ma
l'Atene di Pericle, dove l'ozio creativo consentiva equilibrio e
bellezza. Sotto questo aspetto, la Bahia di Caetano Veloso può insegnare
assai più del Veneto di Benetton.
E il
Mezzogiorno, se finalmente consapevole delle sue qualità e libero dei
suoi difetti, potrebbe vantaggiosamente collocarsi tra Atene e Bahia.
Su questo, ne
sono certo, anche Fausto Altavilla è d’accordo con me.
Domenico De Masi |